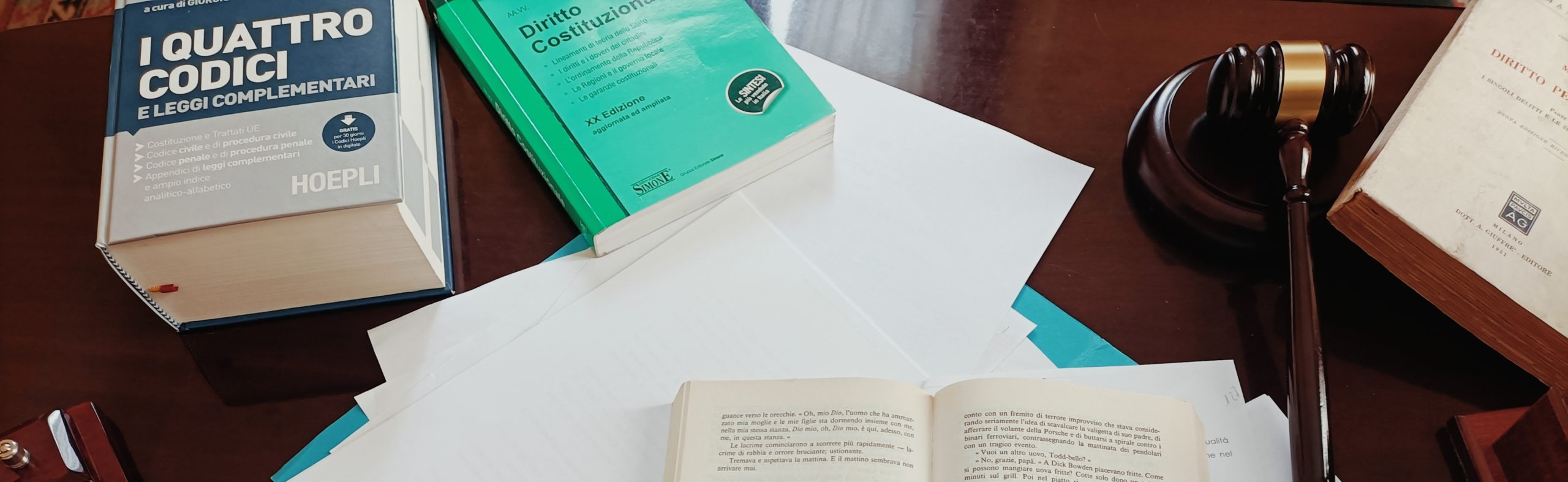Diritto Penale
La libertà
Ero nello studio legale Goggi da meno di un anno, quando Paola decise di rivoluzionare la sua attività professionale.
Era parecchio tempo che si lamentava del fatto che i nostri clienti pagassero poco e pretendessero troppo, scrivendo e telefonando ogni giorno per avere aggiornamenti sulle pratiche.
La notizia mi fu data in un tardo pomeriggio d’autunno, quando Paola mi convocò nella sua stanza. Aveva dipinta in volto l’aria austera degli annunci ufficiali. Mi fissò negli occhi per più di un minuto, prima di parlare.
«Ale, non ne posso più di come stanno andando le cose qui dentro. Non ne posso più di buona parte dei nostri clienti».
Ero d’accordo, ma non intravedevo soluzioni al problema. «Okay. E quindi?».
«Quindi ho deciso di cambiare, di svoltare proprio. Ci vuole un’autentica rivoluzione in questo studio!».
Un brivido di inquietudine e di speranza al tempo stesso mi percorse la schiena, come una scossa di adrenalina. Coltivai in un istante il sogno/incubo che Paola volesse lasciare a me la guida dello studio. Ciò avrebbe significato responsabilità a mille ma anche un bel po’ di soldi in più, e di soldi me ne servivano tanti per soddisfare i desideri di Claudia.
Un attimo dopo, però, il mio pessimismo cosmico, frutto di tante sconfitte esistenziali, prese il sopravvento ed io temetti addirittura che la mia capa mi stesse mettendo alla porta. Ancora oggi mi chiedo come fossero possibili tanti pensieri dentro la mia testa in quelle poche decine di secondi di silenzio.
«Ho deciso di dare un’impronta sociale al nostro studio».
«E cioè?». Ero tutto orecchi, anche perché la parola “nostro” incoraggiava qualche aspettativa.
«Ho stipulato una convenzione con il convento dei frati, qui vicino. Ci occuperemo dei loro ospiti, tutta gente in difficoltà, col patrocinio a spese dello stato ovviamente. Hanno uno sportello assistenziale che raccoglie centinaia di richieste di aiuto».
«Una convenzione col convento?». Ero terrorizzato dal sospetto che Paola fosse impazzita, magari in preda ad una crisi mistica.
«Proprio così. Si tratterà di donne maltrattate o abbandonate, di migranti alla ricerca di protezione internazionale, di gente sul lastrico, di vittime di soprusi d’ogni tipo».
“E’ proprio impazzita”. Pensai con sbigottimento ed il viso appuntito e lo sguardo da serpente di zio Arturo mi fecero provare qualcosa di assai simile alla nostalgia e persino al rimpianto.
Paola era inarrestabile. «Hanno aperto, su mio suggerimento uno sportello legale, il venerdì pomeriggio. E sai chi è adatto a parlare con quei poveretti?».
«Chi?».
«Tu!».
«Io?». Ero certo di avere capito bene, ma era come se invocassi i tempi supplementari. “Certo” protestai in silenzio “io sono adatto ai poveretti. Bella promozione, dopo un anno di assidua collaborazione, di Bortolo Floris De Rinaldis e di tutto il resto…!”
«Certo. Tu sei paziente, sensibile, sai ascoltare. Ci andrai tu, un pomeriggio alla settimana, sempre di venerdì!».
Eccolo, l’ennesimo ordine. Il mio destino era quello di sentirmi dire per tutta la vita che cosa avrei dovuto fare. Rimpiansi Bortolo Floris De Rinaldis e tutti gli altri logorroici ed ossessivo compulsivi clienti, che Paola mi aveva rifilato per l’infinita stima che aveva di me. Seppi di non avere scelta e provai ad ingoiare l’amarezza. «E quando dovrei cominciare?».
Il suo sguardo divenne gelido. «Da questo venerdì, alle quindici. Si sono già prenotate sei persone. Almeno quattro hanno bisogno di tutela penale, la tua specialità. Dovrai essere puntuale e non potrai dedicare più di mezz’ora a ciascuno di loro. Alle sei sarai libero e non dovrai tornare in studio. Potrai prenderti un aperitivo con gli amici, se lo vorrai!».
Notando la mia perplessità, lei si piegò verso di me, con occhi comprensivi. «Vedrai che questa esperienza ti arricchirà personalmente e professionalmente e si rivelerà una fonte di guadagno per entrambi».
“Come no…il business dei rifiutati dal mondo…potrò comprarmi una macchina nuova…la parola arricchimento mi sembra davvero una presa per i fondelli” pensai con amarezza.
Mi sollevai dalla sedia schiacciato da un senso di impotenza, di rassegnazione al corso di eventi che non potevo in alcun modo governare. Sperai che il tempo rallentasse il suo affannoso fluire e che la strada verso il venerdì diventasse tutta in salita.
Quando mi presentai per la prima volta al portone del convento, fui preso da un istante di smarrimento totale. Gli occhi dolenti di un gigantesco crocefisso ligneo mi trafissero, come la punta di una spada.
Quel silenzio mistico mi sovrastava, facendomi sentire molto più piccolo del mio metro e settantaquattro e dei miei ventotto anni.
Un uomo calvo, stretto in un saio, mi accolse qualche metro più avanti. I suoi occhi piccoli e determinati mi sottoposero ad un severo scrutinio.
«Buongiorno, sono Fra Giacomo».
«Buongiorno, avvocato Alessio Mayer».
«Mi aspettavo l’avvocato Paola». Sembrava deluso e sospettoso.
«L’avvocato Paola la saluta. Ha mandato me. Faccio parte del suo studio».
Il suo sguardo divenne ancor più inquisitore. «Mi scusi, ma lei è credente?».
Quella domanda mi colse alla sprovvista e scoperchiò, nella mia testa, un autentico abisso di possibilità confuse. “Sono credente?”. Mi domandai. “E se sì, in cosa esattamente? In Dio, nella giustizia o in entrambi?”.
Ero in un vicolo cieco ed innestai il pilota automatico. «Certo, sono credente». In verità non mettevo piede in una chiesa da oltre sei anni, neppure a Natale. Eppure la sera qualche volta pregavo, con parole mie, e quando mi trovavo in difficoltà nel compiere una scelta provavo a dare del tu a Dio.
La successiva domanda del frate, se possibile, fu ancor più surreale e di certo superiore alle mie poche risorse intellettuali. «Lei ritiene che la professione di avvocato sia una missione?».
Se avessi dovuto seguire l’istinto gli avrei urlato in faccia che la mia missione era ubbidire a chi mi dava lavoro, ma riuscii a trattenermi, avendo imparato che l’istinto spesso diventa una pistola alla tua stessa tempia. Provai invece a misurare le parole. «Credo che la missione dell’avvocato sia dare il massimo per il cliente, senza chiedere denaro più del giusto».
Il religioso annuì e sembrò convinto. «Le chiedo di recitare assieme a me un padre nostro».
Fui colto dal panico: ricordavo le esatte parole? “Ma da quando per fare l’avvocato e sbarcare il lunario bisogna conoscere il padre nostro?”. Ero risentito ed anche un po’ umiliato.
Con mia sorpresa ce la feci a star dietro a Fra Giacomo da “Padre nostro che sei nei cieli…” all’ “amen”, che accolsi come il fischio finale dell’arbitro quando sei in vantaggio.
Finalmente l’inquisizione ebbe termine ed il frate mi invitò a salire su per una ripida scala.
Dietro ad una porta a vetri mi attendeva il primo cliente. Si chiamava Salvatore Lorusso, aveva ventisei anni ed era senza fissa dimora. La sua pelle, almeno nella parte visibile, era tappezzata di tatuaggi. Ne aveva addirittura due sul collo, uno per lato. I suoi capelli, svettanti come guglie, erano simili alla cresta impazzita di un gallo. Al di là dello sguardo triste, non sembrava proprio un tipo da convento.
Stringeva tra le dita un rotolo di carte, che lo pregai di consegnarmi. Si trattava di un ordine di esecuzione di pena detentiva: un biglietto di viaggio di sola andata per le patrie galere. Lessi con attenzione quei sette fogli e vidi che il tipo era stato condannato per ben quindici volte, sempre per furti o ricettazioni. La procura della Repubblica di Milano aveva fatto quello che si chiama “cumulo delle pene” (1) e gli restavano da scontare tre anni e dieci mesi.
«Tre anni e dieci mesi per qualche furtarello? E a chi stupra le ragazze?!». Mi chiese, corrugando la fronte.
“Il solito banale luogo comune dei delinquenti da strapazzo: io faccio schifo, ma c’è chi sta peggio di me”. Evitai di replicare e di fargli notare che quindici reati rappresentavano un curriculum criminale di un certo spessore e gli diedi la buona notizia. Essendo la pena inferiore ai quattro anni gli sarebbe bastato fare nei trenta giorni successivi richiesta di pene alternative alla detenzione, ad esempio l’affidamento in prova al servizio sociale (2), per evitare la camera d’albergo con le sbarre. Ciò gli avrebbe consentito di condurre una vita quasi normale.
Il suo volto fu illuminato da un improvviso sorriso. «Grazie avvocato, questa è una bella notizia. Ma cos’è l’affidamento in prova alla società?».
Gli dissi che si trattava di un modo di scontare la pena fuori dal carcere, col divieto di lasciare il comune di dimora e di stare in giro la notte, salvo un’autorizzazione del giudice. Gli spiegai che era necessario avere una casa e che avremmo dovuto chiedere al convento la disponibilità ad assicurargli un tetto per l’intera durata della pena, visto che non aveva nessuno disposto ad ospitarlo.
«Ma l’avvocato lo devo pagare io?». Ecco la fatidica domanda, lo scoglio contro il quale spesso si infrangevano le buone idee o gli astratti discorsi sulla libertà dell’uomo e sul valore rieducativo della pena. Lo rincuorai: se non aveva altre persone sul suo stato di famiglia e nell’ultimo anno non aveva avuto un reddito superiore a circa undicimila e settecento euro avrebbe potuto godere del patrocinio a spese dello stato, con un paio di autocertificazioni.
Finalmente i suoi dubbi furono fugati e mi firmò il mandato difensivo e le carte per il patrocinio.
Lasciai il convento soddisfatto del mio lavoro e con un foglio preziosissimo nella mia borsa: Fra Giacomo aveva firmato la disponibilità del convento a garantire un alloggio al Signor Lorusso.
Quella sera stessa, però, cambiò tutto.
Ero disteso in tuta sul divano, a sorseggiare una birra, con gli occhi fissi sulla televisione perché mancavano pochi minuti alla fine della partita ed il Milan pressava alla ricerca del pareggio, quando con rabbia squillò il mio cellulare.
«Buonasera, avvocato, sono Lorusso».
Ebbi l’istinto di mandarlo a quel paese. «Signor Lorusso, può richiamarmi domani? È molto tardi».
«Avvocato, la prego, mi deve ascoltare. Stracci le carte che le ho firmato. Voglio andare in carcere!».
Strabuzzai gli occhi per lo stupore. Me ne erano capitate di tutti i colori, ma quella del cliente che chiede di andare in carcere era davvero un’esperienza nuova. «Non capisco. Lei mi dice che…».
«Questi preti sono dei pazzi. Hanno regole assurde, orari da ragazzini. Vogliono che al mattino io devo recitare le lodi. Meglio il carcere!».
Per trovare le parole giuste, mi arrovellai a tal punto che mi persi il gol del pareggio del Milan. «Caro Signore, ma ha riflettuto bene?».
«Ho riflesso abbastanza».
«Ci ripensi. Non creda che in carcere le regole siano più flessibili. Guardi che i detenuti pagherebbero per uscire da quei formicai, pressati come sono in celle di pochi metri quadrati. Altro che lodi del mattino e orari rigidi…lì dentro ogni forma di libertà è perduta».
Lorusso alzò la voce, forse per timore che non lo ascoltassi. «Non vogliono che suono la chitarra. Quella è l’unica cosa che so fare. Non posso rinunciare. Questi frati sono dei mostri!».
“La chitarra” pensai “questa poi…chissà perché i pazzi capitano sempre a me”.
Il connubio tra le parole “ladro seriale” e la passione sfrenata per la musica possedeva il fascino dell’impossibile che si realizza. Ma era davvero così?
Provai a portare un po’ di logica in quel dialogo tra sordi. «Mi permetta di dirle, signor Lorusso, che in carcere non potrà di certo suonare la chitarra. Magari non riuscirà a dormire perché il suo compagno di cella russerà troppo a nemmeno un metro da lei, magari sarà coinvolto in una rissa con qualche prepotente che vuole dominare il raggio. Forse dovrà farsi la spesa allo spaccio perché alla mensa serviranno piatti immangiabili. O forse aspetterà invano che un parente o l’avvocato la vengano a trovare. Ma suonare la chitarra…questo proprio lo escludo! La esorto a ripensarci. La sua scelta, caro signore, è assolutamente folle. Per non sottoporsi alle regole dei frati lei accetta di umiliarsi ai piedi dei secondini di un carcere».
Seguì un istante di silenzio. Poi la voce fredda del mio cliente si confuse col fischio finale dell’arbitro. «Non mi faccio mettere i piedi in testa da nessuno, né da lei né dai frati. Stracci le carte. Non se ne fa più nulla!». E riattaccò.
Fissai lo schermo, immobile come una statua: i giocatori stavano facendo ritorno negli spogliatoi e gli allenatori avversari si stringevano la mano, all’imbocco del tunnel.
Mi avventai con rabbia sulla mia borsa di pelle. Estrassi tutte le carte firmate quella mattina da Lorusso e le ridussi in mille pezzi, con una sorta di selvaggio piacere.
Fui sul punto d’incolparmi per non aver saputo persuadere quel pazzo a farsi difendere. Poi prevalse il disprezzo per l’arroganza mostrata dal cliente.
Scostai le tendine e osservai, oltre i vetri della finestra, la strada deserta che scintillava al riverbero della luce dei lampioni. Pensai a quanto soggettivo potesse essere lo sfuggente ed indeterminato concetto di “libertà”. Per Lorusso la libertà era rappresentata dall’angusto perimetro della cella di un carcere e da quell’implacabile rumore di chiavi che ogni detenuto trova raggelante. “Tutto per non rispettare gli orari, per non recitare quattro preghiere e per non privarsi della chitarra…mah!”. Accostai le persiane, come se volessi chiudere fuori dal mio piccolo regno i dubbi che rischiavano di martellarmi il cervello.
Ne parlai anche con Claudia, la domenica pomeriggio. Eravamo seduti al bar del parco Sempione.
«Non capisco…» le sussurrai «Come può arrivare la mente di un uomo a disprezzare a tal punto la propria libertà?».
«Forse l’affidamento in prova al servizio sociale non rappresenta la forma di libertà che quel signore cerca. Forse teme di non farcela a rispettare le regole. La sua scelta, comunque, va rispettata. Nessuno può scegliere al nostro posto».
Mi presi la testa tra le mani. «Già, ma perché ha deciso così?».
Lei mi accarezzò i capelli e mi disse una frase che è rimasta impressa nei miei ricordi a distanza di due anni. «Forse il tuo cliente trova meno umiliante subire una punizione che non ha scelto e a cui non può opporsi, piuttosto che rinunciare alla sua libertà volontariamente, firmando un ricorso».
La guardai con ammirazione: Dio, quant’era profonda. Possedeva una capacità d’introspezione, tipicamente femminile, che io potevo solo sognarmi.
Quando chiusi la porta di casa, quella sera, mi dimenticai del Signor Lorusso per dodici lunghi mesi.
Ne cancellai il ricordo fino al pomeriggio del trenta ottobre dell’anno successivo, quando, nella cassetta della posta, trovai quella lettera che proveniva dal carcere di San Vittore.
Lorusso scriveva di non poterne più di stare dietro le sbarre, di avere già fatto due scioperi della fame. Lamentava di trovarsi in un raggio pieno di pedofili, di doversi difendere dai soprusi di altri detenuti e delle guardie. Parlava della qualità pessima del cibo, degli scarsissimi momenti di libertà, dell’impossibilità di comunicare con l’esterno. Implorava il mio aiuto affinché contattassi i frati per presentare, con un anno di ritardo, quel “famoso” ricorso per l’affidamento in prova al servizio sociale. Quando ebbi finito di leggere, appallottolai quel foglio e lo feci cadere nel cestino. Mi imposi di non andarlo a trovare per nessuna ragione al mondo: “ha fatto la sua scelta?” pensai “ebbene, ne paghi le conseguenze!”.
Fu zio Arturo a farmi cambiare idea.
Mi aveva invitato a cena, nel noto ristorante di pesce da Lorenzo, per riconciliarsi con me e dirmi che mi stimava e che avrebbe voluto continuare ad essere uno zio affettuoso e prodigo di consigli.
Servivano l’aragosta, quando il mio mentore mi fissò, con una luce bonaria che scintillava nei suoi occhi da serpente. «Un penalista non deve mai provare rabbia per il proprio cliente. Non deve farsi guidare dalla suscettibilità, ma dalla passione per la difesa dei diritti dell’imputato e, in particolare, del detenuto».
Ed io seppi che quelle parole avrebbero fatto breccia nel mio cuore.
Mi recai in carcere, il mattino seguente.
Lorusso mi accolse con un sorriso e due occhi da cane bastonato. Mi promise persino del denaro se lo avessi fatto uscire. Io rifiutai e gli feci di nuovo firmare le carte, promettendogli che sarei andato da Fra Giacomo un’ora dopo.
Stavo per uscire dalla saletta dei colloqui, quando il cliente mi scaraventò addosso le sue ultime parole. «Avvocato, senza rancore, però un anno fa avrebbe dovuto insistere di più perché cambiassi idea».
Divenni rosso di rabbia.
Strinsi tanto forte il pugno destro, da rischiare di spezzare in due la biro e fui tentato di stracciare le carte, una seconda volta.
Mi calmai solo quando credetti di vedere il volto appuntito di zio Arturo e ricordai le sue parole: “ un penalista… non deve farsi guidare dalla suscettibilità, ma dalla passione per la difesa dei diritti dell’imputato e, in particolare, del detenuto”.
Cumulo delle Pene
Nella fase dell’esecuzione penale (vale a dire allorchè giunge il tempo, per il condannato con sentenza irrevocabile, di scontare la pena) vengono spesso in rilevo questioni circa la determinazione della complessiva pena da scontare (con conseguente determinazione del giorno di fine pena), qualora vi sia concorso di reati (ovvero una pluralità di condanne penali a carico dello stesso soggetto che il pubblico ministero mette in esecuzione contestualmente con un unico ordine). Basti pensare all’istituto della continuazione, ex art. 81 cpv c.p., che anche in fase di esecuzione consente di ottenere uno sconto di pena, qualora più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi. In questo caso, tuttavia, è il giudice dell’esecuzione a dover quantificare la pena complessiva, rideterminandola eventualmente al ribasso, posto che è necessaria una valutazione discrezionale circa la riunione sotto il vincolo della continuazione di più reati giudicati separatamente e spesso non contestuali l’uno all’altro quanto alla loro esecuzione.
Quando, contro la stessa persona. sono divenute irrevocabili più sentenze o più decreti penali di condanna per fatti di reato diversi, esistono più titoli penali da porre in esecuzione e non può dunque applicarsi la regola di cui all’art. 669 c.p.p. (“Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre”), che vale invece nel caso di più condanne relative al medesimo fatto.
Viceversa, quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o più decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena, osservando le norme sul concorso di pene, ovvero gli articoli del codice penale che vanno dal 71 all’84.
Qualora le condanne di cui sopra siano state inflitte da giudici diversi, competente a determinare la pena complessiva è il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Da ultimo, la norma in esame dispone che il provvedimento debba essere notificato al condannato e al suo difensore, affinchè possano eventualmente dolersi dell’errata determinazione della pena.
Il pubblico ministero può ricomprendere le diverse condanne in un unico titolo esecutivo, sommando le varie pene algebricamente, sino a determinare col cumulo materiale la pena finale (che sarà semplicemente il risultato di una somma).
Colui al quale è notifico tale titolo (equivalente alla sommatoria di più condanne) ovvero sono notificati più titoli esecutivi relativi a diverse condanne può ricorrere al giudice dell’esecuzione chiedendo che la complessiva pena finale (oggetto dell’addizione delle singole pene) sia rideterminata al ribasso secondo i parametri dell’art. 81 cpv (pena relativa al reato più grave aumentata fino al triplo) allegando la circostanza che i vari reati furono commessi in continuazione tra loro (ovvero sulla base di un medesimo stato patologico, sulla scorta di un medesimo impulso ovvero in base ad un programma delittuoso unitario).
Se il giudice accoglie il ricorso ridetermina la pena finale passando dalla mera somma delle singole sanzioni (cumulo materiale) alla rideterminazione della pena finale con semplice aumento di quella irrogata per il reato più grave (cumulo formale).
L’art. 663 Codice di procedura penale così recita:
- Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
- Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 comma 4.
- Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore.
Affidamento in prova al Servizio Sociale
L’affidamento in prova ai servizi sociali è una pena alternativa alla detenzione; vale a dire una sanzione alternativa al regime di restrizione carceraria o domiciliare, che, in omaggio alla funzione rieducativa della pena, mira a favorire, attraverso una minore compressione della libertà personale, il reinserimento sociale del condannato (Così Cassazione penale, sez. I, sentenza 10/01/2019 n° 1032).
L’affidamento in prova al servizio sociale consiste nella possibilità, a determinate condizioni, di espiare la pena definitiva che sia contenuta entro un limite edittale massimo (ovvero senza limite di pena per i soli soggetti affetti da Aids conclamata o grave deficienza immunitaria) o il residuo di una maggiore pena, cioè detratta la pena già espiata o condonata, fuori dall’Istituto penitenziario, affrontando un periodo di prova il cui esito positivo estinguerà la pena ed ogni altro effetto penale.
L’affidamento in prova al servizio sociale presenta indubbi risvolti positivi di tipo sociale. In particolare:
- Costituisce il miglior modo di attuare il dettato costituzionale in punto di funzione risocializzativa della pena;
- Consente di affrontare il delicato problema del sovraffollamento carcerario;
- Consente di garantire al meglio le esigenze sanitarie, evitado contagi di massa all’interno di vetusti istituti di pena;
- Scongiura il contagio criminale;
- Favorisce l’avviamento dei rei al lavoro o ad attività di utilità sociale;
- Rappresenta un innegabile risparmio per le casse dello stato, in punto di mantenimento in carcere dei detenuti.
Quali sono le tipologie di affidamento?
- l’affidamento in prova ordinario (art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 o.p.)
- l’affidamento in prova di soggetti affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria (art. 47 quater legge 26 luglio 1975, n.354 o.p.)
- l’ affidamento in prova in casi particolari (inizialmente previsto dall’art. 47bis o.p., poi abrogato con l’art. 3 della legge 27 maggio 1998, n. 165) oggi previsto dall’art. 94, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
- l’affidamento in prova del condannato militare di cui all’art. 1 della legge 29 aprile 1983, n. 167.
Può richiedere l’affidamento in prova:
- il condannato che sia a piede libero o anche detenuto e debba espiare una pena, anche come residuo di pena maggiore, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire un giudizio prognostico favorevole (c.d.“affidamento allargato” ex art. 47 comma 3 bis o.p. che sostituisce una precedente declinazione dell’istituto, innalzando a quattro anni il limite di pena precedentemente fissato in anni tre)
- fuori da qualsivoglia limite di pena, il condannato affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria che abbia in corso un programma terapeutico o ad esso intenda sottoporsi presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.
- Ex art. 94 DPR n. 309 del 1990 (affidamento in casi particolari), il condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore ad anni sei se tossicodipendente ovvero alcooldipendente, qualora ritenga di sottoporsi ad un programma terapeutico di recupero, sempre che il programma sia certificato come idoneo.
Il condannato può essere ammesso all’affidamento purchè:
- abbia tenuto un comportamento che consenta un giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua rieducazione (assenza di pericolosità sociale);
- la misura in questione sia idonea a escludere il pericolo di recidiva;
- nel caso di soggetto affetto da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria, abbia ottenuto, dal servizio sanitario pubblico competente o dal servizio sanitario penitenziario, una certificazione che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, la quale deve essere allegata all’istanza.
Quando non può essere concessa?
- Per i delitti di cui all’art. 4 bis comma 11 o.p. (in sostanza per i reati di criminalità organizzata terroristica e/o mafiosa) l’affidamento può essere concesso solo in caso di collaborazione con la giustizia, salvo la collaborazione sia impossibile o irrilevante ai sensi del comma 1 bis o.p;
- Per i delitti di cui all’art. 4 bis comma 1ter2 o.p. (reati di particolare allarme sociale) l’affidamento può essere concesso qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva;
- Per i delitti di cui all’art. 4 bis comma 1 quater o.p.3, l’affidamento può essere concesso solo dopo un anno di osservazione della personalità condotta in istituto.
Il divieto di concessione dell’affidamento in prova non si applica ai soggetti affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria (art. 47 quater comma 9 o.p.)
Ai sensi dell’art. 58-quater comma 1 o.p. l’affidamento in prova al servizio sociale non può inoltre essere concesso: 1) al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di evasione; 2) al condannato (non minorenne: cfr. Corte Cost. Sentenza 436/1999) nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa, per un periodo di tre anni; 3) al condannato recidivo ex art. 99 comma 4 c.p. (recidiva reiterata) salvo dimostri di aver raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti (Corte Cost. Sentenza n. 79/2007); 4) al condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell’art. 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all’esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione: in quest’ultimo caso il divieto di concessione del beneficio opera per un periodo di 5 anni da quando è ripresa l’esecuzione.
Se il condannato si trova in libertà, l’istanza è presentata al pubblico ministero competente per l’esecuzione che la trasmette al tribunale di sorveglianza (art. 96 dpr 230/2000).
Se il condannato è detenuto, l’istanza è presentata al Direttore dell’istituto di detenzione il quale la trasmette al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo dell’esecuzione (art. 96 dpr 230/2000). In quest’ultimo caso, se a presentare l’istanza è il difensore della persona detenuta, munito di procura all’uopo rilasciata, l’istanza è depositata presso la cancelleria del Tribunale di Sorveglianza del luogo di detenzione.
Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ammissione all’affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova con ordinanza. L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti.
L’affidamento in prova viene concesso con ordinanza adottata in camera di consiglio dal Tribunale di Sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione della pena, sulla scorta della documentazione relativa alla personalità del condannato (cartella personale del detenuto o, se l’interessato è libero, informativa proveniente dall’Ufficio per l’esecuzione penale esterna detto UEPE) nonché di tutti gli elementi acquisibili ex officio che l’organo giudicante ritenga utili ai fini della decisione.
Il provvedimento è ricorribile in cassazione dal difensore del condannato iscritto all’albo speciale dagli avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori e dal Procuratore generale, entro 15 giorni dalla notificazione/comunicazione.
In caso di concessione del beneficio, l’ordinanza viene trasmessa, a cura della cancelleria dell’organo giudicante, al direttore dell’istituto penitenziario in cui si trova il condannato detenuto: ciò ai fini della sottoscrizione del verbale relativo alle prescrizioni che il beneficiario dell’affidamento dovrà seguire.
Nel caso in cui l’interessato sia libero, l’ordinanza è comunicata /notificata alle parti e ai difensori con l’avviso per l’interessato di presentarsi entro 10 giorni all’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) al fine di procedere alla sottoscrizione del verbale dinanzi al Direttore di tale struttura: la mancata presentazione del condannato in status libertatis comporta la revoca della misura salvo sussistano fondate ragioni del ritardo (art. 97 comma 2 DPR 30 giungo 2000, n. 230). La revoca sarà disposta dal giudice dell’esecuzione, a seguito di udienza.
In caso di mancata sottoscrizione del verbale l’affidamento in prova non ha effetto (v. art. 97, comma 3, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230).
L’inizio dell’esecuzione della misura è subordinato all’accettazione, mediante sottoscrizione del verbale, delle prescrizioni sottese all’affidamento in prova: prescrizioni che, per un verso, sono finalizzate a favorire l’opera di rieducazione del reo; per altro verso, sono dirette a neutralizzare eventuali fattori recidivanti.
Le prime fanno riferimento ai rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.
Le seconde, c.d. prescrizioni di polizia, hanno funzione limitativa e preventiva e possono riguardare il divieto di soggiorno in uno o più comuni, l’obbligo di soggiorno in un comune determinato, il divieto di svolgere attività o avere rapporti personali che possano comportare il compimento di altri reati.
In ogni caso le prescrizioni restrittive connesse alla concessione della misura non possono precludere l’esercizio dell’attività lavorativa. Il condannato che per lavoro è costretto a viaggiare fuori dal comune ove ha fissato il domicilio ovvero a trattenersi fuori di casa di notte avrà cura di chiedere al magistrato di sorveglianza le opportune autorizzazioni.
In effetti il lavoro (unitamente alla disponibilità dell’alloggio e alla non pericolosità sociale) rappresenta uno dei parametri più importanti per la concessione della misura.
Il lavoro, oltre a “nobilitare l’uomo”, è anche fondamentale per il reinserimento sociale e, garantendo fonti lecite di guadagno, rappresenta un deterrente al reato (forse il principale).
Analoghe autorizzazioni saranno concesse per ragioni di salute (ospedalizzazioni, visite specialistiche, esami etc) ovvero per la partecipazione ad eventi personali o familiari importanti (come funerali, matrimoni etc).
Nel verbale deve anche stabilirsi che l’affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del reato da lui perpetrato ed adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare. Ciò è disposto in funzione della mediazione dei conflitti, ritenuta fondamentale a fini risocializzativi.
Quando si tratta di condannati affetti da AIDS conclamata o grave deficienza immunitaria le prescrizioni da impartire devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma terapeutico presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di AIDS.
Nel corso della misura l’UEPE deve aiutare il condannato al reinserimento sociale, controllare la condotta tenuta, verificare il rispetto delle prescrizioni e riferire periodicamente al Magistrato di Sorveglianza sull’andamento dell’affidamento, inviando, infine, una relazione finale all’estinzione della pena.
Nel corso dell’affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell’ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferisce nella relazione periodica sul comportamento del soggetto.
La sospensione dell’affidamento in prova (art. 51 ter o.p.) può essere disposta se la persona sottoposta ad essa pone in essere comportamenti suscettibili di determinarne la revoca del beneficio (v. infra): in tal caso il magistrato di sorveglianza, nella cui giurisdizione la misura è in esecuzione, ne dà immediata comunicazione al tribunale di sorveglianza e può disporre con decreto motivato la provvisoria sospensione della misura alternativa ordinando l’accompagnamento in istituto del trasgressore. Il provvedimento di sospensione perde efficacia se la decisione del tribunale non interviene entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.
La revoca (art. 47 comma 11 o.p.) può essere disposta quando il comportamento del condannato, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, sia incompatibile con la prosecuzione della prova: in questi casi il Tribunale di Sorveglianza emette l’ordinanza di revoca, e ridetermina la pena residua da espiare.
L’annullamento può essere disposto in caso di sopravvenienza di un altro titolo esecutivo (art. 51 bis o.p.) che determini un residuo di pena superiore a quello consentito per la misura: in tal caso il pubblico ministero competente ai sensi dell’articolo 655 c.p.p. informa immediatamente il magistrato di sorveglianza formulando contestualmente le proprie richieste. Il magistrato di sorveglianza, tenuto conto del cumulo delle pene, se rileva che permangono le condizioni di applicabilità della misura in esecuzione, ne dispone con ordinanza la prosecuzione; in caso contrario, ne dispone la cessazione e ordina l’accompagnamento del condannato in istituto. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 è ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69-bis al Tribunale di sorveglianza.
Prescrizioni più comuni imposte al condannato ammesso alla pena alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale:
- Divieto di lasciare l’abitazione, al mattino, prima di una certa ora (generalmente le ore 8). Salvo autorizzazione per ragioni di lavoro, salute o familiari;
- Divieto di fare rientro nell’abitazione oltre un determinato orario (generalmente le ore 23). Salvo autorizzazione per ragioni di lavoro, salute o familiari;
- Divieto di lasciare il comune in cui si fissa il proprio domicilio. Salvo autorizzazione per ragioni di lavoro, salute o familiari;
- Divieto di frequentare pregiudicati;
- Divieto di partecipare ad assembramenti o di frequentare locali di spaccio di sostanze alcoliche;
- Conservare l’attività lavorativa;
- Avere stretti contati con l’UEPE.
Ai fini dell’ottenimento della pena alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale è esiziale dimostrare di poter contare su un alloggio e su una attività lavorativa idonea ad assicurare legittime fonti di reddito.
L’avvocato scrupoloso e diligente, avrà cura di informare il proprio cliente a piede libero, raggiunto da un ordine di esecuzione di pena temporaneamente sospeso in relazione al quale egli possa chiedere ed ottenere l’ammissione alla pena alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, dell’esigenza di presentare la suddetta istanza, perentoriamente entro giorni trenta dalla notifica, presso gli uffici della procura della repubblica che ha emesso l’ordine di esecuzione medesimo. Spirato tale termine il condannato non potrà più godere della sospensione dell’ordine di esecuzione e potrà essere tradotto in carcere. In questo caso egli dovrà fare analoga istanza a mani del Direttore del Carcere.