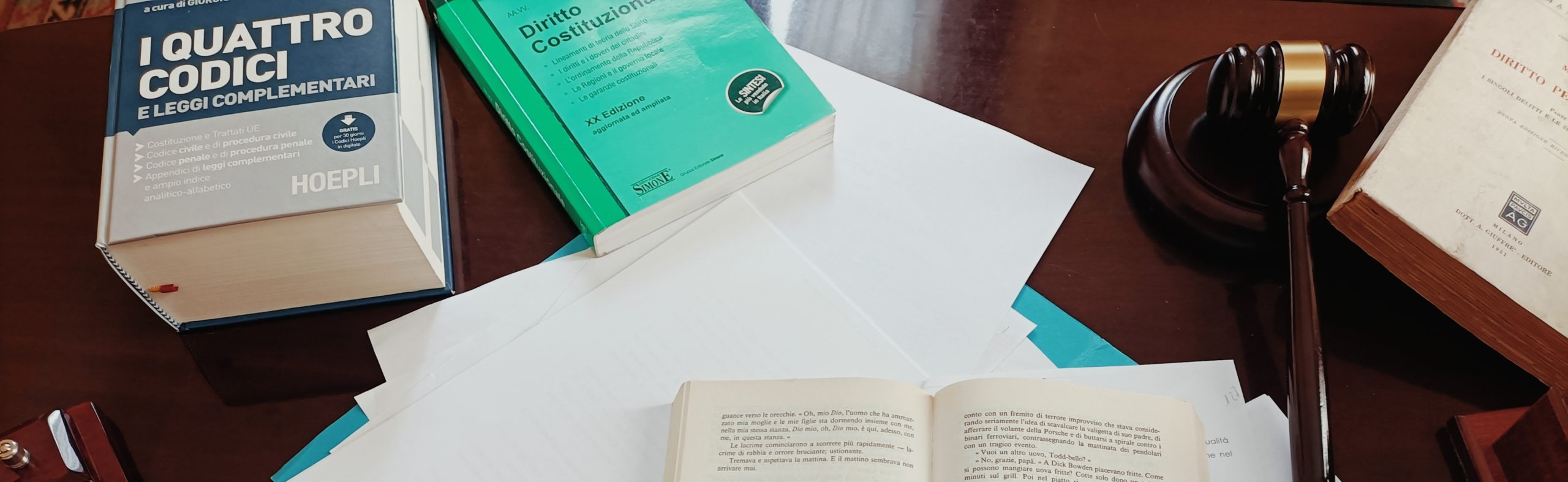Diritto Penale e Penale Minorile
Il nipote
Era un caldo ed assolato mezzogiorno di maggio, quando Claudia osò venire in studio senza essersi annunciata, neppure con un messaggino. Ne fui irritato, perché sono sempre stato geloso dei miei spazi.
La sentii chiacchierare con il mio socio, nell’atrio d’ingresso, mentre mi accingevo a scrivere qualche appunto, dopo avere completato la ricerca di giurisprudenza su un recente caso di bancarotta.
Mi precipitai in corridoio, sorpreso e preoccupato, ma la trovai di apparente buon’ umore. Quel volto sorridente sembrava scongiurare l’ipotesi di una drammatica resa dei conti, anche se non potevo esserne assolutamente certo, dal momento che la mia fidanzata era abile, talvolta, a nascondere la propria rabbia.
L’accolsi con un bacio e lei si mostrò molto comprensiva. «Scusa se sono venuta senza telefonarti, se sei impegnato posso tornare di pomeriggio».
«Scherzi?».
«Davvero. Se preferisci, prendo un appuntamento».
«Vieni! Andiamo nella mia stanza». Sbottai, nella speranza di porre fine a quella inutile manfrina.
Quando fu seduta, all’altro capo della mia scrivania, il suo umore sembrò cambiare all’improvviso. Si mordeva il labbro, aveva lo sguardo fisso e le mani stringevano la borsetta, con gesti nervosi.
«Si tratta di mio nipote Denis». Si fece sfuggire a voce bassissima.
«Cosa è successo?».
«E’ sotto processo, davanti al Tribunale per i minorenni, per bullismo. Ha tormentato un ragazzino più piccolo, così dicono. Ha udienza tra tre giorni. Mi sono molto arrabbiata con mia sorella, perché non mi ha detto niente fino a ieri sera. E’ difeso da un avvocato d’ufficio perché è gratis, lo paga il Tribunale. Io invece vorrei tanto che te ne occupassi tu. Voglio molto bene a Denis, me ne sono occupata fin quando io ero una ragazzina e lui piccolissimo. Si tratta di una difesa a pagamento, ovvio».
Sorrisi, orgoglioso di quella fiducia. Chiunque vorrebbe difendere un imputato minorenne: a meno che non si tratti di drammatici fatti di cronaca, basta che si materializzi in aula un genitore a piede libero ed il perdono giudiziale o la messa alla prova sono garantiti. Il carcere viene ritenuto altamente diseducativo per un ragazzino. Almeno quella volta non si trattava di un viaggio, ma di una parcella, seppur scontata per l’amicizia e la pseudo parentela. Per quella volta, dunque, niente Parigi, Copenaghen o New York, ma un piccolo gruzzolo di denaro ancora tutto da stabilire nel suo esatto ammontare.
La osservai con attenzione scientifica, felice di scoprire bagliori di sentimento che ultimamente non mi era sembrato di scorgere in lei. «Volentieri, amore. Ma tre giorni all’udienza sono pochi. Bisognerà studiare le carte e parlare con gli assistenti sociali che lo stanno seguendo».
«Già fatto». Sfilò, con prontezza, un rotolo di carte dalla borsetta e me lo porse. Mi sorpresi di quanto fosse stata rapida: aveva portato a termine la missione di cambio avvocato in poche ore. A ben pensarci, però, non c’era da sorprendersi, la mia ragazza, quando si metteva in testa qualcosa era più efficiente di un’agenzia d’investigazioni.
Diedi una rapida scorsa alle carte e constatai che il ragazzino s’era dato da fare parecchio. La procura gli contestava un reato di stalking continuato, per un arco di tempo che sfiorava l’anno. L’accusa era infarcita di una notevole serie di episodi: minacce con il coltello, furtarelli e rapine, video che ritraevano la vittima nell’atto di implorare pietà, per non dover subire altre botte, pubblicati sulla chat degli studenti dell’istituto tecnico ed anche su Facebook, calci, pugni e percosse assortiti e gli appellativi di gay e sfigato ripetuti con ossessiva insistenza.
“Caspita” pensai, sollevando gli occhi da quei pochi fogli “chi l’avrebbe detto. Proprio quel sedicenne pallido, dallo sguardo indifferente, privo di iniziative, ai limiti dell’impacciato, pronto a sfinirsi per ore con le cuffie alle orecchie e, ancor di più, a smanettare sul suo cellulare in preda ad una ferocia ossessivo-compulsiva…”. Eh già, quel ragazzino che non avevo mai osato neppure sfidare a calcetto, da tanto mi era antipatico, mi era sempre sembrato più simile ad un’ameba che non ad un mostriciattolo in miniatura.
Claudia dovette intuire i miei pensieri, e reclinò il capo di lato. «Sorpreso?».
«Ammetto di sì, dopo tutto. Però molto spesso il confine tra la noia ed il reato è molto sottile».
«Posso dirgli di venire da te oggi pomeriggio?».
Mi diedi un tono, consultando la mia agenda di studio, anche se ricordavo perfettamente che quel giorno avevo un solo breve appuntamento alle diciotto.
«Digli di venire per le quindici».
Lei scattò in piedi. «Molto bene. Adesso però voglio offrirti un pranzo da Leo».
Fui felice della proposta. Leo aveva sempre pesce fresco a buon prezzo ed il Gewurztraminer ne esaltava il sapore.
Il tragitto, a piedi, verso il ristorante si rivelò interminabile, una vera e propria via crucis. Claudia si fermava ad ogni semaforo rosso, appoggiando la sua testa alla mia spalla destra e portandosi un fazzoletto agli occhi.
Quando terminavano le lacrime, iniziava un profluvio di parole. «Il mio adorato nipotino, quello che ho tenuto in braccio da ragazzina, che ho aiutato a fare i compiti fin dalle elementari, a cui ho insegnato a nuotare, che viene sempre a cena da me il mercoledì….un bullo!…ma come è possibile? In cosa abbiamo sbagliato?».
Provai ad arginare tanto dolore con un pizzico di rassegnato buon senso. «Non avete sbagliato in niente, tu poi, sei solo la zia».
«E allora perché?».
«Il bullismo è un fenomeno sociale molto diffuso. Nell’ultima generazione ha assunto proporzioni allarmanti. Pensa che più del cinquanta per cento dei ragazzi dagli undici ai diciassette anni in Italia, al Nord, è vittima abituale di bullismo». Ero particolarmente informato perché, su quella materia avevo fatto la tesi, col professore di criminologia.
Davanti ad un fritto misto di pesce mi esibii nel pezzo preferito di quella ch’era stata la mia discussione accademica. «Secondo me nasce tutto da un mal inteso senso della forza. La violenza, invece che essere concepita come un fallimento della persona, agli occhi del bullo diventa il modo di affermare la propria potenza, annientando la personalità della vittima e divenendo il membro dominante del branco cui appartiene. Occorre spiegare ai ragazzi che la forza interiore si fonda sui valori etici, sull’empatia, sulla ricchezza di sentimenti e non sulla violenza».
Claudia mi ascoltava con interesse, ma era preoccupatissima. «Finirà in carcere?».
Quasi mi venne da ridere. «Tranquilla, il carcere è fuori moda».
«Davvero?».
«Puoi starne certa. Per finire in carcere oggi bisogna averla combinata davvero grossa ed avere alle spalle almeno un paio di precedenti. Insomma, bisogna essere senza speranza».
Con mia grande sorpresa, fui io a mettere fretta a lei; io che amavo trattenermi a tavola anche due ore. Volevo rientrare presto in studio per telefonare agli assistenti sociali, prima di ricevere il ragazzo.
Così feci.
Parlai con una giovane psicologa che mi disse che all’udienza, tre giorni dopo, avrebbe chiesto la sospensione del processo con la messa alla prova per un anno.
Mi illustrò un progetto che prevedeva colloqui del ragazzo con gli educatori ogni due settimane, la frequenza scolastica regolare e una attività di volontariato in una RSA.
“Quel mostriciattolo in una RSA?”. Pensai con sgomento. “Poveri vecchietti…”.
Il giovane campione di empatia varcò la soglia della mia stanza, scortato dalla mamma, con mezz’ora di ritardo.
Mi sbirciò con i suoi soliti occhi di vetro, che sembravano dire “Che ci sto a fare qui? Non possiamo vederci al prossimo giro?”.
Poi allungò la sua mano molle e sudata. «Ciao zio».
Dio, quanto odiavo quell’abusato appellativo, tanto in voga tra i giovani a Milano. Per me lo zio restava il fratello dei miei genitori, punto e basta.
Lo guardai dritto negli occhi. «Ho parlato con i tuoi educatori. Loro pensano ad un progetto di un anno. Si sospenderebbe il giudizio e se il progetto va bene il reato sarebbe estinto e tu saresti assolto. L’imputazione a tuo carico è grave ed io ti consiglierei vivamente di accettare. Cosa ne pensi?».
Lui mi guardò in diagonale, con sospettosità, e fece una smorfia. «Sarebbe quella storia per cui devo accompagnare in bagno i vecchi? Che palle!».
La sorella di Claudia, che sino a quell’istante aveva resistito in silenzio, divorandosi le unghie, sbottò all’improvviso. «Vergognati! Chi ti ha insegnato a parlare a quel modo? Porta rispetto per Alessio, che da oggi è anche il tuo avvocato».
Avrei voluto dirle che in quella penosa situazione c’era di molto peggio dell’educazione del linguaggio o di un paio di parole fuori posto, ma tacqui. In fondo non erano esattamente affari miei.
Claudia prese, con affetto, le mani del nipote. «Questo progetto ti aiuterà a crescere, Denis. Devi imparare che la forza non si identifica con la violenza, ma con il rispetto per il prossimo. Proprio no: la violenza è tutt’altro: è un segno di debolezza».
La guardai con una punta di compiacimento: la mia ragazza mi aveva ascoltato, nonostante la delizia della frittura di pesce di Leo, ed aveva imparato la lezione.
Denis cominciò a toccarsi i capelli e a sbuffare. «Non vedo perché dovrei buttare un anno della mia vita. Sì ho fatto qualche stupidata, ma eravamo un gruppo di tre. Mica l’ho fatto girare io il video. Quel poppante gli altri non li denuncia perché ha paura di loro, molto più che di me».
Gli spiegai che, a titolo di concorso morale, tutti i membri di un gruppo rispondono anche di ciò che fanno gli altri, se non sono stati pronti a dissociarsi.
Mi guardò, con la sua aria da extraterrestre e scosse la testa. «A questo mondo c’è la legge della giungla, lo sai anche tu. Se uno non sa difendersi viene schiacciato. Bisogna imparare a stare al mondo. Quello lì più lo picchi e più se ne sta in silenzio, come se si vergognasse. Non sono io ad essere un mostro è lui, quella specie di palla di lardo, che è uno sfigato!».
La madre del ragazzo balzò in piedi, rossa in viso per il furore, e temetti che volesse avventarsi contro il figlio. Claudia si limitò a scuotere la testa e a borbottare: «incredibile…incredibile…».
Decisi di essere pragmatico. «Molto bene. Se questa è la tua posizione non ci sarà nessuna messa alla prova. Non sarebbe giusto costringerti ad affrontare una prova tanto difficile». Non usai quelle parole a caso. Al corso per difensore minorile, due anni prima, mi avevano insegnato che talvolta il minore va spronato ad affrontare una sfida con sé stesso, per motivarlo a provarci. Deve convincersi che affrontare le proprie colpe è un segno di coraggio non alla portata di tutti.
La sorella di Claudia strinse le mani davanti al viso, come se volesse pregare.
«Denis, le educatrici ti vogliono aiutare, perché sputi in questo piatto? Fallo per me, per tuo padre e per tua zia. Non darci questo dolore. Non lo meritiamo!».
Lui mi guardò, con una scintilla di vita negli occhi immobili. «Devo proprio pentirmi per avere questo progetto ed essere assolto?».
«Esatto. I giudici minorili vogliono un’ammissione di colpa».
«Io non ammetto niente. Se uno è un debole non è colpa mia. Bastava che reagisse e i miei amici avrebbero smesso. La paura è un invito ad attaccare, come succede nella giungla. Lo sanno tutti».
Quel discorso mi fece orrore e credo che mi fosse sfuggita un’espressione disgustata. Tuttavia non potevo rinunciare al mio ruolo d’avvocato. «Allora affronteremo il processo e tu non sarai tenuto ad ammettere la tua colpa».
Ne seguì un autentico teatrino, con mamma e zia che lo imploravano di cambiare idea e di ammettere le sue responsabilità ed il ragazzo, pronto a rintuzzare ogni affondo delle due donne con una vigorosa scrollata di spalle.
Personalmente non ho mai trovato giusto costringere una persona ad ammettere colpe che non sente di avere, a torto o a ragione. I tribunali sono pieni di ipocriti pronti a confessare reati di ogni specie, solo nella previsione di uno sconto di pena o di un trattamento di favore.
Tuttavia Denis, dopo un’ora abbondante di colloquio, ammise di essere un po’ confuso e si prese del tempo per riflettere e decidere.
Lo congedai alle sedici e quarantacinque. Claudia mi ringraziò e mi promise che avrebbe fatto al nipote: «un bel lavaggio del cervello». “Quale cervello?”. Avrei voluto chiederle, ma ebbi il buon gusto di astenermi.
Quando rimasi da solo, nella mia stanza, mi ritrovai a fissare il profilo dell’edificio di fronte, oltre i vetri della finestra, sprofondando nei ricordi dell’età più difficile della mia vita: l’adolescenza.
Da ragazzo, ci avevano provato anche con me, a farmi sentire uno schifo, uno che vale meno di zero, come se mi rimanesse solo la speranza che la terra si aprisse sotto i miei piedi per inghiottirmi e farmi sparire alla vista del giudice più inflessibile: il mondo. Ma io non mi ero sprofondato nel buco nero dei miei silenzi. Parlavo con tutti: genitori, insegnanti e compagni. Quando parli butti fuor il veleno ed eviti che il peso della vita diventi insostenibile e ti seppellisca.
Eppure io avrei anche potuto cadere nella trappola della timidezza e della distruzione di ogni forma di autostima, se non avessi avuto al mio fianco tre amici veri. Antonio, Stefano e Giovanni si erano rivelati preziosi alleati nella quotidiana battaglia per trovare il mio spazio nel mondo. Da soli è molto più difficile combattere. Il bullismo, in effetti, si nutre della solitudine, della paura, della vergogna e del silenzio delle vittime. Fa leva anche sull’applauso di un pubblico compiacente e sull’indifferenza di chi potrebbe intervenire, per porre fine alla tortura, e decide consapevolmente di non farlo. “Proprio così” pensai “l’amicizia e l’empatia sono i due più potenti antidoti al bullismo”.
Il giorno dell’udienza preliminare, Denis non si era ancora deciso ad accettare il progetto messo a punto dagli assistenti sociali.
I giudici lo avevano invitato a riflettere, ma lui aveva ammesso di non essere in grado di esprimersi, al momento. Implorava solo di avere altro tempo. Uno dei giudici mi aveva guardato negli occhi, esprimendo la sua perplessità. «Avvocato Mayer, il suo cliente fa tanta fatica».
Ed io avevo ribattuto: «nessun cambiamento può essere profondo, se non costa fatica». Non sono impeccabile nella conoscenza dei codici, ma le frasi ad effetto spesso mi vengono bene.
Il Tribunale, al termine di una breve camera di consiglio, aveva deciso di rinviare di quattro mesi l’udienza, perché potesse esserci una mediazione, cioè un incontro tra vittima e presunto colpevole in una sede neutra e protetta, ai fini di una possibile riconciliazione.
Dopo tutto non era andata malissimo.
Avevo rivisto il mio pseudo nipote allo studio legale, molto prima del previsto, solo una settimana dopo.
Venne accompagnato da Claudia. Ma non era il solito Denis. Aveva gli occhi bassi, sembrava fissare la punta delle proprie scarpe. Un enorme cerotto gli proteggeva la fronte. Aveva un occhio pesto ed una vistosa cicatrice lungo la guancia sinistra.
Gli chiesi cosa fosse successo e lui sollevò gli occhi di scatto. «Siamo stati menati, io e i miei amici. Stavamo giocando a basket nel campo della scuola, quando sono arrivati certi ragazzi di quinta che si sentono i padroni di quel posto. Ci avevano chiesto soldi per lasciarci giocare, un mese fa, ma noi ci eravamo rifiutati di pagare. Allora ci hanno attaccato da ogni parte e ci hanno massacrato di botte. Non se ne sono andati finché non hanno visto il sangue scenderci dalla fronte».
Lo guardai con comprensione. «Mi dispiace. Sappi che puoi denunciarli». Era la prima volta che non provavo per lui un’aperta antipatia.
Mi disse che i suoi genitori e quelli dei suoi amici avevano già fatto querela in polizia.
Lanciò un’occhiata a sua zia e poi cercò i miei occhi. «Zio, sono venuto a dirti che accetto il progetto».
«Sei pronto ad ammettere le tue colpe, dunque?».
«Sono pronto».
Lo guardai con attenzione. «Posso sapere che cosa ti ha convinto?».
«Ieri le ho prese, di brutto. Adesso so cosa si prova».
Smisi di prendere appunto e mi concentrai su di lui. «I giudici ti chiederanno di spiegare bene il concetto. Non si accontenteranno di due parole. Dovrai chiarire il tuo pensiero. Vuoi provare a farlo con me, adesso?».
Lui si piegò in avanti ed avvicinò il suo viso al mio. «C’è sempre qualcuno più grande di te, nella vita. Non puoi capire gli altri se non vivi quello che hanno vissuto loro».
Mi appoggiai allo schienale della sedia e gli regalai un sorriso, forse il primo di sempre. «È vero, solo mettendoci nei panni degli altri possiamo capire le conseguenze delle nostre azioni, le sofferenze che provochiamo. Solo così possiamo sperare di crescere».
Bullismo
Nell’accezione lata e comune del termine si intende come bullismo: “una forma di violenza verbale, fisica e psicologica ripetuta nel tempo e perpetuata in modo intenzionale da una o più persone (i “bulli”) nei confronti di un’altra (la “vittima”), al fine di prevaricare e arrecare danno”.
Il bullo, a mezzo di un comportamento violento pienamente voluto e protratto nel tempo tende ad annientare la personalità della vittima, condannandola ad un permanente stato di allarme per la propria incolumità fisica ovvero psicologica.
Si parla di “asimmetria del rapporto”, in quanto l’autore di tali disdicevoli comportamenti tende a strutturare con la vittima designata un rapporto impari fondato su un potere proprio e sull’altrui sudditanza psicologica.
Secondo un’indagine statistica condotta nell’anno 2024 dall’osservatorio “indifesa” dell’associazione Terre des hommes, il bullo (singolo individuo ovvero anche gruppo di individui) designa la propria vittima:
- per l’aspetto fisico nel 79% dei casi;
- per l’orientamento sessuale nel 15% dei casi;
- per le condizioni economico/sociali nel 11% dei casi;
- per l’origine etnica e geografica nel 10,5 % dei casi;
- per la disabilità nel 5% dei casi;
- per la religione nel 4% dei casi.
Le conseguenze dei comportamenti violenti perpetrati dal bullo, secondo questa accurata statistica, sono diverse e gravi. Nel 75% dei casi in capo alla vittima si riscontra una perdita di autostima, sicurezza in sé stessi e fiducia negli altri.
Altri effetti negativi attestati sono:
- difficoltà di concentrazione e basso rendimento scolastico (28%);
- depressione (28%);
- paura e rifiuto della scuola (24%);
- disturbi alimentari (24%);
- autolesionismo (20%).
Il bullismo, a sommesso parere di chi scrive, si nutre di un malinteso concetto di forza. Quest’ultima, nella lente deformata del bullo, non appare come l’armonica strutturazione della propria personalità, la fedeltà ad un complesso strutturato di valori etici e ideali di riferimento, bensì, al contrario, come la violenta affermazione di un proprio potere fisico ovvero psicologico in danno di vittime indifese e costrette a subire in silenzio prevaricazioni e abusi.
Il bullismo impera altresì a causa dell’inerzia di un pubblico di osservatori che, invece di prendere le parti delle innocenti vittime di aggressioni fisiche o psicologiche, empatizzando con costoro, rimane indifferente o, peggio, risulta plaudente, quando addirittura non riveste un vero e proprio ruolo di complicità morale nella perpetrazione di tale odiose violenze.
Purtroppo il fenomeno di cui parliamo risulta difficile da arginare anche per il fatto che le vittime degli illeciti, per paura o vergogna, preferiscono chiudersi in un mortificato o atterrito silenzio, invece di reagire o riferire i torti subiti a terze persone, come insegnanti, personale scolastico, genitori e autorità di pubblica sicurezza. A costoro andrebbe sempre ricordato che della violenza deve vergognarsi colui che la commette e non già colui che la subisce.
Il fenomeno desta, attualmente, un grande allarme sociale sia per la sua diffusione sia per la gravità delle conseguenze che produce.
Qui di seguito riportiamo i dati statistici più significativi emersi da un’indagine ISTAT del 2014 (confrontati coi dati emersi da una nuova rilevazione del 2021, in attesa di un aggiornamento al 2023 non ancora disponibile, nemmeno ufficiosamente) relativi alla diffusione di comportamenti offensivi e violenti tra i giovani:
“Più del 50% degli intervistati 11-17enni ha riferito di essere rimasto vittima, nei 12 mesi precedenti l’intervista, di un qualche episodio offensivo, non rispettoso e/violento. Una percentuale significativa, pari al 19,8%, ha dichiarato di aver subìto azioni tipiche di bullismo una o più volte al mese (oltre 800 mila ragazzi). In circa la metà di questi casi (9,1%) si è trattato di comportamenti che sono avvenuti una o più volte a settimana. Le ragazze hanno evidenziato una percentuale di vittimizzazione superiore rispetto ai ragazzi. Oltre il 55% delle giovani 11-17enni è stata oggetto di prepotenze qualche volta nell’anno mentre per il 20,9% le vessazioni hanno avuto almeno una cadenza mensile (contro, rispettivamente, il 49,9% e il 18,8% dei loro coetanei maschi). Il 9,9% delle ragazze ha subito atti di bullismo una o più volte a settimana, contro l’8,5% dei maschi.
Tra i ragazzi utilizzatori di cellulare e/o Internet, il 5,9% ha denunciato di avere subìto ripetutamente azioni vessatorie tramite sms, e-mail, chat o sui social network. Le ragazze sono state più di frequente vittime di cyberbullismo (7,1% contro il 4,6% dei ragazzi) – si deve tenere conto però che nel 2014 l’utilizzo dei telefoni cellulari tra i ragazzi era meno diffuso di oggi.
L’indagine del 2014 evidenziava, infine, che bullismo e cyberbullismo tendevano a colpire gli stessi ragazzi: tra quanti hanno riportato di aver subìto ripetutamente azioni offensive attraverso i nuovi canali comunicativi una o più volte al mese, l’88% ha subito altrettante vessazioni anche in altri contesti del vivere quotidiano.
Nel 2021 – tra maggio e ottobre – l’Istat ha realizzato un’indagine sugli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado volta a cogliere la quotidianità dei ragazzi in un periodo in cui erano ancora evidenti le conseguenze della pandemia e ancora vigenti alcune regole relative al distanziamento sociale.
Il 9,4% degli intervistati ha dichiarato di aver assistito in prima persona o di essere venuto a conoscenza durante la pandemia di episodi di cyberbullismo sui suoi compagni di scuola (oltre 350 mila ragazzi). Sono soprattutto i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado ad avere assistito o a essere venuti a conoscenza di questo tipo di comportamenti (11,7%, contro il 7,9 delle scuole secondarie di secondo grado). Tra le ragazze, la quota è più alta rispetto ai coetanei maschi: rispettivamente 11,3% contro 7,6%. Per i ragazzi stranieri la percentuale di persone che hanno assistito o saputo di episodi di cyberbullismo sale al 12% (per gli italiani è 9,2%); si deve inoltre registrare che per gli stranieri la quota di coloro che non risponde è notevolmente più elevata di quella registrata tra gli italiani: 7,7% contro 2,9%; anche questo potrebbe essere interpretato come un segnale di maggior disagio rispetto a questo tipo di fenomeno.
A partire da settembre 2023, l’Istat realizzerà una nuova indagine dedicata a tutta la popolazione residente tra gli 11 e i 19 anni, su un campione rappresentativo per sesso, cittadinanza e ripartizioni geografiche. Il questionario prevede diversi quesiti su bullismo e cyberbullismo”.
Il report dell’Osservatorio “indifesa” di Terre des Hommes e scuola Zoo, pubblicato in vista della giornata mondiale contro bullismo e cyberbullismo del 07.02.2024, dipinge un quadro significativamente più allarmante: su un campione di 4000 ragazze e ragazzi italiani intervistati, di età compresa tra il 14 e i 26 anni, il 65% dei giovani ha ammesso di essere stato vittima di violenza; fra questi il 63% ha subito atti di bullismo (o meglio, definiti come tali dalla vittima) e il 219% di cyberbullismo.
A essere maggiormente prese di mira sono le ragazze, dato che il 70% ha raccontato di aver subito una violenza, sia fisica sia psicologica, e le persone non binarie; in quest’ultimo caso la percentuale sale addirittura all’83% mentre gli episodi tra i maschi si aggirano attorno al 56%.
Dopo una lunga attesa, e una altrettanto complessa gestazione, vi è stato un primo intervento normativo in tema di bullismo, con particolare riferimento al cyberbullismo.
La legge 71/17 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” è nata per tutelare il diritto delle nuove generazioni di navigare in rete in modo sicuro, positivo e libero. Prevede altresì linee di orientamento per contrastare il cyberbullismo all’interno delle scuole. È una legge pensata sia per perseguire e recuperare socialmente i responsabili, sia per proteggere le vittime.
La legge 71/17 all’articolo 1 conia la prima ufficiale definizione giuridica del cyberbullismo come: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. La legge è scritta e promulgata allo scopo di individuare e concretizzare misure, le più efficaci, di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori (qualunque sia il ruolo da costoro rivestito nell’episodio incriminato) da attuare in ambito prevalentemente ma non esclusivamente scolastico (in effetti la scuola è la triste più frequente palestra di bullismo).
La legge definisce il ruolo dei diversi attori del mondo della scuola italiana (MIUR, USR, Istituti Scolastici, Corpo docente) nella promozione, ampia ed efficace, di attività preventive, educative e ri-educative (quest’ultime finalizzate a riparare i torti subiti, al recupero sociale dei responsabili e ad evitare la recrudescenza del fenomeno, con ricaduta nell’illecito). L’insieme di queste azioni di attenzione, tutela ed educazione è rivolto a tutti i minori coinvolti in episodi di cyberbullismo, sia che si trovino nella posizione di vittime sia che rivestano quella di responsabili di illeciti, e senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. In particolare:
- Ogni istituto scolastico deve individuare fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Il ruolo di tale docente è dunque centrale.
- Secondo quanto già previsto dalla legge 107 (la Buona Scuola) per il triennio 2017-2019 ci sarà una formazione del personale scolastico sul tema.
- Verrà promosso un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole.
- In un’ottica di alleanza educativa, il Dirigente Scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo informerà tempestivamente i genitori dei minori coinvolti. I regolamenti e il patto educativo di corresponsabilità (destinato a tutte le famiglie) scolastici dovranno essere integrati con riferimenti a condotte di cyberbullismo.
- Le istituzioni scolastiche devono promuovere, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi. Gli uffici scolastici regionali sono chiamati a promuovere progetti elaborati nelle scuole, nonché azioni integrate sul territorio di contrasto del cyberbullismo e educazione alla legalità.
Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore) che sia stato vittima di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro le ventiquattro ore successive il gestore non avrà provveduto, l’interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.
È stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.). In caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c’è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
Oggi però, le linee guida delineate da quella legge del 2017 risultano insufficienti. Per questo, il governo ha deciso di integrare la legge introducendo innovazioni attraverso la nuova legge 70/24. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 30 maggio 2024, descritta come “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo”, questa legge estende le disposizioni della 71/17 anche ai fenomeni del bullismo (oltre quindi il perimetro del cosiddetto cyberbullismo), con la finalità di prevenire e contrastare entrambe le azioni considerate oggetto del reato.
Nell’incipit della novella legislativa leggiamo che: “La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con azioni di carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l’attuazione degli interventi, senza distinzione di età, nell’ambito delle istituzioni scolastiche, delle organizzazioni degli enti locali, sportive e del Terzo settore che svolgono attività educative, anche non formali, e nei riguardi dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombe l’obbligo di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l’uso”.
Il comma 1-bis definisce il bullismo come “l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonee a provocare sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni”.
Un altro importante intervento introdotto dalla Legge 70/2024 riguarda la possibilità per le Regioni di attivare, presso le scuole, servizi di supporto psicologico per gli studenti. Questo servizio mira a fornire assistenza agli alunni in situazioni di disagio, coinvolgendo anche le famiglie in un percorso di prevenzione e gestione dei conflitti. L’obiettivo è quello di garantire un intervento tempestivo e qualificato, capace di affrontare le problematiche legate al bullismo e al cyberbullismo in modo integrato e personalizzato.
Inoltre, la nuova legge prevede che ogni istituto scolastico adotti un codice interno per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, oltre a istituire un tavolo permanente di monitoraggio. Questo tavolo, composto da rappresentanti degli studenti, delle famiglie, del corpo docente e da esperti del settore, ha il compito di monitorare costantemente la situazione all’interno della scuola, promuovendo iniziative di prevenzione e sensibilizzazione.
Un ulteriore elemento di novità della Legge 70/2024 è rappresentato dalle misure rieducative previste per i minori responsabili di condotte aggressive o lesive della dignità altrui. Il Tribunale per i minorenni può disporre lo svolgimento di progetti educativi e riparativi, sotto la direzione dei servizi sociali, che possono includere attività di volontariato sociale, laboratori teatrali o di scrittura creativa, corsi di musica o sport.