Diritto Penale e Processuale Penale
La sfida
Quel pomeriggio avevo preso un caffè di troppo.
Quando lo bevo a breve distanza da quello precedente mi vengono sempre la tachicardia ed il voltastomaco.
Al rientro in studio, mi imbattei in Jacopo, il nostro primo praticante, assunto dopo una interminabile quanto accurata selezione, e vidi che era emozionatissimo. Mi parlava di un caso che scottava e di una signora che mi aspettava nella mia stanza.
Avevo la testa ovattata da una specie di ronzio, ma le parole “omicidio volontario” e “corte d’assise” mi restarono impresse.
Accellerai il passo lungo il corridoio, perché la curiosità era insopprimibile.
La porta era semiaperta e la vidi di profilo. Mi sembrò una donna sulla quarantina, magra, sinuosa ed irrequieta.
Mi sedetti alla scrivania e le strinsi la mano, mentre chiedevo a Jacopo una nuova cartelletta ed un discreto quantitativo di foglia bianchi, per gli appunti.
La signora si passò un fazzoletto sugli occhi, ancora umidi. Doveva aver pianto a lungo.
Le feci raccontare la sua storia, dicendole che non avevo fretta.
Era rimasta vedova da pochi mesi. Suo marito, un affermato ristoratore, era stato ucciso a colpi di pistola, in un prato vicino a Via dei Missaglia, dopo una cena con gli amici. La polizia le aveva detto che si trattava di una vera e propria esecuzione.
Il pubblico ministero aveva incriminato un tale Signor Rizzo, assolto in un precedente processo dall’accusa di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso. Il capo d’imputazione era stata formulato, sentite le dichiarazioni dell’unico testimone presente ai fatti, un conoscente del defunto, che aveva dichiarato di avere assistito al diverbio tra vittima e colpevole, su una partita di droga non pagata. Aveva riferito che il Rizzo, pronunciate le parole: “figlio di puttana”, aveva puntato l’arma contro Giuseppe Tallarida, il marito della signora che mi stava davanti, facendo fuoco prima che questi potesse darsi alla fuga.
Il presunto colpevole aveva partecipato, assieme alla vittima ed al testimone, alla cena tra amici che avrebbe dovuto appianare contrasti d’affari.
La signora, che di cognome faceva Frigo, mi scrutò con occhi imploranti. «La prego avvocato. Voglio conoscere la verità. Io ho sempre ritenuto mio marito una brava persona, ma ultimamente non lo capivo più. Era sempre arrogante e pieno di soldi. Frequentava brutta gente. Aveva paura, eccome. Si guardava sempre alle spalle. Una volta aveva fermato all’improvviso la macchina in autostrada, convinto che qualcuno ci seguisse. Quella gente, Rizzo ed i suoi amici, faceva affari con lui. Era brutta gente. Erano una specie di…mafia!». Tremò quasi, nel pronunciare quell’ultima parola. Mi strinse le mani con veemenza. «La prego avvocato, scopra la verità. Voglio sapere se mio marito era diventato uno di loro. Questo, per me, sarebbe peggio della sua morte, dei colpi di pistola, di tutto!».
Io annuii, senza sottrarmi alla stretta, ed intanto pensavo “cara signora, anche se riuscissi a scoprire la peggiore delle verità, non avrei mai il coraggio di distruggere la memoria di suo marito”.
Infilai nella pratica il decreto di fissazione dell’udienza preliminare e constatai, senza sorpresa, che l’imputato si trovava presso il carcere di San Vittore, in misura cautelare ed in attesa del processo.
Feci firmare alla mia nuova cliente, dai capelli biondi come i miei e dallo sguardo persino più innocente, la procura per la costituzione di parte civile.
Le spiegai che, all’udienza preliminare e poi al processo, avrei rappresentato i suoi interessi di erede del defunto marito, chiedendo la punizione del colpevole ed il risarcimento del danno.
Lei mi ringraziò e, lasciando lo studio, mi sembrò confortata.
Quanto tornai nella mia stanza, vidi che Jacopo mi fissava con occhi sgomenti.
«Che c’è? Hai visto un fantasma?». Avevo stabilito che ci saremmo dati del tu. Ero incapace di coltivare rapporti profiqui che non fossero riconducibile ad un vago senso di parità.
«Hai visto?». Mi chiese, indicandomi la quinta riga del decreto di fissazione dell’udienza.
«Che cosa?».
«Arturo Battaglia è tuo zio?».
«Proprio così. E allora?».
«Tuo zio difende l’imputato, Vito Rizzo».
Rimasi raggelato ed afferrai il foglio che il praticante mi tendeva.
Era vero: zio Arturo sarebbe stato il mio avversario in quel processo, il più importante della mia vita. Proprio lui, il mio mentore, il miglior avvocato penalista che esistesse sulla faccia della terra.
Riposi il decreto nell’apposita cartelletta, col cuore che mi tambureggiava in petto. Troppe emozioni in mezz’ora: il mio primo caso di omicidio volontario, lo spettro della Corte d’assise e di una battaglia legale contro un sodalizio mafioso…zio Artuto dall’altra parte della barricata, pronto ad annientarmi. Era tutto decisamente…TROPPO GRANDE.
Per non perdermi in un inutile labirinto di pensieri, stabilii di fare un passo alla volta. Decisi che il mattino successivo mi sarei recato in procura, negli uffici del pubblico ministero assegnatario del fascicolo, questo tale Dr. Carlo Biondi, che non conoscevo affatto.
E lo feci, scortato dal fido Jacopo.
Bussai alla porta di legno massiccio e sentii un flebile: «avanti».
L’immagine che i miei occhi fotografarono fu piuttosto sconfortante.
Il magistrato era sprofondato, con indolenza, nella sua poltrona, gli occhi semichuisi rivolti al soffitto ed i piedi accavallati sopra una sedia. Aveva la cintura dei pantaloni slacciata ed una pancia smisurata, che sussultava come se potesse godere di vita propria, e che gli avrebbe impedito, anche se avesse spalancato gli occhi, di vedere i propri arti inferiori.
Da uno stereo, che faceva tremare il legno della mensola su cui era stato adagiato, provenivano le note di “amami, Alfredo…”, l’aria della Traviata.
«La disturbiamo, dottore?». Preferii essere cauto.
«Chi siete?».
«Avvocato Alessio Mayer, lui è il mio praticante: Dottor Jacopo Foldi. Mi costituirò parte civile nel processo Vito Rizzo».
Il pubblico ministero aprì di scatto un occhio. «Brutto affare, vero? Non ha paura?».
Avvertii una fitta allo stomaco. «Lei conosce la pratica molto meglio di me. Lo chiedo io a lei se è un brutto affare».
«Bruttissimo. Sono tutti pugliesi. C’è puzza di Sacra Corona. Droga, armi, contrabbando…di tutto!».
«Lei crede che Tallarida potesse essere implicato in qualche losco affare?»
«La cosa non ci riguarda».
Aveva ragione. La mia era stata una domanda da dilettante. Ero stato sviato dal volto di quella donna, pregno di sincero dolore.
«So che c’è un testimone oculare». Azzardai il tema più delicato, quello delle prove.
«Proprio così, bella fortuna».
Stavo per fare una domanda scomoda e mi sforzai di misurare le parole. «A questo proposito le volevo chiedere…ha pensato di blindare la prova? Voglio dire ha fatto verbalizzare le dichiarazioni del teste davanti ad un giudice in incidente probatorio (1)? Visto che conta solo ciò che il teste dice in dibattimento, non vorrei che ritrattasse le accuse. In questo caso l’impianto accusatorio crollerebbe come un castello di carta».
Il magistrato aprì anche il secondo occhio, con una vaga espressione irritata. «E perché mai? Non c’è pericolo che ritratti. Confermerà in aula quanto ha già riferito a me durante le indagini».
Tenni a freno il nervosismo. «Mi scusi, ma lei ha detto che questo è un brutto affare. Ha detto che c’è puzza di Sacra Corona. Ha chiesto a me se avevo paura. Non crede che possa averla il testimone? Che possa essere minacciato o comprato?».
Il Dottor Biondi tornò a chiudere entrambi gli occhi e si toccò il naso. «Andrà tutto bene. Si fidi del mio fiuto. Trent’anni di esperienza sono troppi per potersi permettere l’ingenuità».
Ritenni chiuso il discorso. Lo salutai e me ne andai, in verità molto preoccupato dalla sciatteria dei modi e dei discorsi cui avevo assistito.
Mentre aspettavamo l’ascensore, Jacopo fu un rabbioso fiume in piena. «Ma come possono affidare un’indagine così delicata ad un tipo simile? Quello è uno scansafatiche. Non gli farei neanche vendere i biglietti al botteghino di un cinema d’oratorio. E’ allucinante. Tu hai ragione: doveva far sentire il testimone davanti al giudice».
Annuii, mentre nella testa mi ronzavano cattivi presagi.
Decisi di far visita a zio Arturo, tanto aveva lo studio in Viale Papiniano, a poche centinaia di metri dalla nuova tana mia e di Claudio.
Lo incrociai sul portone, mentre salutava un cliente.
Quando mi vide volle abbracciarmi ed offrirci un caffè. Jacopo gli piacque. Aveva un debole per tutte le anime candide, a patto che avessero lo sguardo furbo e che fossero leali e pronti alla sfida. Le sfide erano la sua ossessione.
Gli dissi che avrei difeso la vedova Tallarida e gli occhi gli s’illuminarono. «Fai bene a metterti in gioco. Ti vedo cambiato. Ho lasciato un ragazzo e ritrovo un uomo».
Sostammo al banco del bar, benché ci fossero almeno tre tavolini liberi.
«Qualcuno ti ha chiesto di parlare col testimone?». Chiesi a bruciapelo, certo che lo zio avrebbe detto la verità, almeno a me.
Mi fissò, con una luce delusa nei suoi occhi da serpente. «Scherzi? Lo sai che io non mi faccio mai coinvolgere. Io non manipolo i testimoni. Voglio vincere per la mia abilità, nel rispetto delle regole del gioco!».
«Il pubblico ministero mi ha chiesto se ho paura ad assumere questo mandato».
«E perché mai dovresti averne?».
Appoggiao la tazzina di caffè sul banco. «Già. Perché dovrei averne?».
Lo salutai battendogli una mano sulla spalla, come soleva fare lui con me, e feci segno a Jacopo di seguirmi fuori dal locale.
All’udienza preliminare lo zio non presenziò, ma si limitò a mandare un sostituto. Lui si scomodava solo per le grandi occasioni.
Io perfezionai la costituzione di parte civile, nell’interesse della Signora Frigo.
L’udienza fu molto rapida, giusto il tempo di individuare nell’agenda elettronica la data più opportuna per l’inizio del vero e proprio processo, quello che si definisce pomposamente “il dibattimento”: l’11 Aprile, due mesi più tardi.
Sarebbero stati due mesi di preparazione psicologica, perché ci tenevo parecchio, sia per la gravità del reato, sia per l’inedito confronto col mio maestro.
Perciò volevo curare la mia difesa in ogni dettaglio, anche il più trascurabile.
E, per quanto mi fu possibile, lo feci.
Il processo iniziò in un clima di grande tensione, alla presenza di giornalisti e di un folto pubblico di studemti.
Ricorderò per tutta la vita l’udienza in cui venne escusso l’unico teste dell’accusa: Pietro Nastro.
Era un tipo più largo che lungo, dal volto inespressivo, incassato nelle spalle, col collo taurino e le mani da contadino.
Io sedevo nel banco riservato alla parte civile, con Jacopo alla mia destra e Claudio, che mi faceva da consulente, alla sinistra. Li avevo voluti entrambi al mio fianco perché, non mi vergogno a dirlo, avevo bisogno di sentirmi protetto.
Lo zio mi strizzò l’occhio; sembrava che una piccola fetta della sua anima, quella meno corrotta, facesse il tifo per me.
Dietro le sbarre, gli occhi luciferini dell’imputato scintillarono nel silenzio marmoreo dell’aula. I membri della giuria popolare erano schierati in fila, come una piccola falange.
L’enigmatico Signor Nastro venne invitato ad accomodarsi al banco dei testimoni.
Il Dottor Biondi, questa volta sufficientemente sveglio da potersi reggere in piedi, seppur rigido come un pinguino, gli chiese se confermava le dichiarazioni fatte in precedenza.
«Io non so niente». E l’aula rumoreggiò, tanto da costringere il Presidente ad invitare i presenti al silenzio.
Il pubblico ministero era sgomento e si curvò sulle sue carte, col respiro affannoso. «Come sarebbe a dure: io non so nulla? Io le contesto che lei ha dichiarato di aver visto il Signor Rizzo sparare alla vittima».
Il teste, all’evidenza ben preparato, non ebbe esitazioni. «Guardi, io ero strafatto. Proprio ubriaco…».
«Quando ha fatto le dichiarazioni?». Il pubblico ministero sventolò, con gesti furenti, tre fogli pinzati. «Quando ha sottoscritto questo verbale, lei era forse ubriaco? Si rende conto di quello che dice?».
«No, io ero ubriaco la sera dell’omicidio. Ho visto solo un film tutto mio. La mia testa non era lucida. Io pensavo di aver visto sparare…a distanza di tempo ho capito che era tutto dentro la mia testa, forse per lo choc. Che non era vero niente…».
Claudio mi sussurrò all’orecchio. «Sta ritrattando. Qui si mette male. Colpa del pubblico ministero che si è fidato dell’unico teste e non l’ha tenuto sotto pressione».
Io iniziai a mordermi le unghie.
Il pubblico ministerò si lanciò, con tardiva veemenza verbale, contro quello che, durante le indagini, era stato il suo unico alleato e che in quel momento stava condannando a morte la tesi accusatoria. Si scompose, balbettò, diede sordi colpi di tosse, come se avesse ingoiato litri di saliva. Fece davverro pena. Mi era piaciuto di più con gli occhi chiusi, nel suo ufficio, al magico riverbero de “amami, Alfredo…”.
Feci correre lo sguardo alla mia destra. Jacopo scuoteva la testa con, dipinta in volto, una smorfia di disgusto. Lo sentii borbottare. «Che pagliaccio…gente che ruba lo stipendio alle casse del ministero della giustizia!».
Il muro eretto dal testimone resistette ai colpi degli sgangherati attacchi dell’accusa, evidentemente sorpresa, senz’armi in pugno o idee di scorta pronte all’uso, da quella inattesa svolta processuale.
Il dottor Biondi arrivò ad allargare le braccia, come un’aquila in volo, e ad urlare senza più controllo. «Le pare giusto? Ma io dico: ha un senso tutto questo? Ci si accorge a distanza di mesi di essere stato vittima di un delirio alcolico? Davvero lei non è in grado di distinguere fantasia e realtà? Lei è forse uno da interdire per infermità di mente?!».
Il presidente posò sul teste due occhi da corvo. «Lei è stato forse minacciato?».
Il teste scosse la testa con decisione. «Minacciato io? Ma quando mai!».
Claudio mi diede di gomito e sussurrò. «Solo tu puoi salvare la situazione. Non hai niente da perdere. Attaccalo, attacca il testimone. Fissalo negli occhi, fagli paura. Ricordagli la gravità della falsa testimonianza!».
«Sicuro?».
«Sicuro».
«Ma non si fa mai. Non si attacca il teste che può darti una mano».
«Il teste l’abbiamo già perso. Ora è un nostro avversario. Non hai nessun’altra carta da giocare. Fallo!».
Pensai che avesse ragione e quando ebbi la parola, attesi dieci secondi prima di formulare la mia prima domanda. In quello spazio di tempo fissai con spietatezza il Signor Nastro. Lui distolse lo sguardo e la mascella gli tremò: aveva paura.
«Signor Nastro, lei ha mentito al pubblico ministero durante le indagini o mente oggi? Quando ha detto il falso?».
Il testimone impallidì. «Né oggi, né l’altra volta. Io non ho mai mentito».
«Eh no, caro signore. Siccome io non credo alla visione dei fantasmi, agli extratraterrestri che abitano nell’alcool o ai sogni scambiati per realtà, ho la certezza oggettiva che lei ha mentito in una delle due occasioni. Quando?».
Il teste non rispose ed io ne fui incoraggiato e lo incalzai, fissandolo negli occhi con lo sguardo da serpente che avevo imparato dal mio mentore.
«Mi permetta, signor Presidente, di ricordare al testimone che la falsa testimonianza è un reato molto grave, punito dal nostro codice con una pena massima di sei anni. A volte si sta in carcere più per falsa testimonianza che per un omicidio….ora mi dica: perché lei ha mentito quando ha dichiarato al pubblico ministero di avere assistito ad un omicidio? Forse per coprire le proprie responsabilità? Forse perché lei è implicato nell’omicidio e ha preferito depistare le indagini accusando un innocente per salvare se stesso?».
«Io non ho mentito…io non sono implicato, non ho fatto niente…io…». Il teste bofonchiò a voce bassissima, lo vidi diventare rosso come un peperone, vacillare sulla sedia, ebbi la plastica percezione del fatto che si sentisse sull’orlo del burrone.
Zio Arturo balzò in piedi, agile come una volpe. «Signor Presidente, mi oppongo. La domanda è inammissibile. L’avvocato difensore, pur brillante e competente, sta forzando il testimone. Sta dando per scontato che il testimone abbia ammesso una falsa dichiarazione, cosa che non è avvenuta. Le domande devono essere poste su fatti oggettivi, solo su quelli, non su ipotesi personali!».
Vidi il Presidente incerto. Ci stava pensando. Si morse persino un labbro. Tre secondi di silenzio, in casi come questi, sono eterni. Poi si scosse la testa. «La domanda non è ammessa, avvocato Mayer».
E così svanì, non per mia colpa, l’unica occasione di vincere quel processo e fare giustizia. Ancora oggi sono convinto che se quella domanda fosse stata ammessa, il teste avrebbe a fatica buttato la pallina dall’altra parte della rete, ma con la domanda successiva avrei messo a segno uno smash vincente. Ma non andò così. E nessuno più di me sa che nella vita conta solo come le cose vanno realmente e non come sarebbero potute andare nell’infinito spettro delle nostre proiezioni immaginifiche.
Claudio mi sorrise. «Sei stato bravo. Non potevi fare altro…bravo…bravo…».
In sede di discussione feci del mio meglio, almeno credo. Parlai per settanta minuti, il mio record personale.
Per il resto ammirai a bocca aperta l’arringa di zio Arturo, precisa, suggestiva, manipolatoria…come nel suo stile!
La camera di consiglio durò tre ore, poi il presidente diede lettura della pronuncia di assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto.
Mi complimentai con lo zio e lui mi battè una mano sulla spalla. «Complimenti a te, Ale. Non conta come è andata. Conta dare il massimo e metterci passione. E tu l’hai fatto».
Riuscii persino a sorridergli.
Tuttavia, prima di lasciare l’aula, mi accostai nuovamente a lui, che infilava la toga nel borsone. Gli parlai da pari a pari, come ero certo che avrei fatto sempre da quel momento in poi. «Non finisce qui, zio. Questo è certo. Ci sarà un appello e farò di tutto perché la sentenza di oggi sia ribaltata».
Lui mi strizzò l’occhio. «Mi stupirei se tu non ci provassi. Ne sarei deluso. Non sarebbe degno di mio nipote. Tu, però, sei solo un’umile parte civile. Puoi fare appello solo per il risarcimento del danno. Per la condanna penale dovresti convincere il pubblico ministero ad agire».
«Lo convincerò».
«Sicuro? A me quello sembra un mollaccione. Ho più paura di te che di lui!».Mi sorrise di nuovo. «Ci si vede a cena da Lorenzo. Per parlare d’altro, ovvio. Ha un astice alla catalana da fare impressione. Siccome l’imputato è stato assolto, pago io» e scomparve, lungo il corridoio, con i misteri, gli enigmi e la complessità di un animo eternamente insondabile.
Io lasciai l’aula nella direzione opposta.
Su una panchina di marmo trovai ad aspettarmi Claudio e Jacopo.
Seppi con certezza che per vincere in appello avrei avuto bisogno di loro.
Incidente probatorio
L’incidente probatorio è un istituto previsto e disciplinato dall’art. 392 del codice di procedura penale. Viene celebrato in un’udienza, che si svolge in camera di consiglio (dunque senza la presenza del pubblico) e consente, in via d’eccezione alla regola generale, l’acquisizione di una prova in via anticipata, rispetto alla sede naturale del pubblico dibattimento, ovvero durante le indagini preliminari. La predetta prova, ben inteso, dovrà essere ritenuta dal giudice ammissibile e rilevante ai sensi dell’art. 190 c.p.p per poter essere posta a base della decisione.
La funzione di questo istituto è, dunque, quella di assumere una prova in via anticipata, ovvero in una fase pregressa rispetto al contraddittorio processuale, non essendo possibile, o essendo pericoloso, attendere sino al dibattimento per la sua acquisizione. In sede di incidente probatorio, le prove vengono assunte con le stesse modalità previste per il dibattimento. Le prove di tipo dichiarativo (testimonianze e confronti) sono assunte tramite un esame incrociato, nel contraddittorio delle parti, ovvero alla presenza di tutti gli antagonisti della vicenda processuale (qui si fa riferimento specifico al pubblico ministero ed al difensore dell’indagato). Gli organi competenti all’assunzione probatoria sono il GIP, ovvero il Giudice delle indagini preliminari, ed il GUP ovvero giudice dell’udienza preliminare (rispettivamente l’uno o l’altro a seconda che frattanto sia stata fissata o meno l’udienza preliminare) ed infine il giudice incaricato nel dibattimento, in una fase anteriore a quella finalizzata all’istruttoria dibattimentale (ovvero prima dell’inizio dell’istruttoria dibattimentale).
Come abbiamo già avuto modo di dire, il diritto processuale penale italiano prevede che tutti gli elementi di prova raccolti durante la fase delle indagini preliminari, vale a dire nella fase meramente procedimentale condotta dal PM e sorvegliata e governata dal GIP, non possano essere successivamente utilizzati, salvo eccezioni, nel dibattimento (ciò, volutamente, ad evitare che la prova si formi nel segreto degli uffici della procura o della polizia giudiziaria, lontano dai riflettori dell’udienza, fuori dal contraddittorio delle parti e dal controllo di un giudice terzo ed imparziale e senza la partecipazione del difensore dell’indagato). Al contrario, con l’incidente probatorio, in via d’eccezione, il pubblico ministero (anche su sollecitazione della persona offesa) e la difesa dell’indagato possono chiedere l’assunzione anticipata dei mezzi di prova nella fase procedurale precedente al dibattimento. Si tratta di una sessione d’indagine a cui partecipano, oltre al Giudice, le parti costituite con i loro avvocati. Tale sessione d’indagine, garantita quanto all’imparzialità dalla presenza di un giudice terzo che celebra l’udienza, a differenza dei normali atti investigativi del pubblico ministero e della polizia giudiziaria, conduce alla formazione di una prova utilizzabile nel successivo dibattimento. Trattasi, in altre parole, di un’udienza che apre una parentesi processuale (un inciso, da qui il nome dell’istituto) in una fase meramente investigativa e preprocessuale. Introduce, per sua natura, una prova “cristallizzata” e non ripetibile.
Questa acquisizione anticipata della prova, prevista come rigorosa eccezione ai principi generali, viene richiesta dalle parti, allorché appaia inopportuno differirne l’assunzione ad un dibattimento futuro, magari lontano nel tempo, a causa del rischio concreto che, nell’attesa, la fonte di prova possa compromettersi o venga meno la sua genuinità.
L’articolo 392 c.p.p. disciplina l’istituto dell’incidente probatorio sia con riferimento alla procedura sia con riferimento ai mezzi di prova assumibili:
- la testimonianza e il confronto, se vi è fondato motivo di ritenere che il dichiarante non potrà deporre in dibattimento a causa di una infermità, di un altro “grave impedimento”, o, sulla base di elementi gravi e specifici, perché esposto a minaccia, violenza o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al teste membro di una associazione per delinquere di stampo mafioso che si sia determinato a collaborare al fine dell’accertamento dei fatti);
- l’esperimento giudiziale e la perizia “breve” aventi ad oggetto persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a “modificazione non evitabile”;
- la perizia di lunga durata, che, se disposta durante il dibattimento, determinerebbe una sospensione del processo superiore a sessanta giorni;
- la ricognizione ove particolari ragioni d’urgenza non consentano di rinviare l’atto al dibattimento.
Inoltre, vi sono mezzi di prova che possono essere assunti su mera richiesta di parte:
- l’esame dell’indagato che debba deporre su fatti concernenti la responsabilità altrui;
- l’esame dell’imputato (o indagato) per reato connesso o collegato;
- su richiesta del difensore, la testimonianza o l’esame delle persone che si sono avvalse della facoltà di non rispondere in sede di indagini difensive;
- la testimonianza di un minore di sedici anni in procedimenti per delitti di violenza sessuale, tratta di persone o assimilati. Lo scopo, in quest’ultima ipotesi, è quello di permettere un serio vaglio della credibilità/attendibilità della deposizione prima che la memoria del dichiarante subisca deformazioni (il rischio è grave poiché trattasi di persona minore d’età).
Dieci consigli pratici al penalista
Sono consigli tratti da esperienze personali. Scusate per la evidente incompletezza.
Prescrizione
La prescrizione è un istituto giuridico previsto dal diritto penale italiano e può essere annoverato tra le cause di estinzione del reato. Obbedisce al principio per cui, decorso un rilevante lasso di tempo dalla commissione di un reato, predeterminato dal legislatore in relazione ed in proporzione alla gravità del fatto, non v’è più un interesse sociale e collettivo alla sua punizione, sia in ragione del fatto che nella coscienza sociale è perduta la memoria dell’illecito nonché l’allarme per la pericolosità del suo autore, sia dal momento che il reo è, nella sostanza, ormai una persona diversa da quella che l’ha commesso.
Previsto all’art. 93 del Codice Zanardelli, l’istituto della prescrizione venne poi disciplinato dal codice Rocco e modificato dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 e da ulteriori interventi normativi.
La prescrizione può riferirsi a due ambiti:
- la prescrizione di un reato, ex art. 157 c.p.;
- l’estinzione della pena per decorso del tempo, o «prescrizione della pena», ex artt. 172 e 173 c.p.
Entrambi gli istituti si fondano sul presupposto che la pretesa punitiva dello Stato debba affievolirsi, fino a scomparire, quando sia decorso un determinato (rilevante) periodo di tempo dalla commissione del fatto senza che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna ovvero l’esecuzione della pena. I due istituti, tuttavia, sono tra loro concettualmente differenziati: la prescrizione di un reato si nutre della convinzione che la risposta sanzionatoria ad un crimine, verificatosi in un passato ormai remoto, perda la sua giustificazione, sul piano general-preventivo (l’oblio rende inutile l’accertamento delle responsabilità); la cosiddetta prescrizione della pena, invece, si fonda sull’idea che sia incongruo far eseguire una pena nel caso in cui dalla pronuncia del provvedimento di condanna (o dalla sottrazione volontaria del reo all’esecuzione della pena) sia decorso un periodo di tempo da ritenersi eccessivo.
Il primo istituto, pertanto, incide sul diritto penale sostanziale, mentre il secondo sull’esecuzione della pena.
Con l’istituto della prescrizione, si intende evitare che la macchina giudiziaria continui a impegnare risorse per la punizione di reati commessi troppo tempo prima e per i quali è socialmente meno sentita l’esigenza di una tutela giuridica penale, e ciò anche nell’ottica della funzione socialmente rieducativa della pena (art. 27 Cost.).
Inoltre l’istituto assolve, nelle intenzioni del legislatore, alla funzione di garantire l’effettivo diritto di difesa all’imputato. Col passare del tempo, infatti, è sempre più difficile per lo stesso imputato individuare ed indicare fonti di prova a suo favore (si pensi alla difficoltà di ricordare l’identità di testimoni o di reperirli o di conservare documentazione attestante la lontananza dell’imputato dai luoghi teatro dei fatti criminosi come biglietti aerei, scontrini di ristoranti, tiket di parcheggi etc). L’istituto della prescrizione, infine, contribuisce all’attuazione del principio di ragionevole durata del processo.
Secondo l’art. 157 del codice penale italiano, il tempo necessario a prescrivere un reato varia in considerazione della pena massima stabilita per lo stesso reato. I reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo (in primis l’omicidio aggravato) non sono prescrittibili. L’art. 157 del codice penale, modificato dalla legge 5 dicembre 2005 n. 251, prevede che la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Detti termini, tuttavia, ricominciano a decorrere col verificarsi di determinati eventi interruttivi espressamente indicati dal codice penale (come la convocazione dell’indagato per l’interrogatorio, la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, la sentenza di condanna etc), ma senza poter mai superare il tempo prescritto aumentato di un quarto (ad esempio: nel caso del tempo per la prescrizione fissato in sei anni, detto termine diverrà di sette anni e sei mesi in presenza di eventi interruttivi, anche plurimi).
Per determinare il tempo necessario alla prescrizione non vengono considerate né le attenuanti né le aggravanti, eccezion fatta per le aggravanti a effetto speciale (che aumentano la pena di oltre un terzo) e per quelle per le quali la legge stabilisce una pena diversa (ad esempio, ergastolo anziché reclusione: si pensi all’aggravante della premeditazione che rende l’omicidio volontario imprescrittibile poiché punito con la pena massima dell’ergastolo); in tali casi si tiene conto dell’aumento massimo della pena prevista per l’aggravante. Quando la legge prevede per un reato sia una pena detentiva sia una sanzione pecuniaria, la prescrizione si calcola sulla base della sola pena detentiva. La legge, in determinate fattispecie, può prevedere una pena alternativa a quella detentiva e pecuniaria: in tal caso la prescrizione matura in tre anni. La prescrizione è espressamente rinunciabile dall’imputato (art. 157 cp.). Infatti costui, anche per evitare una separata causa civile di danni, può preferire una sentenza che accerti la sua estraneità al fatto rispetto ad una pronuncia che, senza entrare nel merito e dunque lasciando un sospetto di colpevolezza, si limiti ad accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’asserito reato. In effetti, la pronuncia d’accertamento di intervenuta prescrizione non equivale ad un’assoluzione con formula piena, anche se gli effetti per l’imputato possono sembrare identici.
I termini di prescrizione sono stati modificati con la legge n. 3 del 9 gennaio 2019 (cosiddetta “Legge spazzacorrotti”), che ha introdotto la sospensione del corso della prescrizione stessa, dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia di condanna sia di assoluzione) o dal decreto penale di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del decreto penale. La norma è entrata in vigore il primo gennaio 2020.
La disciplina della prescrizione è ulteriormente mutata nel corpo della c.d. riforma Cartabia, modellandosi come segue:
il corso della prescrizione (ex art. 157 c.p.) si interrompe definitivamente con la sentenza di primo grado, sia essa di assoluzione o di condanna, e qualora la sentenza venga annullata, con regressione del procedimento al primo grado, la prescrizione riprende il suo corso dalla pronuncia definitiva di annullamento.
Tuttavia, qualora l’eventuale giudizio di appello non si concluda entro il termine di due anni, e quello di Cassazione entro un anno, salvo giudizi di impugnazione particolarmente complessi prorogabili di un anno in secondo grado e di sei mesi in Cassazione, l’azione penale viene dichiarata improcedibile.
Per i reati ad elevato allarme sociale, quali i delitti aggravati dal metodo mafioso, il termine può essere prorogato a tre anni per l’appello e ad un anno e sei mesi per la Cassazione; per i reati di terrorismo, violenza sessuale aggravata e traffico di stupefacenti, le proroghe possono essere concesse senza limiti.
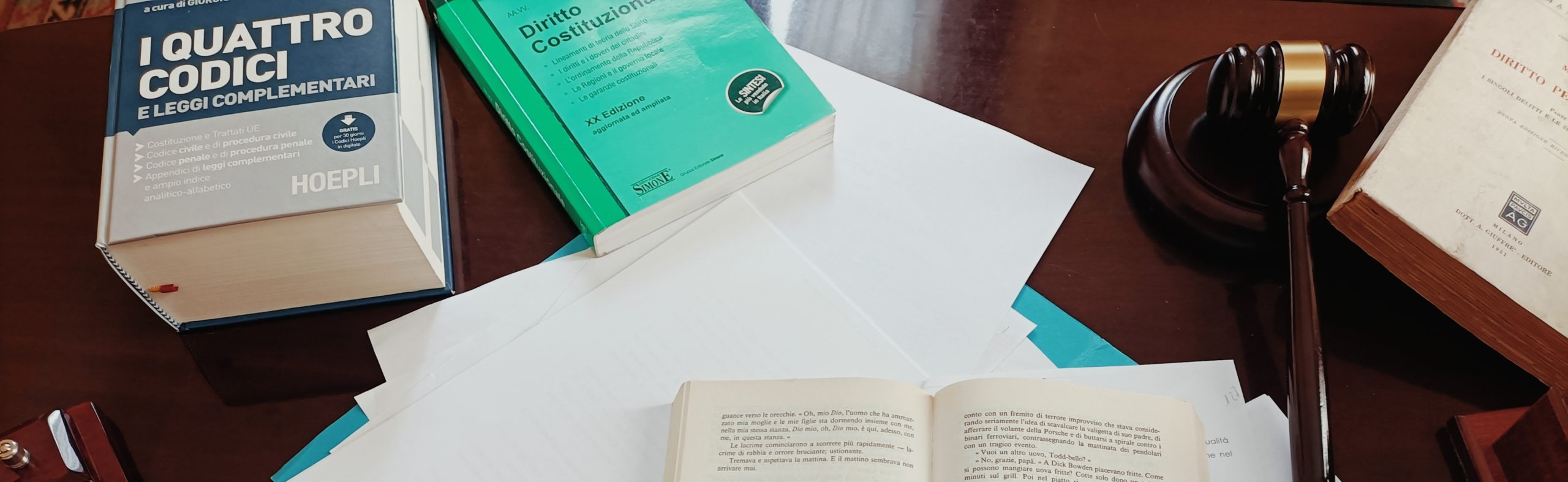

pharmacy online prescription