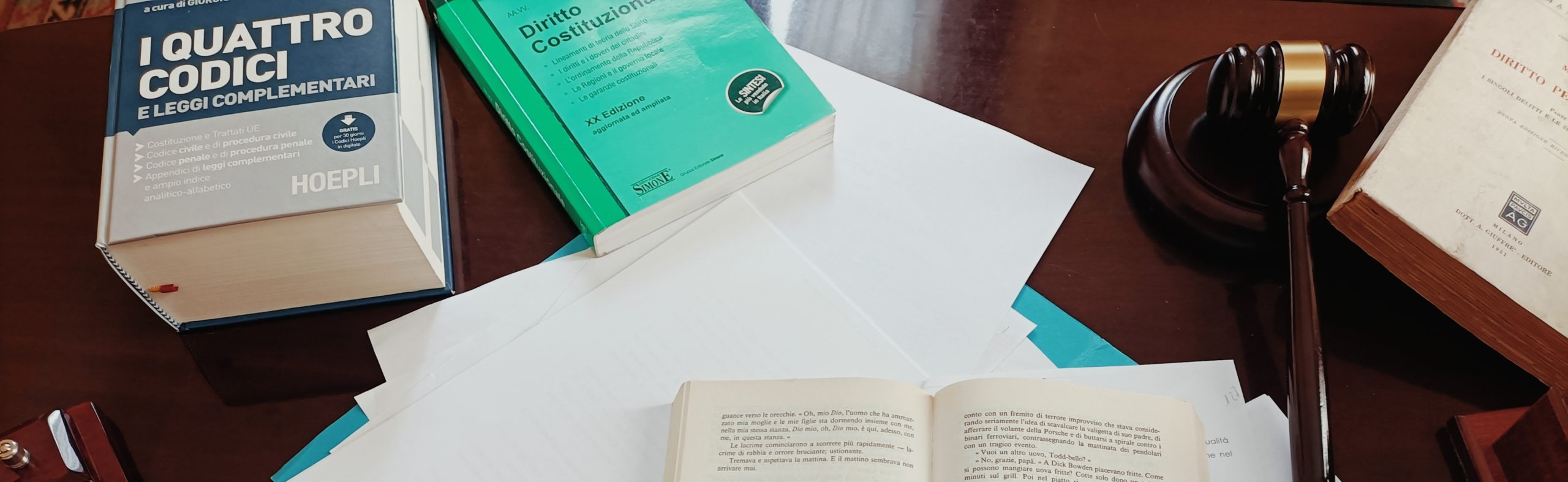Diritto Penale
Voglio vincere
Dopo accurate ricerche, con Claudio decidemmo di prendere in affitto un trilocale con bagno, in Viale Papiniano, a due passi dal carcere di San Vittore e dallo studio di mio zio.
La stanza sulla destra rispetto all’ingresso, più luminosa dell’altra, sarebbe spettata a me e quella a sinistra a Claudio, che non amava né il caldo né la luce.
C’era anche una piccola sala d’aspetto, con una postazione lavorativa per un praticante che avremmo ingaggiato più avanti, una volta fatto con precisione il conto delle spese. Fu questo il compromesso che trovammo.
In verità Claudio avrebbe rinunciato alle prestazioni di un collaboratore, per risparmiare i quattrocento euro mensili che l’ordine degli avvocati consigliava di garantire ai neolaureati che iniziavano la pratica. Io invece quei soldi li avrei spesi volentieri, anche solo per il gusto, finalmente, di poter comandare qualcuno a bacchetta, come avevano fatto gli altri con me. L’idea di avere un sottoposto costretto a correre e ad affannarsi al mio posto, stuzzicava il mio orgoglio ferito da tante umiliazioni. Sarebbe stata una specie di rivincita, dopo il senso di inadeguatezza provato al cospetto di zio Arturo.
Uno stretto e buio corridoio conduceva dall’ingresso al bagno. A metà del disimpegno c’erano due grandi classificatori neri, uno destinato a custodire le mie pratiche. Quelle di Claudio erano molto più numerose e riempivano per intero il secondo classificatore. All’inizio avremmo gestito due attività separate, in attesa di valutare se costituire una vera e propria associazione, che avrebbe fatto molto più comodo a me che a lui.
Organizzammo anche una festicciola d’inaugurazione per pochi intimi, un venerdì sera. Claudia per l’occasione aveva sfornato addirittura tre torte.
Mentre Claudio stappava l’ennesima bottiglia di prosecco, mi si avvicinò un compagno di liceo, Fulvio Rigon. A scuola eravamo una forza, io gli permettevo di copiare le mie versioni di latino e lui mi passava, con la rapidità di un fulmine, le soluzioni dei test di matematica, materia nella quale ero davvero negato.
Fulvio mi sembrò in gran forma, con i muscoli tirati a lucido in palestra. Mi disse che aveva aperto un negozio di sigarette elettroniche ed altri prodotti che godevano di ottimo mercato. Poi mi sorrise con occhio complice. «Devo passarti un cliente, un imprenditore, ottimo pagatore. Ha un brutto penale sulle spalle».
Lo ringraziai e gli diedi il mio nuovo biglietto da visita, appena ritirato in stamperia.
Il Signor Francesco Trotta venne in studio tre giorni dopo, con un ordinato faldone di carte sotto il braccio. Era riuscito a ritirarle di persona in Procura, senza l’aiuto di nessuno, dopo la conclusione delle indagini preliminari.
Si rannicchiò sulla sedia, all’altro capo della scrivania, con lo sguardo colpevole di chi è già pronto ad implorare la clemenza della corte.
«Ho letto che in Italia non si va in carcere per pene inferiori ai quattro anni. Vero, avvocato?».
Lo scrutai con sospetto. Non ho mai amato chi si improvvisa conoscitore di una materia complessa, nella quale non ha alcuna competenza. «È vero». Risposi asciutto. «A meno di non essere considerati socialmente pericolosi. Se poi si hanno problemi di alcool e droga e si accetta di seguire un programma di trattamento si evita il carcere anche per pene fino ai sei anni».
«Grazie avvocato. Si vede che lei è molto preparato. D’altra parte mi hanno parlato benissimo di lei». Sorrise e per un attimo sembrò sollevato. Ma un istante dopo prese a divorarsi le unghie e a tormentarsi le mani.
Diedi una rapida scorsa al fascicolo, divertendomi a far correre lo sguardo dalle carte della procura allo sguardo contrito di quell’uomo gentile ed apparentemente remissivo.
Vidi che l’imputazione era grave: maltrattamento continuato nei confronti della moglie (1); articolo 572 del codice penale, con pena massima prevista fino a sette anni.
C’era in atti una querela sporta verbalmente dalla donna, infarcita di accuse di ripetute aggressioni fisiche subite dal marito, con schiaffi, calci, pugni e strattoni. La signora parlava anche di imprecisati insulti, che definiva pressoché quotidiani. Notai subito che, a seguito della querela verbalizzata presso la caserma dei carabinieri, la signora era stata sentita una sola volta da un ispettore di polizia giudiziaria, negli uffici al palazzo di giustizia. In tale occasione la querelante non aveva fornito ulteriori particolari rispetto a quelli già descritti in precedenza.
Notai che in atti non era stato acquisito alcun certificato medico e che i fatti denunciati non erano stati collocati con precisione nel tempo e nello spazio. Non si comprendeva quando le supposte aggressioni fossero avvenute, né in quale luogo. La signora diceva soltanto di essere stata colpita la sera, dopo che il marito era rincasato in palese stato di ebbrezza.
Sollevai lo sguardo dalle carte, con in volto un’espressione trionfale. «Ce la giochiamo!».
Il mio cliente ebbe un sussulto e sembrò rianimarsi. «Cosa intende dire, avvocato?».
«Intendo dire che al processo conto di far cadere le accuse nei suoi confronti». Ebbi il vago sospetto di essere stato incauto, ma ormai avevo deciso di sollevarmi dalla seggiola per raggiungere il centro del ring, battendo i guantoni l’uno contro l’altro, pronto allo scontro col pubblico ministero.
«Lei dice?». La voce bassa e sofferta del mio assistito strideva con la mia, che sembrava possedere il fragore di uno sparo.
«Io dico!». Replicai, con la stizza che prova il professionista che ha la sensazione di non trasmettere al cliente sufficiente fiducia.
Gli dissi che a mio giudizio le accuse erano generiche e non riscontrate da alcuna prova, né da documenti né da dichiarazioni di terze persone.
Il Signor Trotta non sembrò convinto e strinse le mani l’una nell’altra. «Ho sentito parlare del giudizio abbreviato, avvocato. Una forma di processo rapido che prevede uno sconto di pena. Dico bene?».
Fui punto sul vivo e scattai come una molla al massimo della carica. «Chi le ha parlato del giudizio abbreviato?».
Il cliente sembrò spaventarsi ed agitò le mani, come volesse cancellare le sue stesse parole. «Avvocato, non si allarmi. Lei ha tutta la mia fiducia. Seguirò i consigli che mi darà».
Strinsi i pugni, al riparo della scrivania. “Eccolo” pensai “quello che si fa il suo giretto interculturale sul web e poi viene a farmi la sua lezioncina di diritto usa e getta!”.
Scossi la testa. «Non glielo consiglio proprio il giudizio abbreviato. Lei può essere assolto!». Gli spiegai che il giudizio abbreviato garantiva sì lo sconto di pena di un terzo ma, essendo una definizione allo stato degli atti, aveva anche pesanti controindicazioni, come la rinuncia a far sentire testimoni o a controinterrogare la querelante per farla cadere in contraddizione o evidenziarne imprecisioni o buchi di memoria.
Lui sembrò convincersi e mi sorrise. «Mi fido di lei, avvocato». Io lo congedai chiedendomi se fosse sincero e, soprattutto, se il suo cenno al giudizio abbreviato non significasse che aveva altri consulenti legali oltre a me.
Dopo che l’ebbi accompagnato alla porta, sprofondai nella mia poltrona esausto, come se l’anima del pugile pronto al combattimento fosse evaporata dal mio corpo all’improvviso.
Mi stupii dell’aggressività orgogliosa che avevo manifestato durante quel colloquio e che non apparteneva alla mia personalità, o almeno non a quella che ero solito esibire in pubblico, nelle mie relazioni sociali.
Sapevo bene che dentro ciascuno di noi c’è una sorta di doppio che combatte, nel buio, contro ogni forma di compromesso e per la liberazione del puro istinto dall’educazione che ci hanno inculcato e dalle convenzioni /costrizioni sociali. Quell’altro me stesso, non necessariamente peggiore della versione educata ed adattiva, da appassionato di fumetti, mi divertivo a chiamarlo: Alessinik.
Ecco, nel colloquio appena concluso, Alessinik aveva prevalso sul composto e remissivo Alessio Mayer e sembrava che gli avesse urlato in faccia. “Non puoi sempre soffocarmi!”.
Lanciai occhiate tutt’attorno: le pareti erano ancora disadorne, con appeso solo il diploma di laurea nella cornice di legno.
La mia stanza era piccola ma, dopo le umiliazioni subite quand’ero al servizio di zio Arturo e di Paola Goggi, mi sembrava un vero e proprio regno.
Forse era questo il punto: lì dentro mi sentivo padrone del mio destino, un vero avvocato e non un semplice collaboratore e dunque non ero più disposto a tollerare che qualcuno mi suggerisse cosa avrei dovuto dire o fare.
Bussai alla stanza di Claudio, per proporgli di andare insieme a pranzo. Quando ci trovammo sulle scale, mi volsi a scrutare con orgoglio la targa di ottone
STUDIO LEGALE
Avvocato Claudio Chiodi
Avvocato Alessio Mayer
Era proprio vero, allora: avevo costruito, con l’aiuto del mio migliore amico, un pezzo del mio futuro. D’ora innanzi il senso di responsabilità avrebbe controbilanciato la libertà di fare ciò che avrei ritenuto più giusto.
Il giudice dell’udienza preliminare sollevò di scatto gli occhi dalla tastiera del suo computer. «Avvocato Mayer, ci sono richieste di riti alternativi?».
Volsi lo sguardo di lato e scrutai il Signor Trotta, che aveva le mani intrecciate e batteva con nervosismo il piede a terra. Riconobbi nei suoi occhi un’espressione implorante, come volesse dire: “Signor Giudice, la prego, mi liberi da questo tiranno che mi siede accanto…ABBREVIATO…TUTTA LA VITA ABBREVIATO…”.
«Non ci sono richieste di riti alternativi, Signor Giudice. In dibattimento proveremo l’innocenza dell’imputato». Tuonai invece io, deciso ad andare per la mia strada ed a vincere il processo.
Sentite le conclusioni mie e del pubblico Ministero, il Giudice ci invitò ad attendere qualche minuto lungo il corridoio.
Quando ci fece accomodare di nuovo all’interno dell’aula, annunciò la data della prima udienza del futuro processo: tre marzo, ore nove e trenta, in aula nove.
Allorché fummo usciti dal palazzo di giustizia, sul lato di via Freguglia, il mio cliente cominciò di nuovo a mordersi le unghie e a borbottare parole preoccupate. «Cosa dice, avvocato? Come andrà? Forse era meglio chiedere l’abbreviato?».
Lo incenerii con lo sguardo, perché detestavo sia ripetere cose già dette sia il fatto che si mettesse in dubbio l’autorevolezza delle mie parole e della mia professionalità. Davanti ad una tazza di caffè, al bar sul lato opposto della strada, mi esibii in una filippica sul diritto di difesa e su come tale garanzia spettasse a tutti i cittadini, senza distinzione. «Oggi si fa presto a credere a qualsiasi querela fatta da una donna che racconta d’essere stata picchiata o offesa o maltrattata e a condannare gli uomini, anche per un’innocente pacca sul sedere. L’abbreviato? In un caso come questo proprio no, sarebbe una rinuncia al diritto costituzionalmente garantito alla difesa in giudizio. Ci mancherebbe pure che un brav’uomo come lei possa essere condannato, senza un solo certificato medico, e per le accuse di una donna che non sa dire neppure dove e quando è stata picchiata. Siamo in Italia e non nella repubblica delle banane. Abbia fede nella giustizia!».
Quando ebbi terminato il mio comizio, incrociai di nuovo lo sguardo del cliente, che mi sembrò ancor più allarmato. «Avvocato« miagolò «nel mio caso non parliamo di una pacca sul sedere, ma di cose molto più gravi. Quando mi ubriaco io non mi controllo più, ecco…».
Lo fissai sgomento, con gli occhi vitrei di un fantasma e pensai: “beh, che cos’è questa? Una confessione per mettere in difficoltà l’avvocato?”.
Lo spinsi fuori dal bar, senza lasciargli neppure finire il suo caffè, terrorizzato dalla prospettiva che quel processo potesse sfuggire al mio controllo. «Signor Trotta, si ricordi che tra qualche mese inizierà il processo e lei sarà esaminato dal Giudice. Lei dovrà negare i fatti, sempre e comunque. Se non lo farà lei rovinerà il mio lavoro e si beccherà una terribile condanna. Allora tanto valeva fare un bel patteggiamento. Non le pare?».
Trotta parve convinto ed annuì. «Negherò tutto, certo. Loro non hanno prove…».
Gli posi le mani sulle spalle, con decisione. «Parole sante: non hanno prove! E non saremo noi a dargliele!»
Quando ci lasciammo, alla fermata del tram, su Corso di Porta Vittoria, la chiesa di San Pietro in Gessate si materializzò davanti ai miei occhi, instillandomi, con la sua sacralità, qualche dubbio di coscienza.
Sospettai che l’anima del pugile che guadagna il centro del ring si fosse impossessata della mia mente come un demone.
Mi chiesi se non stessi esagerando, nel tentativo di ostentare, a me stesso e forse anche agli altri, uno spirito vincente.
Temetti che il cinismo di zio Arturo avesse contaminato la mia indole bonaria. Era la prima volta che avvertivo in ogni atomo del mio essere il bisogno irrinunciabile di dimostrare al mondo di essere un GRANDE AVVOCATO. Forse perché da quel giorno in poi non avrei più vissuto di stipendi, ma solo di parcelle? Non più di impegno e di diligenza, ma di risultati?
E venne il giorno dell’udienza nella quale sarebbe stata sentita la signora Trotta, per confermare o smentire le dichiarazioni fatte in querela.
Quella mattina, in studio, avevo indugiato davanti allo specchio mentre indossavo la toga.
“Voglio vincere” mi ero ripetuto, con l’ossessività di un mantra, provando ad indurire lo sguardo al massimo. “Questa volta voglio pensare solo a vincere, o non sarò mai un vero avvocato, potrò ambire solo a fare il dipendente!”.
L’aula era deserta. Alle nove e trenta era in calendario solo il nostro processo.
La moglie del mio cliente passeggiava lungo il corridoio, in attesa di deporre. L’avvocatessa di parte civile mi aveva innervosito, chiedendomi in modo del tutto inopportuno: «Scusa collega, ma perché non hai fatto l’abbreviato?».
Le avevo rifilato un’occhiata tagliente. «Perché l’abbreviato è una scelta, non un obbligo!».
L’imputato era più nervoso che mai, non osava neppure sollevare lo sguardo da terra per l’imbarazzo.
Il giudice fece il suo ingresso in aula con un certo ritardo e la signora Trotta venne invitata a sedere al banco dei testimoni ch’erano già passate le dieci.
Dopo il pubblico ministero ed il difensore di parte civile, toccò a me porre domande.
«Signora». Chiesi con tono aggressivo. «Lei ha riferito tante aggressioni, tanti pestaggi, perché non è mai andata in un pronto soccorso a farsi medicare?».
«Avevo paura, quando mio marito faceva così…».
«Paura di cosa, Signora? Dei medici? Le vittime di violenza possono avere paura di fare denuncia, non certo di ricorrere alle cure dei sanitari!».
«…non è che proprio stessi male…».
«Non è che proprio stessi male?». Ripetei con enfasi, mentre lanciavo occhiate provocatorie al pubblico ministero. «Cosa significa, signora? Forse che le presunte aggressioni non erano poi così brutali?».
La donna piegò la testa di lato. «Brutali, in effetti, è una parola eccessiva!».
«BRUTALI E’ UNA PAOLA ECCESSIVA!». Guardai negli occhi il giudice, con fierezza. “Sta crollando” pensai “Devo solo completare l’opera…”. Alessinik aveva preso il sopravvento su Alessio, con i suoi occhi da tenerone ed il suo sguardo da bambino. Mi sembrò di tornare ragazzo, quando ai videogiochi dovevo distruggere ogni mostro che appariva sul display.
«Signora, lei deve dire a questo tribunale, con precisione assoluta, data ora e luogo di ciascuna di queste aggressioni non brutali che afferma di avere subito…».
«Non ricordo avvocato!».
«Chi fa una querela e poi siede al banco dei testimoni non può permettersi di non ricordare. Questo è inaccettabile!».
Mentre mi lanciavo all’assalto della preda, con occhi da tigre, sentii il mio cliente sussurrare. «Basta, avvocato, basta…basta…».
Poi successe l’incredibile. Trotta scattò in piedi, in balia di una sorta di crisi mistica. «Luciana, ti chiedo perdono, sono stato un animale, lo so!». Poi si rivolse al giudice, un istante prima di prorompere in un pianto sfrenato. «Ammetto le mie colpe, signor Giudice, chiedo l’abbreviato, il patteggiamento, il minimo della pena, la clemenza della corte…tutto quello che c’è scritto nel codice per uno che si pente! Sono colpevole!». Infine lanciò alla moglie uno sguardo disperato. «Mi sto curando, Luciana. Ho iniziato la terapia al NOA. Per favore, perdonami…torna da me!».
Il Giudice mi guardò con aria sgomenta. «Avvocato, sospendo l’udienza. Dica al suo assistito di calmarsi e che terrò conto delle sue nobili dichiarazioni!»…
Un’ora dopo percorrevo a passo di lumaca, il corridoio fuori dall’aula. Dopo tutto era andata bene: attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, minimo della pena: due anni con la condizionale perché l’imputato era incensurato.
Mi guardai alle spalle: Trotta era fuori dall’aula, in ginocchio davanti alla moglie e le mostrava i fogli del nucleo operativo contro l’alcolismo in cui si parlava dei progressi che stava facendo.
Appoggiato alla colonna di marmo, nell’atrio, mi comparve davanti agli occhi la sagoma di Zio Arturo, con la sigaretta in bocca.
Mi avvicinai a lui. «Ho sbagliato. Avrei dovuto fare l’abbreviato!».
«Forse hai sbagliato. O forse con l’abbreviato, senza la scena madre di oggi, il nostro amico si sarebbe beccato più di due anni, perdendo il diritto alla condizionale!».
«Ho pensato più a me stesso che al cliente, vero?».
«L’avvocato è un sarto. Deve cucire il vestito su misura per i bisogni del cliente, dopo averlo ascoltato con attenzione».
Quando misi piede in Via Freguglia, lo zio era scomparso come una bolla di sapone. Camminai con rapidità, fino a che sullo sfondo comparve la solita chiesa.
Allora pensai che le lezioni della vita, quando gli errori si pagano davvero, valgono molto di più.
Reato di maltrattamento ex art. 572 c.p
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.
Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.
Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato“.
Il capo IV del titolo VII del libro secondo del codice penale, avente ad oggetto la repressione dei delitti contro l’assistenza familiare, prevede e punisce reati contraddistinti dal fatto che l’offesa viene originata all’interno del gruppo familiare, a salvaguardia del legame giuridico tra persone appartenenti alla stessa famiglia o legate da un vincolo ad essa assimilabile.
I maltrattamenti in famiglia sono sussumibili nella categoria dei reati propri, in quanto la fattispecie criminosa può essere commessa solamente da persone avvinte da un particolare rapporto (di parentela e/o di convivenza, ovvero di affidamento per le ragioni indicate nella norma) col soggetto passivo.
La ratio ispiratrice della disposizione si incentra sull’esigenza di proteggere da qualsiasi forma di sopraffazione gli stabili vincoli affettivi. I suddetti vincoli possono discendere, oltre che da un rapporto familiare, anche da un rapporto di autorità, derivante dallo svolgimento di una professione, di un’arte ovvero da rapporti di cura e di custodia. Tuttavia è bene dire che la quasi totalità dei reati in parola registrati nella pratica forense sono da ricondurre all’alveo familiare e a prepotenze/violenze ed abusi perpetrati a danno dei figli ovvero del coniuge (queste condotte sopraffattrici, al pari della violenza di genere, rappresentano oggi motivo di vero e proprio allarme sociale).
Il delitto di maltrattamenti è un reato abituale, caratterizzato da condotte vessatorie sistematiche di per sé, in rari casi, persino astrattamente in parte lecite, ma che assumono carattere illecito in ragione del loro protrarsi e del loro fondersi in unità. Le condotte possono essere sia commissive sia omissive (nel caso sussistano, a tale ultimo proposito, in capo al soggetto omittente dei doveri di protezione).
Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di infliggere una serie di sofferenze alla vittima.
La norma punisce le condotte, reiterate nel tempo, che siano volontariamente lesive dell’integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di una persona della famiglia, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all’autorità del soggetto agente o sia a lui affidata.
La norma in esame si inserisce nell’alveo della tutela dei soggetti vulnerabili, termine con cui si fa riferimento a quelle situazioni in cui la vittima, per la propria inferiorità fisica psichica o sociale, non ha altra scelta se non cedere all’abuso. Il legislatore italiano, infatti, in seguito alla ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007 ha accordato una sempre maggiore tutela a tali endemiche condizioni di fragilità.
Proprio in quest’ottica, l’attuale tenore letterale dell’art. 572 del c.p. è il risultato di diversi interventi normativi succedutisi nel tempo, primo tra tutti la riforma attuata con la l. n. 172/2012, la quale, non solo ne ha modificato la rubrica che prima faceva riferimento ai “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, ma ha anche inserito tra i possibili soggetti passivi del reato chiunque conviva con il soggetto agente.
La fattispecie in esame è stata, da ultimo, modificata dalla l. n. 69/2019, cd. Codice Rosso, che, nell’ottica del più efficace contrasto di episodi di violenza domestica, ne ha inasprito il quadro sanzionatorio, sia con riferimento alla fattispecie base di cui al comma 1, sia prevedendo, al comma 2, nuove circostanze aggravanti. Con la stessa legge il legislatore ha, altresì, previsto, all’ultimo comma, che il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato.
Il reato di maltrattamenti in famiglia è procedibile d’ufficio. Tale procedibilità pone l’azione giudiziaria al riparo dalla non infrequente ipotesi che la vittima, per lo stato di terrore in lei incusso dal carnefice, decida di rimettere la querela a suo tempo sporta per puro terrore di nuove violenze.
Essendo la pena massima prevista per tale odioso reato pari ad anni sette, è da escludersi, per l’imputato, la possibilità di chiedere prima dell’apertura del dibattimento la sospensione del processo con la messa alla prova (in vista dell’estinzione del reato per esito positivo della prova medesima).
Con la riforma del 2014, che ha mutuato l’istituto della messa alla prova dal processo minorile per estenderlo a quello ordinario a carico di imputati maggiorenni, si è infatti previsto che condizione per accedere al beneficio sia il fatto che si proceda per un reato punito con pena massima non superiore ad anni quattro (tale limite è destinato tuttavia ad essere innalzato a sei anni in relazione a fattispecie “che si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell’autore, compatibili con l’istituto”, come previsto dalla c.d. riforma Cartabia).
Dal reato di maltrattamenti va distinto il simile ma diverso delitto di Stalking.
Lo stalking (tecnicamente: atti persecutori) è un reato punito dall’art. 612 bis c.p.
Risponde di questo reato colui che si rende responsabile della perpetrazione di condotte persecutorie ripetute che incidono sulle abitudini di vita della vittima o generano in lei un grave stato di ansia o di paura. Il reato di stalking (dall’inglese to stalk, letteralmente “fare la posta”) è entrato a far parte dell’ordinamento penale italiano a seguito dell’approvazione del d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009). Trattasi di reato particolarmente odioso in quanto mira all’annientamento della personalità della vittima, mediante la sottoposizione della stessa a vessazioni sistematiche ispirate a sentimenti d’odio o di rivalsa. La fattispecie crimosa di cui parliamo implica la sottoposizione a sanzione penale di chiunque “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita“.
Come si evince dalla lettera della disposizione normativa, inserita nel capo III del titolo XII del Codice penale, nella sezione dei delitti contro la libertà morale, con tale nuova fattispecie di reato, il legislatore, prendendo atto del vasto allarme sociale circa la violenza di genere (giova precisare che nella stragrande maggioranza dei casi le vittime di questo reato sono donne) e della generale richiesta di protezione, ha cercato di dare una risposta sanzionatoria appropriata alle condotte che fino al 2009 venivano inquadrate in altri meno gravi delitti (di minaccia, violenza privata, etc.). Quest’ultime fattispecie di reato, così come previste e disciplinate, si erano rivelate spesso inidonee a garantire una tutela adeguata alle vittime a fronte di condotte illecite caratterizzate da maggiore gravità, sia per la reiterazione delle stesse, sia per i loro effetti devastanti sulla sfera privata e familiare delle persone offese.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l’autore di atti persecutori è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. Anche per tale ipotesi di reato, dunque, il reo non può accedere all’istituto della messa alla prova.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici (quest’ultima disposizione è ispirata ad un più generale tentativo di arginare il fenomeno del cyber reato, idoneo a sconvolgere l’intimità delle persone con la diffusione ad intere masse indistinte di persone di immagini ed apprezzamenti denigratori). La pena è aumentata fino alla metà (aggravante ad effetto speciale) se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 104/1992, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi dalla conoscenza del fatto (nel casi di violenza sessuale è elevato ad un anno). La remissione della querela può essere soltanto processuale. Ciò significa che la vittima non potrà rimettere la querela già sporta con dichiarazione fatta pervenire al pubblico ministero o alle forze dell’ordine ma dovrà recarsi in aula per verbalizzare la propria rinuncia all’azione penale. Inoltre dovrà farlo personalmente. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate o nei modi di cui all’articolo 612 bis, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio. Anche se la casistica in astratto enucleabile mostra che spesso vi è un rapporto di natura affettiva, sentimentale o comunque qualificato che lega il soggetto agente alla vittima (ad es. fidanzati o ex mariti gelosi) lo stalking è un reato comune che può essere commesso da chiunque, anche da chi, dunque, non abbia alcun legame di sorta con la vittima, senza presupporre l’esistenza tra le parti di interrelazioni soggettive specifiche (Cass. n. 24575/2012).
Ciò costituisce pertanto il discrimine con il più grave reato di maltrattamenti in famiglia.
Tuttavia, occorre sottolineare come anche il reato di cui all’art. 612- bis c.p. nell’ipotesi prevista dal secondo comma faccia riferimento ad ambiti latamente legati alla comunità della famiglia, poiché il soggetto attivo di questa forma aggravata di reato, avente natura di reato proprio, è individuato nel “coniuge legalmente separato o divorziato o in un soggetto che sia stato legato da relazione affettiva alla persona offesa”. Quanto al soggetto passivo, la norma oltre a tutelare la vittima “principale”, oggetto delle molestie dello stalker, estende la propria protezione anche a quanti sono legati alla stessa da rapporti di parentela (prossimi congiunti) o da relazioni affettive. Per quanto attiene, infine, al bene giuridico protetto, come si evince dalla stessa collocazione della norma incriminatrice, nel capo III del titolo XII tra i delitti contro la persona, il reato di atti persecutori tutela innanzitutto la libertà morale, intesa quale facoltà dell’individuo di autodeterminarsi liberamente e senza costrizioni.
La fattispecie incriminatrice mira, inoltre, a tutelare gli ulteriori beni giuridici dell’incolumità individuale e della salute, nonché secondo diverse tesi, la tranquillità psichica e la riservatezza dell’individuo, posto che ai fini della configurazione del reato “è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima” (Cass. n. 8832/2011).
In tale declinazione, la finalità perseguita dal legislatore del 2009 sarebbe, dunque, quella di tutelare il soggetto “da comportamenti che ne condizionino pesantemente la vita e la tranquillità personale, procurando ansie, preoccupazioni e paure, con il fine di garantire alla personalità dell’individuo l’isolamento da influenze perturbatrici” (Cass. n. 25889/2013).
Elemento costitutivo, ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 612-bis c.p., è innanzitutto, come dispone la norma, la reiterazione delle condotte persecutorie, idonee, alternativamente, a cagionare nella vittima un “perdurante e grave stato di ansia o di paura”, a ingenerare un “fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” ovvero a costringerla ad alterare le “proprie abitudini di vita”.
Il reato di stalking rientra, quindi, nella categoria dei reati abituali (Cass. n. 20993/2012), per la cui configurabilità sono sufficienti anche “due sole condotte di minaccia o molestia” come tali idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice (Cass. n. 45648/2013; Cass. n. 6417/2010). Quanto al contenuto di tali condotte, a titolo esemplificativo, si sottolinea come la giurisprudenza abbia ritenuto, in questi anni, atti persecutori idonei ad integrare il delitto di stalking anche comportamenti che non necessitano della presenza fisica dello stalker (Cass. n. 32404/2010), come: l’invio di buste, sms, e-mail e messaggi tramite internet, nonché la pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso sui social network (Cass. n. 14997/2012; Cass. N. 32404/2010); oltre, altresì, al danneggiamento dell’auto della vittima (Cass. n. 8832/2011). Costituiscono esempi di stalking, inoltre, anche le aggressioni verbali alla presenza di testimoni e i reiterati apprezzamenti, invii di baci e sguardi insistenti e minacciosi (Cass. n. 11945/2010).
Di certo, può considerarsi comportamento idoneo a configurare un’ipotesi di stalking il fare ripetute telefonate alla vittima, da questa ritenute non gradite (Cass. n. 42146/2011). In tal caso si parla, più propriamente, di stalking telefonico.
Per quanto concerne l’elemento soggettivo del reato è sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia descritte nella norma con la consapevolezza della loro idoneità a produrre taluno degli eventi parimenti descritti nella stessa (Corte Cost. n. 172/2014; Cass. n. 20993/2012; Cass. n. 7544/2012).
La reiterazione delle condotte, tuttavia, non è sufficiente da sola all’integrazione del reato, occorrendo che le medesime siano idonee a cagionare uno dei tre eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (non tutti contemporaneamente, anche uno solo), in base ad una valutazione di idoneità condotta in concreto dal giudice, sulla base della dimostrazione della configurabilità di un nesso causale tra la condotta posta in essere dall’agente e i turbamenti derivati alla vita privata della vittima” (Corte Cost. n. 172/2014; Cass. n. 46331/2013; Cass. n. 6417/2010).
Per gli abusi familiari e la violenza domestica, dal 1° marzo 2023 sono in vigore le nuove regole introdotte dalla Riforma Cartabia che accelerano i tempi delle procedure e rafforzano la tutela dei soggetti vulnerabili.
L’articolo 64 bis c.p.p. (introdotto con la c.d. riforma Cartabia) stabilisce che il giudice penale trasmetta “obbligatoriamente” e “senza ritardo” al giudice civile dei giudizi di separazione o di affidamento dei figli copia dei provvedimenti adottati nel procedimento penale per il delitto di violenza domestica o di genere, tra cui le ordinanze relative a misure cautelari personali, gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, i provvedimenti di archiviazione e le sentenze di condanna. Ciò al fine di consentire al Giudice civile competente l’adozione dei provvedimenti più idonei alla tutela delle famiglie e dei figli minori.
L’avvocato diligente, incaricato di assistere persona imputata del reato previsto e punito dall’art. 612 bis c.p., avrà cura, all’atto di controesaminare i testi del pubblico ministero o della parte civile ed, in particolare, la persona offesa dal reato, di porre domande finalizzate a chiarire:
- se la vittima del reato abbia patito ansia e/o paura effettive, perduranti nel tempo e gravi (diverse da un qualsiasi momentaneo disagio psicologico);
- ovvero un timore fondato e concreto per l’incolumità propria o dei propri cari;
- ovvero infine se la stessa abbia, in conseguenza dei fatti denunciati, modificato a fini di difesa personale le proprie abitudini di vita, adottando accorgimenti quali, a mero titolo esemplificativo: l’ingaggio di una guardia personale; il farsi accompagnare fuori di casa da una persona di fiducia; la modifica del percorso per andare al lavoro o degli orari di uscita/entrata da casa etc.
In difetto di risposte chiare in tal senso il difensore dell’imputato potrà sempre sostenere che il fatto non costituisce reato, mancando un elemento strutturale necessario al perfezionamento della fattispecie criminosa.
Ove, invece, il difensore sia incaricato di tutelare gli interessi della vittima di tale odioso reato, dovrà essere suo onere esortare la vittima a superare l’invisibile muro della paura e a denunciare il colpevole delle vessazioni, posto che la scelta di continuare a subire le prepotenze non può che rappresentare scaturigine di violenze sempre più efferate.