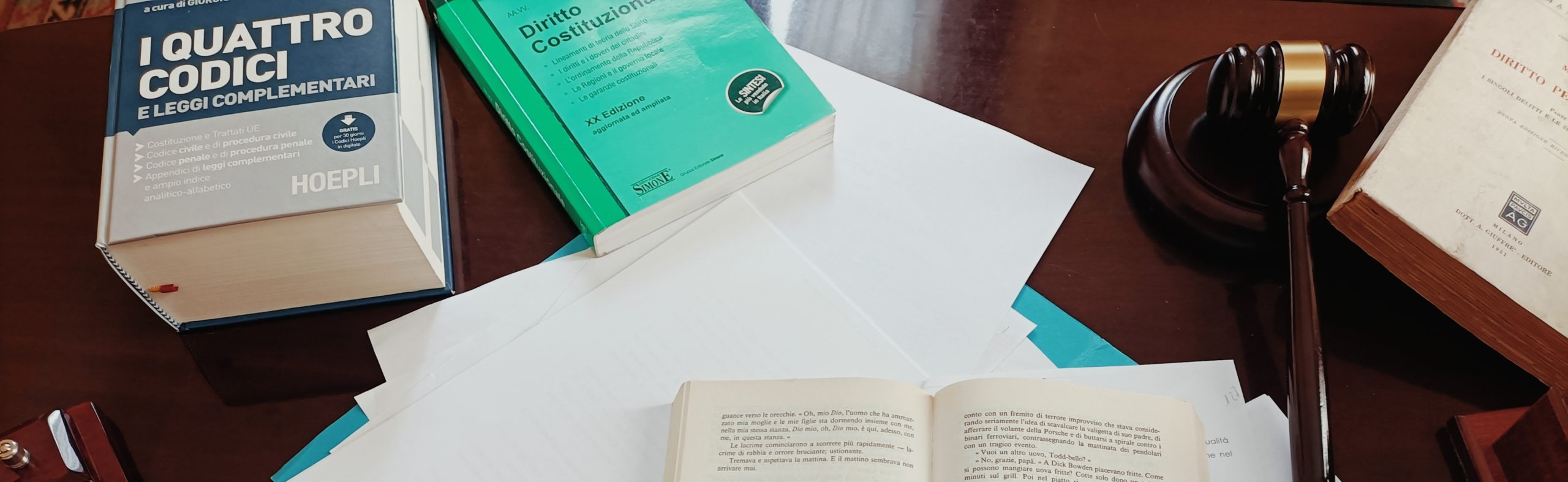Diritto civile e processuale civile
Casa mia
«Tu lavori troppo».
Squadrai Claudia con i miei occhi sospettosi, stando ben attento a non far cadere la forchetta. Il rumore avrebbe spezzato il silenzio di pietra degli altri avventori del ristorante, tutti mummificati in un’eleganza senza vita.
Quando Claudia si lamentava del tempo che trascorrevo in studio oppure a casa, ma con gli occhi rapiti dalle pratiche legali, era perché le frullava in testa una parolina: “viaggetto”.
In verità il diminutivo è fuori luogo, perché le mete agognate dalla mia ambiziosa fidanzata non erano né banali né tantomeno economiche.
Sondai il terreno, con prudenza. «Hai programmi?».
Il silenzio che seguì sembrò alimentare le mie speranze, ma alla fine la parola «Copenaghen» mi riportò alla realtà dei miei sospetti: Copenaghen, niente di meno, una delle città più costose d’Europa, dove rischi di spendere un capitale anche solo per mangiare salmone.
Mi guardai attorno, alla ricerca di un’ispirazione, ma il mio sguardo, dopo un breve volo, poté posarsi solo sui volti attempati di gente che non aveva i miei problemi, potendo contare su una meritata pensione.
«Amo, non posso programmare niente adesso…».
«E perché?». Eccolo l’immancabile suono capriccioso di una voce che non mi dava scampo.
«Perché in questo preciso momento sono a secco. Sto cercando di far entrare pratiche nuove. Dammi tempo e ti garantisco che dormiremo tutte le notti del nostro soggiorno danese al castello di Amleto!». Intanto un pensiero mi rodeva il cervello: “Lo sa che adesso non posso…perché mi umilia? L’amore non dovrebbe essere un’alleanza?”.
Lei sospirò, con l’aria comprensiva di un giudice che concede la sospensione condizionale della pena. «E va bene!».
Non feci in tempo ad afferrare il menù, per ordinare il vino, che lei squadernò una guida di Copenaghen, davanti ai miei occhi impotenti.
«Ho dato un’occhiata a questo alberghetto, vicino al porto. Ti piace?».
Sbirciai la fotografia che ritraeva un edificio bianco, sormontato da un paio di guglie svettanti, con balconi fioriti ed il luccicare azzurro di una piscina, che si scorgeva oltre una siepe.
Claudia piantò i pugni sul tavolo e si prese la testa tra le mani, impostando lo sguardo sulla modalità “cerbiatto”. «Ho visto anche i voli, sono molto economici!».
“Anche i voli?” pensai “eh no, questo è troppo. Conterò qualche cosa anche io! Oppure mi devo semplicemente sorbire il programmino preconfezionato?”.
Mi guardai attorno una seconda volta: “Ma perché dobbiamo sempre cenare in posti dove hai il terrore persino di masticare in modo troppo rumoroso?”. Quanto mi mancava il piatto comune dell’eritreo, vicino a casa!
«E va bene». Azzardai. «Prenderò in seria considerazione il tuo programma quando i miei clienti avranno finanziato l’operazione CLAUDIA. Contenta?».
Lei sorrise; che strano, non eccelleva per autoironia e di solito non amava granché le battute. Anzi le detestava per la stessa ragione per la quale io le ho sempre amate: fanno da schermo alle emozioni inesprimibili.
Quella sera rientrai a casa con un pensiero fisso: “Devo guadagnare stile zio Arturo, altrimenti sono un uomo morto!”.
Il giorno dopo sembrò persino andarmi bene: un nuovo cliente bussava alla mia porta.
Stavo bevendo una spremuta d’arancia al bar sotto lo studio, con la gazzetta dello sport tra le mani, quando squillò il cellulare.
«Ciao Alessio, sono Luca».
«Scusami. Luca chi?».
«Luca Borlotti, ricordi?».
“Oh, mio Dio, Luca Borlotti: l’inseparabile amico delle elementari che mi stracciava ogni singola volta ad ogni gioco in scatola, o a carte, o a freccette…”.
«Luca, accidenti! Quanto tempo. Come stai?».
«Male!».
Sobbalzai sulla sedia del bar e la gazzetta rischiò di cadere a terra. Ho sempre nutrito un sinistro fascino per quei pochi che alla domanda “come stai?” trovano la forza dirompente di risponderti col suono lugubre di quattro lettere M-A-L-E.
Una simile risposta ti gela e al tempo stesso ti scuote, spingendoti ad offrire il massimo dell’empatia. Il guaio di coloro che la pronunciano è la totale mancanza di rispetto per la tua libertà di pensare ad altro. È come se ti gridassero in faccia: “hai l’obbligo di ascoltarmi!” o peggio “sei pronto a subire ogni sorta di ricatto morale?!”. Superata l’inspiegabile suggestione di quella parolina crudele e desueta, mi verrebbe da replicare: “meglio a te che a me… questo male!”.
«Cosa ti è successo, Luca?».
«Grazia, mia moglie. Se n’è andata dai genitori. Ha portato con sé nostro figlio Giacomo. Mi sembra di impazzire!».
“Okay, allora devo vestire i panni dell’avvocato”. Provai pena per lui, ma anche per me stesso e per l’ennesimo caso umano che il destino mi aveva assegnato.
«Io l’ammazzo, se non torna!».
«Non dire così. Non drammatizziamo. Affrontiamo il problema con razionalità!». Pensai a quanto cambiano le persone, quando si fanno sconvolgere dal dolore. Il dolore è una spada che talvolta usiamo per recidere i legami, con una macabra predilezione per quelli a cui teniamo di più. Il mio compagno delle elementari non avrebbe detto di nessuno: “l’ammazzo”, neanche per scherzo. “Dio quanto cambia la gente”.
«Per favore, vieni a cena da me. Ho bisogno dei tuoi consigli».
«Sarebbe meglio in studio…».
«Sono troppo depresso. Non esco volentieri di casa…».
«E va bene». Quando chiusi la comunicazione pensai di avere sbagliato ad accettare. Non consiglierei a nessun mio collega di fare colloqui professionali a pranzo o a cena, a meno che si tratti di amici carissimi. Per far bene una consulenza legale occorre avere a disposizioni gli attrezzi del mestiere: pc, banche dati, carta e penna, codici e la concentrazione che solo la tua scrivania può darti.
Dopo avere risolto il dilemma “se porto qualcosa lo offendo?” citofonai al suo portone, con una vaschetta di gelato sotto il braccio.
Luca mi accolse in lacrime, con la barba incolta ed una specie di vestaglia addosso. Afferrò il telefono. «Che pizza ti ordino?».
«Una Diavola, grazie».
«Bevi del vino o della birra per caso?».
«Del vino, volentieri».
«Non ho niente, mi spiace!».
«Non importa». “Ma chi diavolo può invitare un ospite senza una bottiglia di vino in casa?”. Mi domandai costernato.
Suggerii di prendere appunti prima dell’arrivo della pizza, per non avere le mani sporche di pomodoro.
Mi feci raccontare la storia del loro matrimonio e lui sembrò un narratore preciso e pacato.
Si erano sposati in chiesa sei anni prima e Giacomo in quel momento aveva quattro anni. Avevano optato, con scelta audace ed anacronistica, per il regime della comunione dei beni (1) ma questo dato, a ben vedere, si rivelò un dettaglio trascurabile nella ricostruzione dell’assetto patrimoniale della famiglia: la casa in cui vivevano sfuggiva alla comunione perché era stata ereditata da Luca alla morte dei genitori; la villetta in montagna era stata donata dai suoceri di Luca a Grazia e dunque era di proprietà esclusiva della moglie.
Loro lavoravano gomito a gomito, follia quando si è sposati. Avevano costituito e gestito di comune accordo un’agenzia immobiliare denominata palazzi d’oro, “alla faccia dell’umiltà”. Erano soci al cinquanta per cento.
Lui mi afferrò un braccio. «Io e Grazia abbiamo gli stessi redditi. Non voglio darle un solo euro. Sia chiaro!».
Gli spiegai che il fatto di avere gli stessi redditi lo esonerava dal contribuire al mantenimento (2) della moglie, ma non a quello di Giacomo.
Lui si trincerò dietro un’espressione statuaria e a paroline che pronunci quando non hai argomenti. «Per ora offro zero. Che sia un giudice a stabilire quanto devo versare. Niente accordi. L’accordo è segno di debolezza». Trovai quest’ultima frase, se possibile, persino più stupida dell’altra: “l’ammazzo”.
Luca fu inarrestabile nella sua veemenza. «Se mi fa scherzi le porto via Giacomo, non m’importa un fico secco se intervengono i servizi sociali».
Gli spiegai che i minori non devono diventare merce di scambio, che non è bene esasperare il conflitto, che occorre collaborare affinché i bambini abbiano un padre ed una madre amorevoli, anche durante la crisi matrimoniale.
Precisai che ormai da anni la prassi consolidata era l’affidamento condiviso (3), con collocamento prevalente dei figli presso la madre e col diritto di visita paterno e che non sarebbe stato opportuno alterare questi equilibri.
Un istante prima della pizza, arrivò, con la rapacità di un falco, la domanda più drammatica. «Chi vivrà in questa casa?».
Tremai di paura, nel rispondere. «Se Giacomo, come penso, sarà collocato presso la mamma, lui e Grazia resteranno qui! La casa coniugale viene assegnata in godimento (4) al genitore presso cui viene collocato il figlio».
«A casa mia?!». Inveì, rosso di rabbia, ma fu l’ultimo sussulto. Poi si prese la testa tra le mani, raggomitolandosi sulla sedia. Il privilegio degli avvocati è che alla fine a crollare per primi sono sempre i clienti, con le loro “passioni” e le loro discutibili questioni di principio.
All’arrivo del cibo, però, ricominciò l’incubo. Non feci in tempo ad interessarmi ad un brandello di pizza che mi trovai la sua faccia furente ad un centimetro dalla mia. «Non voglio un avvocato, voglio una iena!».
Aspettai che si calmasse, impresa difficile senza un goccio di alcool, ed ebbi la cattiva idea, grave per uno come me che si vanta di avere nella tattica la sua unica dote, di chiedergli perché era andato in crisi il loro matrimonio.
«Lei ha un altro».
«Sai chi è?».
«Non lo so».
«Allora come fai a sapere che ha un altro?».
«Da come si comporta!». “Siamo a posto” mi dissi “siamo alle opinabili intuizioni tra coniugi”.
Mi chiese un preventivo per seguire il giudizio di separazione. Ammetto, senza imbarazzo, di aver avuto davanti agli occhi quell’hotel biancheggiante, con tanto di guglia sopra, e sparai. «Tremila euro!».
«Tremila euro? Anche se siamo amici?».
Non avevo voglia di litigare e dissi che ne avremmo parlato.
Alle ventitré decisi che non mi interessava neppure una pallina di gelato. Gli consigliai di metterlo in frigo. Dissi che il passo successivo sarebbe stato quello di valutare l’opportunità di un accordo, per una separazione consensuale (5). Proposi un incontro a tre, anche con Grazia, questa volta in studio.
Lasciai casa sua sospirando: “E’ finita finalmente”.
L’incontro collegiale avvenne nello studio legale Goggi, dieci giorni dopo.
Ebbi cura di avvertire Paola che il colloquio non sarebbe stato breve, promettendole di fermarmi fino a tardi per curare al meglio le sue pratiche.
Grazia mi sembrò una donna attraente, con occhi dolcissimi ad illuminare un volto pallido.
Si sedettero agli angoli opposti della scrivania, rinfacciandosi a vicenda di essere la causa della crisi coniugale.
«Tu mi tradisci».
«Non è vero».
«Hai un altro».
«Ho solo te».
«E tutti quei messaggi che ricevi? E come mi guardi? E il fatto che non facciamo più sesso?».
«I miei messaggi sono una cosa personale. Io ti guardo come sempre. Non facciamo più sesso perché tu sei aggressivo e mi fai paura».
«Davvero? Ti faccio tanta paura? Sono forse un mostro?».
Lei si rivolse a me, cercando una sponda. «Lo vede come diventa aggressivo?».
«Io sono aggressivo come un lupo che difende il suo territorio».
«Io ho amato ed amo un uomo, non un lupo».
«Tu non mi ami più».
«Sei tu che sei geloso. Un geloso patologico».
Notai che i due stavano, poco alla volta, avvicinandosi l’uno all’altra. Era come se le sedie pattinassero sul parquet, attraendosi.
Alla fine lui le prese una mano, con le lacrime agli occhi. «Mi fai sentire un pazzo. Ti odio per questo».
Lei volse il suo viso solare, quasi infantile, e sembrò cercare prima i miei occhi e poi quelli del marito.
In un istante vidi baluginare la luce di un sentimento. Fu un’intuizione che non saprei descrivere a parole.
Trovai la forza di andare oltre il mio ruolo. «Tra voi c’è ancora un sentimento? Vi amate ancora? Domanda difficile, lo so».
Non risposero. Lei abbassò lo sguardo. Lui si morse un labbro. Ed io ebbi l’inspiegabile certezza che non ci sarebbe stata alcuna separazione.
Diedi un’occhiata alle lancette dell’orologio, giusto per far intendere che il tempo era denaro, e chiusi di scatto quella pratica, che avrebbe potuto morire dopo avere emesso solo il primo vagito. «Vi invito a riflettere. Rivediamoci tra un mese».
Uscirono dalla stanza in un clima di quiete dopo la tempesta. Luca mi fece il primo sorriso della sua seconda vita da mio amico. Lasciarono lo studio in silenzio.
Luca mi scrisse una mail quindici giorni dopo. «Grazia è tornata. Ci riproviamo. Grazie per la tua sensibilità. Quanto ti dobbiamo?» “Caspita che eleganza” pensai “forse è per lo scampato pericolo di dover lasciare la SUA casa a due estranei?”.
Risposi che ero felice per loro e che non mi dovevano niente: “addio Copenaghen, almeno per ora!”.
Il giorno successivo lessi una mail di Grazia con un invito a cena, per ringraziarmi dell’aiuto legale e umano. L’invito era esteso a Claudia.
La mia ragazza non voleva venirci, ma la convinsi a patteggiare con la propria ritrosia.
Portammo una buona bottiglia di Chianti, per avere una consolazione, in caso le cose fossero andate male.
Luca e Grazia ci ricevettero con tutti gli onori. Giacomo era dalla nonna materna.
Dopo una interminabile attesa, fatta di scontati apprezzamenti a proposito della stabilità del matrimonio e dell’unità familiare, furono serviti in tavola quattro fumanti piatti di spaghetti alla carbonara. Luca si occupò del vino e riempì di Chianti, fino all’orlo, tre calici; lui non beveva alcool.
Arrivò una telefonata sul cellulare di Grazia: era sua madre. La sottopose ad un fuoco di fila di domande: Giacomino sta bene? Ha mangiato? Ha dormito? Era nervoso? Ha giocato con l’amichetto ch’era venuto a trovarlo? Hanno per caso preso freddo, stando in cortile? Mi raccomando…
Luca, all’improvviso, divenne teso come una corda di violino, scattò in piedi e batté un vigoroso pugno sulla tavola, tanto da far tremare i piatti. «Bastaaa! Giacomino di qua, Giacomino di là…lo pronunci mille volte al giorno il nome di tuo figlio, come fosse l’unica cosa al mondo! ma lo sai che abbiamo degli ospiti? È possibile mangiare un piatto in santa pace almeno quando non abbiamo tuo figlio tra i piedi?».
Grazia fissò il marito con occhi spiritati. «Scusa tanto se ti innervosisco, ma sono preoccupata per mio figlio. Giacomino vale molto di più di un piatto di pasta coi tuoi amici!». Ciò detto, uscì dalla sala da pranzo e sparì nel buio del corridoio.
Luca le corse dietro. «Tu non mi tratti così, è chiaro? Sei una stronza…cosa fai adesso? Vai da lui? Dal tuo amante?».
Io rimasi raggelato e con la forchetta a metà strada tra il piatto e le labbra.
Claudia sembrò rincuorarmi, col suo sguardo indomabile. Allungò la sua mano, per afferrare la mia. «Beh, invece che una cena per ringraziarti potevano offrirti un viaggio a Copenaghen, non credi?».
Le sorrisi. Era stata arguta, come sempre. Fu in quell’istante che ebbi la precisa sensazione che lei fosse la donna della mia vita.
La abbracciai. «A cento metri da qui c’è una spaghetteria aperta fino a tardi, ci andiamo? Non voglio farti digiunare».
Scivolammo fuori casa ed accostammo la porta, mentre dietro di noi sorde grida scuotevano l’aria.
«Sta zitta!».
«Io faccio quello che voglio!».
«Questa è casa mia!».
«L’avvocato ha detto che se ci separiamo questo non è più casa tua, bello mio!».
Comunione dei Beni
La comunione dei beni si concretizza sulla base di un accordo ai sensi del quale più persone costituiscono un patrimonio comune, godendo equamente dei frutti e partecipando solidalmente alle spese.
Nel diritto privato italiano con l’espressione “comunione dei beni” si fa generalmente riferimento al regime patrimoniale legale della famiglia, vale a dire l’assetto patrimoniale che si applica automaticamente in mancanza di diverse pattuizioni da parte dei coniugi. La scelta in favore della comunione dei beni, in quanto regime legale della famiglia, ha avuto luogo con la riforma del diritto di famiglia del 1975 ed è imperniata sul principio della assoluta parità di diritti ed obblighi tra i coniugi. Con tale intervento normativo si è statuito che, per tutti i matrimoni celebrati dopo il 20 settembre 1975, in mancanza di contraria pattuizione, ai coniugi si applicasse il regime della comunione dei beni. Precedentemente a tale data, ai matrimoni si applicava ex lege il regime patrimoniale della separazione dei beni. La citata riforma del 1975 ha operato, in omaggio ad un più moderno principio di parità tra i coniugi, un vero e proprio ribaltamento di principi giuridici. Per i matrimoni celebrati dopo il 20 Settembre 1975, la legge di riforma del diritto di famiglia ha disposto un periodo di tempo transitorio (fino al 15 gennaio 1978) entro il quale ciascuno dei coniugi, anche con atto reso unilateralmente dinanzi a notaio del luogo del contratto matrimonio, avrebbe potuto dichiarare di non voler aderire al nuovo regime, rimanendo pertanto in regime di separazione dei beni. Entro lo stesso termine (15 gennaio 1978) i coniugi potevano convenire che i beni acquistati anteriormente alla data del 20 settembre 1975 fossero assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi.
La comunione dei beni non si estende all’intero patrimonio dei coniugi. Occorre, in effetti, distinguere ciò che rientra nella comunione (beni comuni) da ciò che invece non vi rientra ed appartiene, dunque, esclusivamente ad un coniuge o all’altro (beni propri o personali dei coniugi).
Rientrano nella comunione:
- gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio, eccezione fatta per i beni propri;
- le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi di quelle appartenenti a uno dei coniugi prima del matrimonio ma gestite da entrambi;
- i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati al momento dello scioglimento della comunione;
- i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se non siano stati consumati al momento dello scioglimento della comunione;
- i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi dopo il matrimonio se sussistono al momento dello scioglimento della comunione.
Sono invece beni propri di ciascun coniuge e non rientrano in comunione:
- i beni di cui ciascuno dei coniugi era titolare (proprietà o altro diritto reale parziario) prima del matrimonio;
- i beni acquisiti durante il matrimonio per donazione o successione, a meno che nell’atto di donazione o di successione non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
- i beni di uso strettamente personale di ciascuno dei coniugi e i loro accessori.
- i beni strumentali all’esercizio della professione.
- i beni ottenuti a titolo di risarcimento per danni.
- i beni acquistati con il prezzo di alienazione dei beni propri, purché ciò sia dichiarato espressamente nell’atto di disposizione.
Gli atti di ordinaria amministrazione relativi ai beni comuni possono essere compiuti disgiuntamente da ciascuno dei coniugi, mente gli atti di straordinaria amministrazione devono essere compiuti congiuntamente dagli stessi.
L’art. 191 del codice civile stabilisce i casi di scioglimento della comunione:
- ove sia stata dichiarata l’assenza o la morte presunta di uno dei coniugi.
- Allorché sia stato annullato il matrimonio o dichiarata la sua nullità
- Ove vi sia stato lo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi o per divorzio, ovvero in caso di separazione personale, giudiziale o consensuale. Nel caso di separazione personale, una eventuale successiva riconciliazione dei coniugi non ripristina la comunione dei beni.
- in caso di separazione giudiziale dei beni pronunciata a seguito di interdizione o inabilitazione di uno dei coniugi o di cattiva amministrazione della comunione.
- nel caso in cui i coniugi abbiano scelto un regime diverso.
- nel caso di fallimento di uno dei coniugi.
Mantenimento dei Figli e del Coniuge
Nel diritto di famiglia, si parla di mantenimento del figlio, ovvero, più raramente, del coniuge, per ricomprendere tutti i bisogni della famiglia, non solo quelli fondamentali (come il vitto e il vestiario), ma anche quelli che riguardano la vita relazionale, da commisurarsi all’ambito sociale in cui essa è inserita. In particolare, verso i minori, il mantenimento non è visto come il mero utilizzo del denaro per il soddisfacimento dei loro bisogni, ma anche come una complessa attività di educazione e presenza costante, per garantire il loro miglior sviluppo psico-fisico. L’obbligo di mantenimento in capo ai genitori e verso i figli, che sussiste sia in caso di separazione personale dei coniugi sia in caso di divorzio, può estendersi temporalmente oltre la maggiore età di questi ultimi, se essi con diligenza aspirano a raggiungere un titolo di studio superiore che comporti l’impossibilità temporanea di mantenersi economicamente. Ovviamente, il mantenimento non può avere durata temporale illimitata. Tale istituto cessa i propri effetti allorché il figlio maggiorenne acquisisca una propria capacità economica (un lavoro stabile, non meramente occasionale ) ovvero quando lo status di dipendenza economica dai genitori si protragga ingiustificatamente a lungo (specie dopo i trenta anni) a causa di un sostanziale disimpegno scolastico-lavorativo ingiustificabile e dovuto a colposa negligenza. Si badi che, secondo la più recente giurisprudenza, il figlio che sia occupato a titolo stabile, anche ove perda il lavoro, non ha più diritto, se maggiorenne, al mantenimento, in quanto ormai si ritiene abbia fatto ingresso nel mercato del lavoro.
Il mantenimento è inteso quale somma di denaro necessaria a garantire, al beneficario della dazione montearia, lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, con la storica e per certi versi rivoluzionaria sentenza n. 11504 del 2017, escludeva come parametro dell’importo dovuto a titolo di assegno divorzile il tenore di vita tenuto durante il matrimonio.
La Cassazione ha voluto affermare un principio molto chiaro: posto che con il divorzio l’unione matrimoniale si estingue, determinare le successive obbligazioni di mantenimento sulla base del tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio, significherebbe non valorizzare l’interruzione del legame, vincolando in eterno (o quasi) i coniugi a un rapporto ormai tramontato e lasciato alle spalle.
Al di là delle questioni attinenti all’entità dell’assegno divorzile, rese oggetto dell’innovativo arresto giurisprudenziale già citato, è parere personale di chi scrive che lo storico concetto di mantenimento, inteso quale modo di assicurare anche dopo la separazione ed il successivo divorzio lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, rischi di essere anacronistico. Il diritto, si sa, si evolve con l’evolversi della prassi economica e sociale. Ebbene, chi qui scrive ritiene che una attuale concezione del mantenimento non possa prescindere dagli esiti della crisi economica che devasta le famiglie, spossate dalla pandemia, dalle oscillazioni del mercato finanziario spesso legate a drammatici eventi mondiali e dalla crisi energetica. Il mantenimento non può costituire né un arricchimento del percipiente né un eccessivo depauperamento del soggetto obbligato. Così come la separazione deve costituire un trauma per tutti e non già un affare per qualcuno ed un disastro economico per qualcun altro.
Affidamento Condiviso
L’affidamento condiviso dei figli è la regola che si applica in caso di cessazione della relazione affettiva e quindi della convivenza tra i genitori.
Attraverso il modello dell’affidamento condiviso, viene garantito/a:
- l’esercizio effettivo della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori di talché nessuno di essi si senta escluso dalla vita del figlio/a;
- La partecipazione di entrambi i genitori alla cura ed all’educazione dei figli.
- La necessità di assumere unitariamente le decisioni di maggiore interesse per i minori (ad esempio quelle relative alla scuola, alla salute ed alle scelte educative).
Nel caso in cui vi sia un disaccordo sulle questioni di maggiore interesse, le parti dovranno rivolgersi al giudice tutelare per dirimere le controversie tra loro insorte in punto di scelte fondamentali per la vita del minore. Mentre per le questioni di ordinaria amministrazione il giudice può anche disporre che i genitori possano prendere decisioni separatamente.
L’istituto dell’affidamento condiviso è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico con la legge n. 54 del 2006, “unitamente al principio della c.d. “bigenitorialità”. Aggiungeremmo che l’istituto in parola amplifica il concetto inalienabile di assoluta parità di diritti e doveri in capo ai coniugi.
La principale novità introdotta dalla legge n. 54/2006 è il superamento della prassi consolidata di affidare il figlio minore ad uno solo dei genitori, quello ritenuto più idoneo (generalmente la madre). La legge n. 54/2006 dispone viceversa che l’affidamento esclusivo sia una assoluta eccezione da motivare adeguatamente nel provvedimento giurisdizionale. Questo nuovo orientamento trova scaturigine nell’esigenza, sempre più avvertita, di garantire ai minori la continuità affettiva con entrambi i genitori e di evitare aspre contese per l’affidamento esclusivo generatrici di rancori sempre deleteri per i figli. Tali esacerbate contese, spesso, nella pratica, portavano l’un genitore a svilire con il figlio/a l’immagine dell’altro e ad usare l’affidamento esclusivo come merce di scambio per il soddisfacimento di altri meno significativi interessi patrimoniali.
L’art. 337-ter del codice civile impone di valutare: “…prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori”, in modo da realizzare al meglio il diritto della prole a “…mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi”.
Disporre l’affidamento condiviso, se da un lato consente di esercitare insieme la responsabilità genitoriale, dall’altro lascia aperta la questione della residenza del minore (rectius del suo collocamento prevalente).
Nella maggior parte dei casi, i figli vengono collocati presso la madre a cui, in genere, viene anche assegnata in godimento la casa familiare (ciò anche per retaggi culturali inestirpabili, peraltro in gran parte culturalmente giustificati, secondo i quali è la madre il soggetto della famiglia depositario del diritto/dovere di custodia e cura dei minori).
Questa “preferenza” per la madre, in punto di collocamento prevalente della prole, deriva dal fatto che il suo ruolo viene considerato centrale nel focolare domestico e maggiormente adatto all’educazione dei figli.
Quando il giudice decide sulla residenza dei figli, determina anche tempi e modalità per garantire la presenza dei figli presso il genitore non collocatario prevalente. Questo ha luogo al fine di garantire un significativo rapporto affettivo del minore con ciascun genitore.
Oggi viene riconosciuto, in merito alle decisioni più importanti sulla loro vita, anche facoltà di parola al minore. Vedremo, trattando in successivo paragrafo della separazione e del divorzio giudiziali, che, in base alla c.d. Riforma Cartabia, il Giudice procede all’ascolto del minore che abbia compito gli anni dodici (ed anche più piccolo se riconosciuto capace di discernimento).
Quando viene disposto l’affidamento condiviso, entrambi i genitori hanno diritto di richiedere ed ottenere gli assegni familiari.
Quanto al caso eccezionale di affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei coniugi, giova ritrascrivere il disposto normativo dell’art. 377-quater c.c. “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.”. Trattasi di ipotesi residuali e caratterizzate da situazioni di gravità oggettiva tra le quali, a mero titolo esemplificativo, si citano le seguenti: sospetto di abusi, anche sessuali, di un genitore sui figli minori; stato di grave tensione nei rapporti tra l’un genitore e i figli minori tali da incutere in questi ultimi timori per la propria incolumità psico-fisica; genitore gravato da gravi forme di dipendenza (da sostanze stupefacenti, psicotrope ovvero alcooliche) ovvero comunque altrimenti tenutario di una condotta di vita improntata alla commissione di reati e al totale disimpegno sociale.
Viene per questo riconosciuta a ciascun genitore la possibilità di opporsi all’affidamento condiviso e di richiedere l’affidamento esclusivo.
Al fine di scongiurare il rischio che vengano esperite azioni giudiziarie temerarie e prive di fondamento, l’art. 337-bis del codice civile prevede però che, qualora la domanda sul punto risulti manifestamente infondata, il giudice possa valutare negativamente il comportamento del genitore istante, ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli.
In caso di affidamento esclusivo, il genitore affidatario esercita la responsabilità genitoriale sui figli attenendosi alle condizioni determinate dal giudice. Ma, salvo diversa disposizione, gravano in capo ad entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse per i figli.
Attenzione: anche laddove sia disposto l’affidamento esclusivo in capo ad un genitore, il ruolo dell’altro non viene meno ma quest’ultimo conserva comunque il diritto ed anche il dovere di vigilare sulla istruzione dei figli e sulla loro educazione. Costui potrà persino ricorrere al giudice ove ritenesse che siano state assunte decisioni relativamente ai figli “pregiudizievoli al loro interesse”.
Viceversa perde ogni voce in capitolo il genitore dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale (il relativo provvedimento, emesso in casi gravissimi, è di competenza del Tribunale per i minorenni).
Più in generale, va precisato che in ogni caso, qualunque sia stata la decisione sull’affidamento dei figli, i genitori hanno sempre diritto di chiedere la revisione delle relative disposizioni nel caso in cui si modifichino le situazioni che le hanno determinate.
Sancito il principio dell’assoluta preminenza dell’interesse morale e materiale dei figli minori (stella polare destinata ad orientare una visione moderna della crisi coniugale), la legge sull’affidamento condiviso demanda al giudice il compito di determinare “i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”.
La potestà deliberativa del giudice in argomento, quindi, risulta oggi molto ampia e non è più limitata alla determinazione del solo diritto di visita. Essa, tuttavia, trova un limite importante nell’obbligo giudiziale di “prendere atto” degli accordi intervenuti tra i genitori (a meno che tali accordi risultino pregiudizievoli per i minori).
In ogni caso, il diritto di visita in capo al genitore non collocatario prevalente della prole si modella, secondo consolidate liee guida come segue:
- Un fine settimana su due dal sabato all’uscita da scuola alla domenica sera;
- Un pomeriggio alla settimana dall’uscita da scuola alla cena;
- Quindici giorni, anche non continuativi, l’estate;
- Natale e Pasqua ad anni alterni (se quest’anno lo tengo a Natale non lo tengo anche a Pasqua e l’anno prossimo lo terrò a Pasqua e non a Natale).
- A capodanno, negli anni in cui il Natale è trascorso con l’altro genitore.
Assegnazione in godimento della casa familiare
L’assegnazione della casa familiare è disciplinata dall’art. 337-sexies c.c., secondo cui «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli». Si tratta pertanto di un istituto volto alla tutela dei figli, ancorché il destinatario della assegnazione sia il genitore collocatario con prevalenza della prole convivente. Dopo un primo contrasto giurisprudenziale, poi risolto (Cass. civ., S.U., 28 ottobre 1995, n. 11297), è ormai pacifico sia in dottrina sia in giurisprudenza che si possa procedere ad assegnazione della casa coniugale solamente se vi sono figli conviventi, siano essi minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti economicamente, e che di conseguenza, in assenza di figli, non possa ottenere l’assegnazione il coniuge economicamente più debole, quale forma di prestazione in natura, ancorché parziale, del mantenimento (per tutte Cass., civ., sez. I, 18 settembre 2013, n. 21334). La norma è applicabile ai rapporti tra genitori e figli, siano essi nati dal matrimonio o fuori di esso. Tutti i figli indistintamente, pertanto, hanno diritto all’assegnazione della casa familiare in caso di cessazione della convivenza dei loro genitori, a prescindere dal fatto che questi siano o meno tra loro sposati.
Separazione dei coniugi (a seguito della c.d. Riforma Cartabia)
La separazione personale dei coniugi, nell’ordinamento giuridico italiano, è lo stato giuridico dei coniugi, il cui vincolo coniugale viene attenuato ma non ancora sciolto (ciò avrà luogo solo con il divorzio, rectius, con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, in caso di matrimonio concordatario, o con lo scioglimento del matrimonio, in caso di rito civile). Lo stato di separazione può sfociare nella riconciliazione dei coniugi e nella ripresa della convivenza, oppure nel divorzio. Nel primo caso cessano gli effetti della separazione. Nel secondo caso, la separazione personale rappresenta normalmente l’anticamera della regolazione dei rapporti dei coniugi in vista del futuro divorzio.
Lo status di “legalmente separato” (cioè di non mero separato di fatto) si consegue, in difetto di formalizzazione di accordi in sede stragiudiziale, con l’ottenimento di un provvedimento giurisdizionale che può consistere in una sentenza pronunciata dal giudice (rectius dal collegio giudicante), ed allora parleremo di separazione giudiziale, o nel decreto di omologazione dell’accordo di separazione raggiunto consensualmente dai coniugi (separazione consensuale). Nel primo caso, è il Tribunale, all’esito di una causa, a dichiarare l’intollerabilità della convivenza coniugale e a stabilire le condizioni (economiche, di affidamento dei figli e di eventuale assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario prevalente dei figli minori o di maggiore età e non economicamente autosufficienti senza loro colpa) alle quali i coniugi possono vivere separati. In questa ipotesi il giudizio di separazione è propriamente contenzioso.
La principale novità della riforma è costituita dalla possibilità di presentare, in uno stesso giudizio, domanda di separazione e di divorzio. Tuttavia la domanda di divorzio sarà scrutinata a condizione che sia stata pronunciata in via definitiva la separazione e che siano trascorsi almeno sei mesi (un anno in caso di presenza di figli minori) dalla prima udienza di separazione.
Vediamo come si modella il procedimento di separazione giudiziale dei coniugi a seguito della legge di riforma della giustizia che ha prodotto, in materia, una trasformazione che potremmo definire davvero radicale. Tale trasformazione è incentrata su due principi fondamentali:
- Snellezza del procedimento. Con la riforma grava in capo alle parti l’onere di scoprire subito le proprie carte, allegando fin dal primo atto difensivo i fatti ritenuti rilevanti, producendo fin da subito la documentazione ed articolando (senza strategie dilatorie) fin dal primo scritto difensivo le prove orali ritenute pertinenti.
- La riforma, tesa a velocizzare il rito, pone fine anche alla bipartizione del procedimento in due fasi: quella detta presidenziale, finalizzata all’adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse della prole, e quella istruttoria davanti al giudice delegato finalizzata all’assunzione delle prove e alla decisione finale. Tale bipartizione, in effetti, rendeva il procedimento macchinoso e complesso. Si pensi, a mero titolo esemplificativo, che in capo alle parti gravava l’onere di una doppia costituzione in giudizio: la prima dinnanzi al Presidente o ad un suo delegato; la seconda innanzi all’istruttore. Si pensi altresì al fatto che le prove orali (audizione di testimoni) venivano dedotte addirittura nel corpo del quarto scritto difensivo della procedura (memoria ex art. 183 comma VI n. 2 innanzi all’istruttore).
- Centralità della figura del figlio minore. A seguito della riforma, al minore è attribuita una accresciuta centralità. Il giudice deve ascoltare la prole che abbia compiuto gli anni dodici (o anche di età inferiore se ritenuta capace di discernimento) prima di adottare provvedimenti che incidano sulla situazione dei figli minori. Si pensi, altresì, al fatto che la competenza territoriale è riconosciuta in favore del Tribunale nel cui distretto risiedono i minori coinvolti nel giudizio.
Fatte queste doverose premesse passiamo ora in rassegna gli snodi procedurali del nuovo giudizio di separazione/divorzio contenziosi.
L’art. 473 bis n. 11 del Codice di Procedura Civile stabilisce che per i procedimenti di separazione giudiziale (ed anche per i giudizi di divorzio contenzioso) quando sono coinvolti gli interessi di figli minori, la competenza territoriale è riconosciuta al tribunale del luogo in cui il minore risiede abitualmente. Questa norma contribuisce ad amplificare il concetto di centralità del minore e dei suoi interessi nel contenzioso familiare.
Nel caso di trasferimento non autorizzato (dall’altro coniuge) del minore, sempre che non sia trascorso un anno da tale trasferimento, il tribunale competente è quello del luogo dell’ultima residenza abituale del minore prima del trasferimento. La norma in parola si giustifica poiché tende ad evitare strategici traslochi del minore, decisi dal coniuge che scientificamente e artatamente intende radicare la competenza presso il Tribunale che risulti aver prodotto la giurisprudenza maggiormente favorevole ai propri interessi.
Nelle ipotesi in cui non vi siano figli minori da tutelare, si fa invece ricorso agli ordinari criteri per la ripartizione della competenza territoriale (individuata con riferimento al luogo di residenza, domicilio o dimora del coniuge nei cui confronti è proposta la domanda).
A seguito della c.d. Riforma Cartabia, la forma della domanda introduttiva per i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale è disciplinata dall’art. 473 bis n. 12 c.p.c.
Il procedimento è introdotto con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale competente. Il ricorso deve contenere:
- l’indicazione dell’ufficio giudiziario innanzi al quale viene presentata la domanda;
- nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio o dimora e codice fiscale dell’attore e del convenuto, oltre che dei figli minori, di quelli adulti non autosufficienti economicamente o con grave disabilità e degli altri soggetti coinvolti nelle domande o nel procedimento;
- nome, cognome e codice fiscale del procuratore, unitamente alla procura posta in calce o a margine dello scritto difensivo;
- indicazione dell’oggetto della domanda;
- esposizione chiara e sintetica dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa la domanda, con le relative conclusioni;
- l’indicazione specifica delle prove che il richiedente intende far assumere e dei documenti da comunicare.
Qualora la domanda introduttiva del procedimento contenga richieste di contributo economico ovvero, in ogni caso, in ipotesi vi siano figli minori, è necessario depositare con il ricorso anche i seguenti documenti:
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- documentazione che attesti la titolarità di diritti reali su immobili e beni mobili registrati, nonché di quote sociali;
- estratti conto bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni.
- un piano genitoriale. Si tratta di uno scritto che deve indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli riguardanti la scuola, il percorso educativo, le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute.
L’art. 473 bis n. 14 cpc stabilisce che, dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, il presidente, entro i tre giorni successivi, nomini il relatore.
Passiamo ora ad esaminare le ulteriori disposizioni che regolano la procedura in parola, con particolare riferimento alla tempistica (nel senso di maggior auspicata snellezza e rapidità):
- tra il deposito del ricorso e l’udienza non devono intercorrere più di 90 giorni;
- col provvedimento che fissa l’udienza, il Giudice assegna un termine per la costituzione del convenuto, che in ogni caso deve avvenire almeno 30 giorni prima dell’udienza;
- il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza sono notificati al convenuto dall’attore almeno 60 giorni liberi prima dell’udienza;
- se la notifica deve essere fatta all’estero, l’udienza deve essere fissata entro 120 giorni dal deposito del ricorso e tra la notifica e l’udienza devono intercorrere almeno 90 giorni.
A norma dell’art. 473 bis n. 16 cpc, il convenuto deve dunque costituirsi entro il termine assegnato dal giudice, depositando una comparsa di risposta contenente tutto quanto richiesto, in conformità agli articoli 167 e 473 bis 12, secondo, terzo e quarto comma. Il convenuto deve attenersi ai precetti previsti, in capo all’attore, per il deposito del ricorso, con particolare riferimento all’immediata formulazione delle richieste di prova.
L’art. 473 bis n. 17 cpc, stabilisce quanto segue:
- Entro 20 giorni prima dell’udienza, l’attore può depositare una memoria per replicare con chiarezza e specificità ai fatti esposti dal convenuto, a sostegno delle proprie ragioni, modificare o precisare domande e conclusioni, proporre domande ed eccezioni conseguenti alle difese del convenuto, indicare mezzi di prova tesi a contrastare quelli dedotti dall’attore e produrre documenti a controprova. Se il convenuto ha richiesto un contributo economico, l’attore deve depositare la documentazione prevista nell’articolo 473 bis n. 12, terzo comma, entro lo stesso termine.
- Entro 10 giorni prima dell’udienza, il convenuto può depositare un’ulteriore memoria per precisare e modificare le domande, eccezioni e conclusioni già proposte, proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio conseguenti alla eventuale domanda riconvenzionale o alle difese svolte dall’attore con la memoria prevista dal primo comma della norma citata, indicare mezzi di prova e produrre documenti, anche a prova contraria.
- Entro 5 giorni prima dell’udienza, l’attore può depositare un’ulteriore memoria all’esclusivo fine di articolare prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti ex adverso nella memoria del secondo comma.
L’art. 473 bis n. 23 cpc prevede che i provvedimenti temporanei ed urgenti, assunti dal giudice alla prima udienza in punto di affidamento dei figli minori, di determinazione dell’assegno a titolo di mantenimento ovvero di contributo al mantenimento dell’altro coniuge, dei figli minori o dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti non per loro colpa, di eventuale assegnazione della casa coniugale, possono essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di eventi successivi che mutino lo status quo ante o di nuove emergenze istruttorie.
L’art. 473 bis n. 24 cpc prevede altresì la possibilità di presentare reclamo avverso i predetti provvedimenti temporanei ed urgenti. Il reclamo sarà deciso dalla corte di appello. Il reclamo è ammesso anche contro provvedimenti temporanei emessi durante il processo che sospendono o limitano significativamente la responsabilità genitoriale, oltre a quelli che apportano importanti modifiche all’affidamento e alla collocazione dei minori o che ne stabiliscono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Il reclamo deve essere presentato entro un termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza, dalla comunicazione o dalla notificazione, se reso fuori udienza.
L’art. 473 bis n. 28 bis stabilisce che, anche dopo la conclusione del processo, sia possibile modificare i provvedimenti precedentemente stabiliti in seno al procedimento concluso.
L’art. 473 bis n. 15 cpc prevede che, in caso si prospetti lo spettro di un danno imminente ed irreparabile o quando convocare le parti potrebbe compromettere l’efficacia dei provvedimenti, il presidente o il giudice delegato da lui, acquisite se necessario informazioni sommarie, può adottare con un decreto provvisoriamente esecutivo le misure necessarie nell’interesse dei figli e, nei limiti delle richieste formulate, delle parti costituite.
Con lo stesso decreto, il giudice fissa un’udienza entro i successivi quindici giorni per confermare, modificare o revocare le misure adottate con il predetto decreto, assegnando al richiedente un termine perentorio per la notifica a controparte.
L’art. 473 bis nn. 21 e 22 del Codice di Procedura Civile prevede la comparizione personale delle parti all’udienza, a meno che non vi siano gravi e comprovati motivi che ne giustifichino l’assenza. La mancata comparizione ingiustificata di una parte può essere valutata, a detrimento dell’assente, quale elemento di prova ai sensi dell’art. 116 comma 2 e sulla liquidazione delle spese.
All’udienza, il giudice ascolta le parti, sia congiuntamente sia separatamente, e tenta di promuovere la conciliazione dei coniugi, se del caso mettendo a verbale un’ipotesi di accordo.
Se le parti pervengono ad un accordo, il giudice emette i provvedimenti temporanei ed urgenti necessari e fissa un’udienza per la decisione.
In caso, viceversa, di mancata conciliazione, adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti, il giudice si pronuncia sulle richieste istruttorie e stabilisce il calendario del processo, fissando entro i successivi 90 giorni l’udienza per l’assunzione delle prove ammesse (nel senso di una maggior celerità).
Se il Giudice ritiene la causa matura per la decisione e dunque superflua l’ammissione di ulteriori prove, dopo aver fatto precisare le conclusioni, ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su richiesta anche di una sola delle parti, in un’udienza successiva. Al termine della discussione, il giudice trattiene la causa in decisione.
L’art. 473 bis n. 28 cpc, viceversa, prevede che il giudice, terminata l’acquisizione delle prove, fissi un’udienza per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini:
- non più di sessanta giorni prima dell’udienza per il deposito delle note scritte per precisare le conclusioni;
- non più di trenta giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
- non più di quindici giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica.
La sentenza viene depositata entro i successivi sessanta giorni.
Le sentenze sono, ovviamente, appellabili.
Gli articoli successivi regolano il giudizio d’appello e stabiliscono che:
- il presidente della corte di appello, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il relatore, fissa l’udienza ed il termine per la notificazione del ricorso e del decreto all’appellato;
- tra la notificazione all’appellato e l’udienza deve intercorrere un termine non inferiore a 90 giorni;
- se la notificazione deve essere effettuata all’estero, il termine è aumentato a 150 giorni;
- il presidente acquisisce d’ufficio le relazioni aggiornate dei servizi sociali o sanitari e ordina alle parti di depositare la documentazione aggiornata richiesta dall’articolo 473 bis 12, terzo comma.
L’appellato si costituisce almeno 30 giorni prima dell’udienza, depositando la comparsa di costituzione, in cui deve svolgere le proprie difese in modo chiaro e specifico. Nella stessa comparsa, l’appellato può proporre appello incidentale, a pena di decadenza.
Torniamo ora alle premesse e ad alcune significative disposizioni che illuminano le linee essenziali della riforma.
L’art. 473 bis n. 4 cpc esalta la centralità del minore nei procedimenti di separazione e divorzio giudiziali che li riguardano.
L’art. 473 bis n. 6 cpc prevede che il giudice debba ascoltare il minore che rifiuta di incontrare un genitore, al fine di indagare sulle cause del rifiuto. Il giudice può anche intervenire con durezza e provvedimenti appropriati al fine di impedire che un genitore ostacoli il mantenimento di un rapporto equilibrato tra il minore e l’altro genitore o la conservazione di legami significativi con gli ascendenti e i parenti.
La riforma prevede altresì che il giudice, in caso di gravi inadempienze di uno dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore, possa modificare i provvedimenti in vigore e sanzionare il genitore inadempiente. Le sanzioni includono l’ammonimento, il pagamento di una somma di denaro, una sanzione amministrativa pecuniaria ed il risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o del minore stesso.
La legge di riforma appronta ed assicura adeguate tutele in favore del genitore, economicamente più debole, creditore di assegni di mantenimento o di contributo al mantenimento. I provvedimenti in materia di contributo economico costituiscono titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e il giudice può imporre una garanzia personale o reale per evitare il mancato adempimento di tali obblighi.
Se l’inadempimento dell’obbligo di contribuzione al mantenimento si protrae per oltre trenta giorni, il creditore può notificare il provvedimento o l’accordo di negoziazione assistita ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al debitore, i quali sono pertanto tenuti al pagamento dell’assegno. Se il terzo non adempie, il creditore può agire con un’azione esecutiva diretta. Se il credito dell’obbligato è già stato pignorato al momento della notificazione, il giudice dell’esecuzione si occupa dell’assegnazione e della ripartizione delle somme tra gli aventi diritto al contributo e gli altri creditori.
L’avvocato incaricato di una pratica di separazione personale dei coniugi avrà cura di:
- Verificare la definitività della volontà dei coniugi di separarsi, l’impossibilità oggettiva di ricostituire il menage familiare, l’irreversibilità della crisi coniugale;
- Consigliare ai coniugi di raggiungere, ove possibile, un accordo sulle condizioni di separazione, stante il risparmio di tempo, di denaro e di tensioni relazionali sempre pregiudizievoli per la prole;
- Rinnovare nelle parti lo spirito di collaborazione genitoriale per la miglior tutela dei figli, specie se minori, evitando di coinvolgerli nel dissidio, allo scopo disdicevole di incrementare la tensione ovvero di usarli come merce di scambio per garantirsi la tutela di altri interessi meno prioritari. In effetti si smette di essere coniugi, non genitori
- In caso di separazione giudiziale evitare di accanirsi nella pretesa di addebito della separazione all’altro coniuge, infarcendo gli atti di riferimenti a fatti e circostanze irrilevanti rispetto all’esigenza primaria di assicurare alla famiglia il miglior assetto patrimoniale, con il mantenimento dei figli.