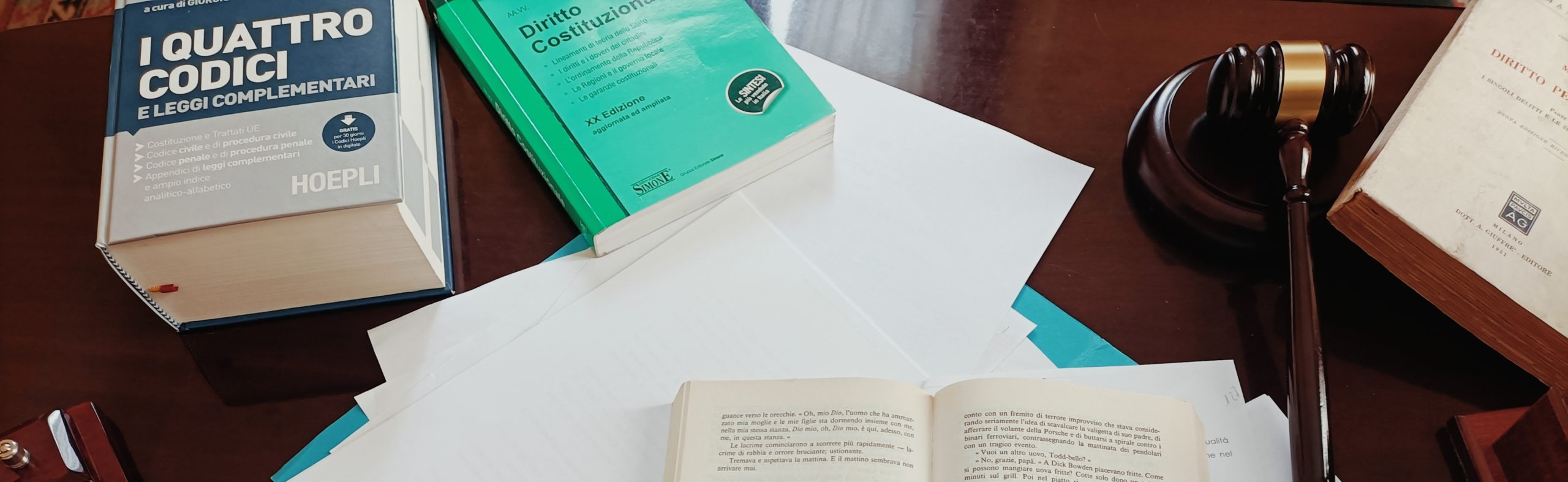Diritto processuale penale
Patteggiamento / Giudizio abbreviato
Pioveva a dirotto e tirava vento il pomeriggio in cui zio Arturo fece cadere sulla mia scrivania quel fascicolo azzurro con la lettera P, che stava per penale, stampata nell’angolo destro.
Il mio mentore era apparso sulla soglia della mia stanza, l’impermeabile ancora addosso e l’ombrello gocciolante, con uno strano sorriso di fredda complicità che sembrava dire. «Ringrazia il cielo che ci sono io». Le parole che pronunciò furono altre e mi regalarono un brivido di piacere. «Voglio che lo segui tu questo processo». Battè le dita contro la copertina esterna della mia nuova pratica. «Fatti firmare una nomina di fiducia da El Atef. A te oneri ed onori di questa difesa!».
Spalancai gli occhi come un bimbo a cui hanno regalato il giocattolo preferito: “Onori? Vuol dire che quel simpatico pizzaiolo egiziano mi pagherà l’onorario? Il mio primo cliente? I miei primi soldi?!”. Non ci potevo credere, tanto che, nell’eccitazione, dimenticai persino di pronunciare la parola che usavo più spesso con lo zio, “grazie”, e l’entusiasmo mise KO la paura di non farcela.
Pensai subito ad un viaggio con Claudia a Parigi, la città dei suoi sogni. Lei la decantava sempre nei suoi discorsi, anche se alla fine abbassava lo sguardo e aggiungeva con aria avvilita “…però Praga costa molto meno…”.
“Altro che Praga” mi dissi, con una punta di orgoglio “Io la porterò a Parigi!”. Dovevo solo artigliare quei magici biglietti rettangolari di carta colorata, di cui non conoscevo nemmeno la faccia, che mamma mi dava al bisogno e che da El Atef sapevo tradursi in arabo con una parola curiosa “flus”. Flus aveva il suono dell’acqua corrente e per me il denaro scorreva per davvero alla velocità della luce, sempre un po’ troppo lontano da me, sempre nelle mani di qualcun altro, spesso in quelle voraci dello zio, o meglio della sua segretaria Antonia: “Perché – come diceva il mio mentore – un uomo di valore non si abbassa a toccare il denaro”.
Guardai fuori dalla finestra, quando rimasi da solo nella stanza, e due magiche paroline mi rimbalzarono nella mente, spesso in imprudente anticipo sugli eventi: “fondo spese”. Lo zio lo chiedeva sempre ai clienti, quando riceveva un incarico. Diceva che era l’altra faccia della medaglia dell’assunzione di responsabilità professionale. “Una pratica in più vuol dire qualche minuto di sonno in meno. E qualche minuto di sonno in meno val bene qualche soldo in più nel portafoglio”. Lo zio ripeteva i suoi mantra, come fossero tratti da un libro di magia nera, e a me capitava di recitare ogni volta la parte della spugna che trattiene il liquido vitale.
Scostai una tendina e lanciai il mio sguardo sognante contro il muraglione del carcere di San Vittore. Perché mai non avrei dovuto chiedere un anticipo a El Atef? I giovani devono forse lavorare gratis perché sono meno avidi dei loro maestri?
La porta si aprì alle mie spalle, con un clik appena udibile. Mi voltai e vidi zio Arturo con dipinta in volto quella insopportabile aria di superiorità. Nei miei sfoghi solitari lo chiamavo “l’uomo dalle verità in tasca”.
Mi guardò dall’alto in basso. «Paura per questo primo incarico?».
Sollevai il mento con fierezza, quella che mi abbandonava solo quando mi facevo ferire da qualche parola tagliente di Claudia. «Neanche un po’, se devo essere sincero».
«Molto bene. Buon lavoro, allora». Mi puntò contro il suo dito indice, come fosse la bacchetta di un direttore d’orchestra. «Vediamo se hai imparato qualcosa. Qual è il primo comandamento del penalista?».
«Non credere ai clienti». Risposi, per compiacerlo.
«E perché?».
«Perché nessuno vuol fare bella figura con un altro come l’imputato col suo difensore!».
Quando lo zio si chiuse la porta alle spalle intuii che presto mi sarei stancato di quei rituali da iniziazione alle scienze giuridiche occulte.
La sera, mentre mia mamma seguiva la sua fiction preferita, divorandosi le unghie per la tensione, nell’attesa di sapere se il suo personaggio preferito sarebbe sopravvissuto all’ennesimo rapimento, seduto al tavolo del soggiorno passai in meticolosa rassegna la ventina di fotocopie che Marcello, il praticante di studio, aveva estratto in procura dal fascicolo del pubblico ministero.
Al povero Atef veniva contestato il reato di diffamazione. C’era scritto che il nostro pizzaiolo di fiducia avrebbe sparlato coi suoi clienti di un suo concorrente, che gestiva il ristorante dall’altra parte della strada, con espressioni che sembravano inequivocabili: “Quello ha una sola specialità: la pizza alla merda!”.
Il nostro amico sembrava proprio spacciato. La pubblica accusa si era impegnata a verbalizzare le dichiarazioni di tutti coloro che avevano ascoltato quella frase infelice e non c’erano dubbi che i fatti si fossero svolti proprio com’erano descritti nel capo d’imputazione.
Pensai subito di scrivere una lettera alla vittima del reato, per proporgli di ritirare la querela (1) in cambio del pagamento di una somma di denaro come risarcimento del danno.
Lo feci il mattino seguente, mentre prenotavo due posti su un volo per Parigi, ma accadde l’impensabile. Il pizzaiolo che si riteneva diffamato mi chiamò al telefono due giorni dopo e urlò con tanto furore da costringermi a tenere il cellulare lontano dall’orecchio. Disse che non avrebbe ritirato la querela neppure per diecimila euro. Strepitò che lui non era un uomo comprabile col denaro, che la verità delle cose non era in vendita, che lui aveva subito un danno gravissimo perché la voce sulla “pizza alla merda” si era diffusa per tutto il quartiere, addirittura nell’intera città, e che quel delinquente di un egiziano doveva chiudere bottega, essere portato al centro di Via Corelli ed imbarcato sul primo volo per Il Cairo.
“Pazzesco”. Riflettei, col mento appoggiato sui pugni. “E’ incredibile come la gente possa andare fuori di testa quando crede di avere ragione”.
Non mi persi d’animo e mi rimisi a studiare il fascicolo e, parola per parola, l’articolo 595 del codice penale, sentenze della cassazione comprese.
Sollevai di scatto gli occhi dal codice e mi balenò subito un’idea: “patteggiamento” (2).
Era senza dubbio il modo migliore di limitare i danni ed anche quello di attenuare la mia responsabilità professionale.
Il mio amico Claudio, figlio d’avvocato, secchione fin dalle medie e di certo molto più preparato di me in fatto di codici e di strategie processuali, una volta, a colazione, in un bar davanti al carcere, aveva pronunciato una frase destinata a fare breccia nella mia mente, tanto bisognosa d’essere guidata: “i cittadini extracomunitari con una condanna pesante rischiano il permesso di soggiorno, meglio patteggiare per limitare i danni”. Quelle parole mi erano rimaste impresse, perché la memoria non mi ha mai fatto difetto. Ho sempre pensato che l’ottima memoria fosse l’arma per sopravvivere, in pugno alle persone che, come me, non hanno avuto in dono la genialità.
Indossai il giubbotto di pelle, deciso a farmi una passeggiata, certo d’avere preso in brevissimo tempo la decisione migliore. “Che fortuna avere un amico come Claudio, sfigato con le donne ma geniale nel lavoro”.
Il mattino dell’udienza dovetti impegnarmi allo stremo, per evitare la sciagura di una comparizione di Claudia al mio fianco in aula. Il suo sguardo implacabile da maestrina mi avrebbe fatto precipitare nel panico al minimo contrattempo. Lei era inesorabile nel sottolineare qualsiasi mio errore, vero o presunto che fosse. Mi faceva osservazioni sulle parole, sul tono di voce, sul nodo alla cravatta per lei sempre troppo largo, persino su come reggevo tra le dita la coppa di gelato.
Quel mattino, davanti al cappuccio, aveva un’aria supplicante ed io mi imposi di guardare da un’altra parte, altrimenti sarei finito come un tonno nella rete del suo sguardo. Scossi la testa con risolutezza. «Devo essere da solo in aula, è importante».
Eppure lei non desisteva, come se ci tenesse ad assistere a quell’udienza più che al viaggio a Parigi. «Me ne starò seduta in disparte. Non dovrai preoccuparti di me, lo giuro».
«Neanche per idea. Quando lavoro non voglio distrazioni. Ho bisogno di concentrazione assoluta».
«Voglio vederti con la toga addosso. Per favore…».
«Mi scatterò un selfie davanti alla porta dell’aula e ti manderò la foto. Sarà la prima cosa che farò, promesso!».
L’avevo convinta, roba da non credere. Forse la mia forza di volontà era superiore alle mie inesistenti aspettative?
Proposi ad El Atef di aspettarmi, dopo l’udienza, nella veranda del mio bar preferito, sullo spigolo del palazzo di giustizia.
Mi ero ricordato di fargli firmare la procura speciale e avrei potuto patteggiare anche comparendo da solo in aula. E poi c’era la possibilità che qualcosa andasse storto – non era stato sempre così fino ad allora ?! – ed io avrei potuto parare il colpo improvvisando, senza la paura di una brutta figura col cliente in diretta live.
Quel truce signore che aveva scritto la querela era presente in aula, seduto dalla parte del pubblico, con uno sguardo da falco pieno d’odio per il mondo.
Il pubblico ministero (3) sfogliò il suo codice, dette una breve scorsa alle carte del fascicolo e mi bisbigliò. «Attenuanti generiche equivalenti all’aggravante, quattro mesi già ridotti per il patteggiamento e pena sospesa, prendere o lasciare!».
Ed io presi. La sospensione condizionale della pena significava che El Atef non sarebbe andato in carcere, visto che era incensurato, a meno di non commettere un reato simile negli anni successivi e non c’era davvero ragione di credere che ciò sarebbe accaduto. Lui era davvero una brava persona.
“Quattro mesi e pena sospesa”… avrebbe potuto servire pizze in Italia per tutta la vita, per la sua gioia, quella della sua famiglia ed anche la mia.
Firmai il modulo per il patteggiamento e lo consegnai al giudice, quando fu il mio turno.
Il magistrato era un uomo minuto, dalla voce flebile ma dallo sguardo arguto. La toga continuava a scivolargli verso il basso, lungo la spalla destra, e lui se l’aggiustava di continuo, con una lieve scrollata. Lesse il fascicolo con attenzione e poi mi guardò con occhi impietositi dalla mia faccia da bambino e dai miei ventisette anni, come se sapesse che avevo appena speso i miei primi guadagni per comprare due biglietti per Parigi. Mi fece segno di avvicinarmi a lui. «Avvocato Mayer, vuole davvero patteggiare?».
Intuì che, anche quella volta, le cose non stavano filando lisce e tuttavia simulai sicurezza. «Certo, Signor Giudice».
Allora il suo sguardo divenne più tagliente. «Ne è proprio sicuro?».
Le braccia mi caddero lungo i fianchi. Aprii la bocca, ma non ne uscì neppure un fiato. Era evidente che qualcosa mi sfuggiva e ritenni più opportuno tacere e limitarmi ad ascoltare, pronto a fiutare l’aria come un segugio. Dal basso del mio metro e settantaquattro ero una discreta ala destra nella storica squadra di calcio di amici d’infanzia e conoscevo bene l’importanza di non scoprirsi, per evitare di essere trafitti in contropiede.
Il giudice sventolò, davanti ai miei occhi di giovane schiappa del tribunale, un blocchetto di fogli pinzati l’uno all’altro. «Avvocato Mayer lei ha visto che la querela è stata sporta più di cinque mesi dopo la conoscenza del fatto? E’ sempre dell’idea di patteggiare?».
Sobbalzai d’improvviso ed uno dei primi concetti giuridici che avevo imparato in università si fece spazio nella mia testa confusa. “LA QUERELA VA PROPOSTA ENTRO TRE MESI DALLA CONOSCENZA DEL FATTO”. Mi impettì, in una vampata d’orgoglio, stringendo nel pugno destro il pendaglio della mia toga. «Chiedo scusa. La mia segretaria ha letto male. Ritiro la proposta di patteggiamento e chiedo l’immediata assoluzione del mio assistito per tardività della querela».
“Cavolo, che figata!”. Pensai. La mia voce era risuonata nell’aula perentoria più di quella di mio zio. Non ero mai stato tanto sicuro di me stesso in vita mia. Avrei dovuto stamparmi bene nella mente quel guizzo da predatore, per farne il punto di partenza della mia crescita professionale.
Il giudice, un minuto dopo, si alzò con solennità dalla sua sedia per leggere la sentenza «…di non luogo a procedere per tardività della querela». Si sedette un istante dopo, dispensandomi un largo sorriso.
Incredibile: avevo vinto il mio primo processo, seppur senza troppo merito.
Scesi le scale di marmo, quasi rimbalzando sui gradini. Uscii di corsa dal palazzo di giustizia e mi infilai nel bar in cui avevo dato appuntamento ad El Atef. Lo fissai negli occhi da lontano, costringendomi ad essere DETERMINATO, per una volta nella vita: “Lui non sa del mio errore, non può sapere. Mi basterebbe fingere….e allora fingi, Ale… fingi, almeno una volta nella vita… togliti dagli occhi quello sguardo da perdente…”.
Trassi un profondo respiro ed allargai le braccia. «Il praticante non aveva fotocopiato tutte le carte. Ho studiato meglio il fascicolo e sai cos’ho scoperto? La querela era stata fatta troppo tardi! Niente patteggiamento. Ti ho fatto assolvere!».
Gli occhi del pizzaiolo si illuminarono ed io pensai ch’era stata davvero una bella idea non portarmelo in aula.
Mi convinsi che, dopo tutto, il presidente della Corte d’appello aveva avuto ragione a definirmi furbo, nell’istante in cui, dopo il mio esame orale, aveva annunciato che sarei stato avvocato per il resto della mia vita.
Vidi Atef allungarmi una busta…era gonfia di contanti!
Immaginai un selfie con Claudia, davanti alla Tour Eiffel, e mi ripromisi che quella sarebbe stata solo la prima di tante vittorie.
Querela
E’ condizione di procedibilità dei reati perseguibili, a causa della loro lieve entità, solo ad istanza della persona offesa dal reato (c.d. procedibilità del reato a querela di parte). Si badi che, alla luce della c.d. riforma Cartabia si amplia novevolmente lo spettro dei reati perseguibili a querela di parte, in uno spirito deflattivo della giustizia penale orientato a demandare alla vittima dell’illecito l’effettiva percezione della gravità del reato. Il difetto di querela, quando la stessa è necessaria, ovvero la sua inidoneità ovvero ancora il fatto che l’atto sia sottoscritto da persona non titolata a farlo, può essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento, comportando la declaratoria di non doversi procedere a carico dell’imputato, appunto, per difetto di querela.
La querela, scritta o verbale, è una dichiarazione resa inanzi alle competenti autorità (Procura della Repubblica o forze dell’ordine) dalla vittima del reato. In tale dichiarazione è narrato il fatto-reato, nonché, ove possibile, identificato il responsabile (diversamente si parlerà di querela nei confronti di persone ignote). La querela, per spiegare gli effetti che le sono propri, deve altresì contenere l’esplicita affermazione di volontà da parte del querelante che si proceda penalmente a carico degli autori del fatto (viceversa la querela non sarebbe idonea a fondare la procedibilità del reato).
La querela deve altresì, a pena di decadenza, essere sporta entro il termine di tre mesi (e non novanta giorni come talora erroneamente si ritiene) dalla conoscenza del fatto. A mero titolo esemplificativo, la querela per truffa, allorché la conoscenza del raggiro sia stata acquisita dalla vittima il 24 marzo, dovrà essere formalizzata entro il 24 giugno (lo stesso giorno del terzo mese successivo).
A detto termine ordinario si fa eccezione in caso di stalking e di violenza sessuale. In tale ipotesi la querela potrà essere sporta entro i sei mesi dalla conoscenza del fatto.
L’avvocato incaricato dal proprio assistito di redigere e depositare una querela dovrà avere cura di
- Generalizzare con precisione il querelante, documentando, ove necessario, la legittimazione di costui a firmare l’atto;
- Generalizzare ed identificare, ove possibile, le persone nei cui confronti la querela è sporta;
- Descrivere con linearità e chiarezza i fatti, facendone emergere i profili di illiceità penale;
- Rispettare il termine di tre mesi, dalla conoscenza del fatto, per il deposito della querela stessa;
- Esplicitare la volontà del querelante che si proceda penalmente nei confronti degli autori/coautori del fatto (diversamente l’atto non sarà idoneo a costituire condizione di procedibilità dell’azione penale);
- Dichiarare la volontà del querelante di essere informato in caso di richiesta di archiviazione da parte del PM per poter fare, nel termine di trenta giorni dalla notifica, opposizione innanzi al Gip. Diversamente la notizia di reato potrebbe essere archiviata senza che il querelante ne abbia notizia.
Il difensore dell’imputato, viceversa, avrà cura di eccepire ognuna delle suesposte carenze della querela sporta a carico del proprio assistito. In caso di querela sporta a nome di una persona giuridica, in particolare, sarà cura del difensore diligente appurare se essa sia stata sottoscritta da soggetto legittimato a farlo, ovvero: da persona all’atto delegata con delibera assembleare; dal soggetto cui è riconosciuta tale facoltà a norma dello statuto; da persona, in ogni caso, munita di poteri di rappresentanza estesa agli atti (come la querela) di straordinaria amministrazione.
Patteggiamento
L’applicazione della pena su richiesta di parte (c.d. patteggiamento), disciplinata dagli artt. 444 e ss.ti c.p.p, costituisce una modalità di definizione del procedimento con rito speciale alternativo al dibattimento. Trattasi di un rito premiale, contemplante una riduzione della pena, a fronte del consenso, da parte dell’imputato, ad una definizione del giudizio immediata e senza istruttoria, quindi assicurando al pianeta giustizia un rilevante risparmio di tempo e risorse economiche ed umane.
Il patteggiamento consiste in un accordo tra accusa e difesa sulla pena da irrogare in concreto all’imputato, ma non implica né una sua ammissione di colpevolezza né una prova di effettiva responsabilità in capo all’imputato medesimo.
Il giudice, con sentenza, applica dunque la pena che è oggetto di una concorde “richiesta delle parti” (di qui la parola patteggiamento). Per parti si intendono l’imputato, ovvero il suo difensore munito di procura speciale, ed il pubblico ministero.
Al giudice spetta, unicamente, il compito di verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena concordata tra le parti, anche alla luce della coerente applicazione delle circostanze attenuanti ed aggravanti. Tale verifica ha luogo “allo stato degli atti”, ossia sulla base degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari (fascicolo del PM) e dell’eventuale documentazione offerta dal difensore dell’imputato e relativa all’espletamento di indagini difensive (circostanza poco frequente nella prassi). Il giudice non è mero Notaio ratificante la volontà di accusa e difesa, essendo viceversa chiamato ad un penetrante vaglio di congruità dell’accordo sottoposto al suo esame.
La semplificazione del rito, in caso di patteggiamento, consiste nell’eliminazione della fase dibattimentale e quindi dell’assunzione della prova nel contraddittorio delle parti (non vengono sentiti testimoni, né periti etc). Ai fini della decisione, con sentenza inappellabile ma ricorribile per Cassazione, si utilizzano dunque, come già detto, i verbali degli atti d’indagine.
Effetto premiale dell’istituto è la diminuzione della pena inflitta all’imputato fino ad un terzo. La diminuente, in tal caso, ha natura processuale ed ha applicazione a prescindere da una qualsiasi connessione con la gravità del fatto di reato o con la personalità dell’imputato. Ha, pertanto, rigorosa natura premiale.
Il patteggiamento si distingue profondamente dal giudizio abbreviato.
L’imputato, in effetti, con la richiesta di definizione del processo col rito abbreviato non rinuncia ad affermare, nella dialettica processuale, la propria estraneità ai fatti contestati ed a richiedere al Giudice la propria assoluzione. Inoltre la sentenza resa a definizione del giudizio abbreviato, differentemente da quella emessa ex art. 444 c.p.p., è appellabile e non meramente ricorribile per cassazione.
In secondo luogo, va detto che la declinazione ed articolazione del rito, a seguito della riforma con legge del 12 giugno 2003 n. 134, è duplice:
- Il patteggiamento “tradizionale”, ai sensi del co. 1 dell’art. 445 c.p.p., permette all’imputato ed al pubblico ministero di accordarsi su una pena (prima della riforma Cartabia si parlava di sanzione) sostitutiva o pecuniaria o su di una pena detentiva che, al netto delle riduzioni fino ad un terzo, non superi due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria;
- Il patteggiamento “allargato”, ai sensi del co. 1 dell’art. 444 c.p.p., consente all’imputato e al pubblico ministero di accordarsi su una pena detentiva da due anni e un giorno fino a cinque anni, sola o congiunta a pena pecuniaria, sempre al netto della riduzione premiale fino ad un terzo.
Si tratta, come si preannunciava, di due distinte declinazioni di un medesimo istituto, le quali presentano caratteristiche comuni e, al contempo, profonde differenziazioni. Le differenziazioni, però, vengono attenuate in parte a seguito dell’entrata in vigore della legge di riforma della giustizia.
L’unico requisito comune per l’applicazione dell’istituto, in entrambe le declinazioni, sta nella previsione di un massimo di pena detentiva sulla quale l’imputato ed il pubblico ministero possono accordarsi al netto delle riduzioni premiali per il rito, fino ad un terzo (due anni, in caso di patteggiamento tradizionale; cinque anni in caso di patteggiamento allargato).
Il patteggiamento “tradizionale” consente all’imputato, non solo di pervenire ad una definizione immediata della propria posizione processuale ma anche di godere di molteplici benefici:
- l’imputato può subordinare l’efficacia dell’accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena ad opera del giudice;
- la sentenza che irroga la pena non contempla la condanna al pagamento delle spese del procedimento penale;
- la sentenza che applica la pena non comporta l’irrogazione di pene accessorie;
- la sentenza che applica la pena non comporta l’applicazione di misure di sicurezza, ma tuttavia consente l’applicazione della confisca nelle ipotesi in cui la stessa, ai sensi dell’art. 240 c.p., è obbligatoria o facoltativa. Quest’ultima costituisce una novità introdotta dalla l. n.134 del 2003. In verità con l’entrata in vigore della c.d. riforma Cartabia, è possibile estendere il patteggiamento, sia esso tradizionale o allargato, all’oggetto della confisca facoltativa predeterminando i beni o la somma di denaro che ne sono oggetto;
- Il reato è estinto se l’imputato non commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole entro il termine di cinque o di due anni, a seconda rispettivamente che si tratti di patteggiamento per delitto o per contravvenzione.
Come anticipato, il patteggiamento “allargato” consente all’imputato e al pubblico ministero di concordare una pena da due anni e un giorno fino a cinque anni di detenzione, sempre al netto delle riduzioni fino ad un terzo.
Il legislatore, al contrario dell’ipotesi precedente, nel delineare l’ambito di applicazione del suddetto istituto, al co.1bis dell’art. 444 c.p.p., ha previsto talune cause di esclusione di natura oggettiva e soggettiva.
Sotto il profilo oggettivo l’istituto non trova applicazione in relazione a tre categorie di delitti:
- Associazione di stampo mafioso,
- terrorismo,
- altri gravi delitti, tra cui la violenza sessuale.
Le cause di esclusione soggettiva riguardano coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali, per tendenza e i recidivi reiterati.
I benefici previsti dal codice per il patteggiamento “tradizionale” non trovano tutti applicazione in tale fattispecie, poiché esclusi dai co. 1-2 dell’art. 445 c.p.p.. Tuttavia la disciplina procedimentale e gli effetti della sentenza sono comuni ad entrambi gli istituti.
Con l’entrata in vigore della riforma della giustizia, però, si è previsto che anche in caso di patteggiamento allargato esso possa estendersi all’applicazione delle pene accessorie e alla loro durata.
La sede naturale per la sottoscrizione dell’accordo sulla pena è l’udienza preliminare, ove prevista dal rito, in quanto in tale occasione l’imputato ha già avuto modo di conoscere l’intero fascicolo delle indagini preliminari e di delineare la sua strategia difensiva. Qualora, viceversa, l’udienza preliminare non sia prevista dal rito il termine ultimo per la formalizzazione dell’accordo sarà il compimento delle formalità di accertamento della regolare costituzione delle parti all’udienza predibattimentale (anch’essa introdotta con la riforma e che analizzeremo in altra sede).
Qui di seguito uno schema riepilogativo dei termini entro cui richiedere il patteggiamento (e, altresì, come vedremo, il giudizio abbreviato):
- In caso di udienza preliminare: entro la formalizzazione delle conclusioni in tale udienza;
- In caso di citazione diretta innanzi al Tribunale in composizione monocratica: entro l’udienza predibattimentale;
- In caso di giudizio direttissimo: entro la dichiarazione di apertura del dibattimento;
- In caso di emissione di decreto che dispone il giudizio immediato: entro quindici giorni dalla notifica all’imputato di tale decreto;
- In caso di decreto penale di condanna: con l’atto di opposizione.
L’iniziativa tendente all’accordo e volta all’istaurazione del rito può essere assunta sia dall’imputato, sia dal difensore munito di procura speciale e sia, molto più raramente, dal pubblico ministero.
Una richiesta unilaterale nel corso delle indagini preliminari impone al giudice di fissare un termine entro il quale la controparte potrà esprimere un proprio eventuale consenso: prima della scadenza la richiesta non è revocabile.
Peculiarità dell’istituto è la non ammissione di reità. Infatti il legislatore non ha imposto all’imputato di riconoscere esplicitamente la propria responsabilità nel momento in cui chiede l’applicazione della pena o stipula l’accordo con il pubblico ministero.
Il pubblico ministero ed il giudice hanno una discrezionalità vincolata nel valutare la richiesta di patteggiamento proveniente dall’imputato.
Il pubblico ministero, ai sensi del co.6 dell’art. 446 c.p.p., può dissentire rispetto ad una richiesta di accordo formulata dall’imputato, ma deve enunciarne le ragioni. Tale diniego impedisce al Giudice di decidere sulla richiesta unilaterale dell’imputato.
In presenza di una concorde richiesta dell’imputato e del pubblico ministero il giudice, all’udienza preliminare ovvero, in mancanza di essa, all’udienza predibattimentale:
- Se ritiene corretta la qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti nonché congrua la pena richiesta, con sentenza dispone l’applicazione della pena ed enuncia nel dispositivo che vi è stata richiesta delle parti;
- In caso contrario, con ordinanza, rigetta la richiesta e ordina di procedersi con rito ordinario;
- Infine, può ritenere che, sulla base degli atti, l’imputato debba essere prosciolto; in tal caso pronuncia d’ufficio sentenza con una delle formule terminative previste dall’art. 129 c.p.p.
Il soggetto maggiormente sacrificato nel patteggiamento è la parte civile. Infatti, ai sensi del co.2 dell’art.444 c.p.p. il giudice quando accoglie la concorde richiesta delle parti non può decidere sulla richiesta di risarcimento del danno derivante dal reato a detrimento della persona offesa, potendo solo condannare l’imputato a rimborsare le spese legali da quest’ultima sostenute. In tal caso il danneggiato potrà proporre l’azione di danno autonomamente in sede civile ( la sentenza di patteggiamento, non implicando un accertamento di merito o una ammissione di responsabilità, non sarà idonea a costituire prova della fondatezza della domanda risarcitoria nella separata sede civile).
La sentenza che applica la pena richiesta dalle parti è inappellabile. Inoltre l’ordinanza di rigetto emessa dal giudice del dibattimento di primo grado può diventare oggetto di impugnazione da parte dell’imputato unitamente alla sentenza di condanna. Motivo del gravame sarà in tal caso la non ragionevolezza del diniego ed il giudice dell’impugnazione, potrà, se lo riterrà, emettere sentenza di applicazione della pena. Il pubblico ministero, tuttavia, potrà sottoporre a gravame la sentenza ex art. 444 c.p.p. resa nonostante il proprio dissenso.
Contro la sentenza che applica il patteggiamento possono proporre ricorso per Cassazione sia l’imputato, sia il pubblico ministero per uno dei motivi previsti dal co. 2-bis dell’art. 448 c.p.p., introdotto dalla Riforma Orlando, e attinenti: all’espressione della volontà dell’imputato; al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; all’erronea qualificazione giuridica del fatto; all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Si tratta di un ricorso a critica vincolata, poiché i motivi sono predeterminati ex ante dal legislatore.
L’avvocato diligente avrà cura di chiarire al proprio assistito, a tempo debito e certamente dopo avere consultato interamente il fascicolo del pubblico ministero a seguito di notifica dell’avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., vantaggi e svantaggi di ciascuno dei riti alternativi al dibattimento, e dunque altresì del patteggiamento. Avrà anche cura, in caso di manifestazione d’interesse dell’indagato per un rito speciale, di munirsi di procura speciale. Non potrà astenersi dal consigliare il cliente in punto di strategia processuale, pur senza imporgli una specifica scelta. Sarà suo compito chiarire che, in difetto di certezza della concessione del beneficio della pena condizionalmente sospesa, in particolare in presenza di precedenti condanne, sarà più opportuno optare per il rito abbreviato.
Qualora il cliente si determini ad optare per il patteggiamento, l’avvocato diligente avrà cura di contattare per tempo il pubblico ministero onde trattare le condizioni di un accordo sulla pena. Ciò dovrà avvenire in tempo utile, quindi certamente prima dell’udienza preliminare, se prevista dal rito, ovvero, in caso contrario, prima dell’udienza predibattimentale.
Il giudizio abbreviato rientra tra i cosiddetti riti penali speciali (come il patteggiamento, dal quale tuttavia differisce profondamente e che, nella prassi, ha quasi del tutto soppiantato), i quali si pongono come alternative rispetto alla celebrazione del giudizio ordinario (ovvero destinato a definirsi a seguito di dibattimento con attività istruttoria).
I riti speciali rispondono essenzialmente ad una esigenza di economia processuale: la loro instaurazione consente all’ordinamento un notevole risparmio di risorse oltre che un significativo abbattimento dei costi processuali, ma per giustificare tali finalità è necessario che sussistano specifiche condizioni enunciate dalla legge. Poiché il risvolto della medaglia è rappresentato da una compressione significativa delle protezioni costituzionali in punto di garanzia integrale del diritto di difesa dell’imputato, di sottoposizione dell’imputato medesimo al giudice naturale precostituito per legge e di presunzione di innocenza, si rende opportuno un adeguato bilanciamento tra l’efficienza del sistema processuale e la protezione dei diritti individuali.
I riti speciali presentano perciò delle peculiarità rispetto al rito penale ordinario. Nel caso del rito abbreviato, le principali caratteristiche che lo contraddistinguono sono:
- Rinuncia al dibattimento: questo rito è privo della fase dibattimentale, perciò idoneo ad essere deciso, sommariamente, nella fase dell’udienza preliminare ovvero all’udienza predibattimentale (introdotta con la recente legge di riforma della giustizia e di cui tratteremo più oltre). L’imputato è consapevole che ricorrendo al rito abbreviato non potrà usufruire delle garanzie e delle facoltà di difesa direttamente connesse al dibattimento (facoltà di controesaminare i testi del pubbico ministero e della parte civile, facoltà di citare in giudizio propri testi a discarico, di richiedere confronti, perizie etc) ed accetta tale limitazione del proprio diritto di difesa in cambio della riduzione di un terzo della pena eventualmente inflitta, in caso di accertamento giudiziale della propria colpevolezza;
- premialità: questo rito si fonda su una scelta libera, consapevole e volontaria da parte dell’imputato. La ragione per cui un imputato rinuncia ad importanti garanzie come quelle dibattimentali è connessa alla premialità di questo rito, ovvero alla possibilità di ottenere un cospicuo sconto di pena (diminuzione di un terzo della pena che il giudice ritiene irrogabile in concreto, a seguito di bilanciamento ed applicazione di circostante attenuanti ed aggravanti).
- Terzietà del giudice: il rito abbreviato è fondato essenzialmente su atti di parte, per lo più del pubblico ministero. Allorché ammette il richiedente al rito, infatti, il Giudice chiamato a decidere ordina al pubblico ministero la consegna del proprio fascicolo, contenente tutti gli atti d’indagine che costituiranno il compendio documentale da porre a base della decisione. Nell’ipotesi, viceversa, che il Giudice del dibattimento rigetti la richiesta di definizione del processo col rito abbreviato, ritenendolo non decidibile allo stato degli atti, dopo avere consultato il fascicolo del pubblico ministero, avrà cura di designare altro giudice per il proseguimento del processo col rito ordinario, in quanto egli sarà divenuto incompatibile (in effetti il giudice che celebra il processo col rito ordinario deve giungere “vergine” alla fase istruttoria, nella quale sola si forma la prova, senza essere condizionato dalla previa conoscenza di elementi investigativi acquisiti dal PM in segreto, senza la presenza del difensore dell’imputato, di un giudice terzo e fuori dal contraddittorio delle parti).
La legge prevede due diverse tipologie di giudizio abbreviato. Possiamo pertanto distinguere:
- un giudizio abbreviato fondato su una richiesta semplice (c.d. rito abbreviato non condizionato), con la quale l’imputato si limita a chiedere di essere giudicato all’udienza preliminare o all’udienza predibattimentale (o, in caso di giudizio direttissimo o immediato, ovvero in caso di opposizione a decreto penale di condanna, al dibattimento), allo stato degli atti, vale a dire sulla base dei soli atti d’indagine contenuti nel fascicolo del PM (art. 438 comma 1, c.p.p.) rinunciando irrevocabilmente e radicalmente a qualsiasi mezzo di prova a proprio favore, anche puramente documentale. In questo caso il giudice dispone l’ammissione del richiedente a tale rito senza compiere alcun vaglio di merito e solo a seguito di una valutazione di definibilità del processo allo stato degli atti. In tal caso la rinuncia all’istruttoria da parte dell’imputato richiedente è incondizionata ed assoluta;
- un giudizio abbreviato fondato su una richiesta complessa o condizionata: In questo secondo caso, nella richiesta, l’imputato pone come condizione quella di assumere determinati mezzi di prova, ulteriori rispetto a quelli custoditi dal P.M. nel fascicolo delle indagini preliminari, sulla base di presunte lacune negli atti frutto delle indagini. L’abbreviato può essere condizionato alla mera produzione in giudizio di documenti ovvero all’esperimento di perizie o all’audizione di testimoni. Stante questo ulteriore elemento di complessità, nell’ipotesi di richiesta di abbreviato condizionato, sarà necessario un controllo di ammissibilità più approfondito, da parte del giudice.
Il giudice rifiuterà verosimilmente la richiesta quando la difesa condizionerà il rito all’audizione di numerosi testimoni, in quanto in tal caso sarebbe vanificato l’obiettivo, proprio dei riti speciali premiali, del risparmio di risorse economiche e processuali che sole possono giustificare il rilevante beneficio dello sconto di pena di un terzo.
La recentissima Riforma Cartabia ha apportato diverse modifiche all’art. 438 comma 5 c.p.p., in particolare ha ampliato i presupposti per accedere al giudizio abbreviato condizionato: “tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili”, il giudice “dispone e accetta la richiesta se il rito realizza le esigenze di economia processuale in relazione ai prevedibili tempi dell’istruzione dibattimentale”. Questa disposizione, elastica, ha ampliato le maglie della concedibilità del rito.
Ciò appare importante in quanto, nella prassi forense ante riforma, si assisteva spesso alla negazione di abbreviato condizionato all’audizione anche di un solo testimone.
Il giudice non avrà, viceversa, problemi ad ammettere l’imputato all’abbreviato condizionato da mera produzione documentale.
Come anticipato nel precedente paragrafo, l’iniziativa per l’instaurazione del giudizio abbreviato è rimessa esclusivamente all’imputato o al suo difensore, purché munito di procura speciale, in quanto trattasi di un atto personalissimo. Non è quindi necessario, al contrario del patteggiamento, un consenso del P.M., avendo peraltro ritenuto la Corte Costituzionale che tale rito sia compatibile con il principio della parità delle parti.
L’imputato che intenda fare ricorso allo strumento del giudizio abbreviato è tenuto a farne richiesta entro termini ben precisi. I termini sono gli stessi previsti per la formalizzazione della richiesta di patteggiamento (V. supra).
Una volta perfezionata la richiesta, il giudice dovrà effettuare un vaglio di ammissibilità della stessa.
Con riguardo allo svolgimento procedurale, va detto che il rito si celebra in camera di consiglio salvo che l’imputato non chieda che la trattazione abbia luogo nelle forme della pubblica udienza, ossia con ammissione del pubblico. All’udienza in camera di consiglio partecipano le parti principali del procedimento, ossia l’imputato, il suo difensore ed il pubblico ministero. Anche una eventuale parte civile costituita può prendervi parte, ma una sua non accettazione del rito non potrà arrestarne lo svolgimento.
Lo svolgimento dell’udienza varia in relazione al tipo di rito abbreviato ammesso. Qualora si tratti, infatti, di rito non condizionato ovvero semplice, abbiamo detto che non sono previste integrazioni probatorie e che il giudizio è idoneo ad essere deciso allo stato degli atti. Tuttavia, esiste la possibilità per il giudice di assumere d’ufficio alcune prove qualora lo ritenga necessario per la decisione. In questo caso potrà essere assunto qualsiasi mezzo di prova, indipendentemente dal dispendio di tempo che l’attività istruttoria comporti, stante la non revocabilità dell’ordinanza che ha ammesso il rito con richiesta semplice.
Qualora il rito in esame sia stato invece disposto sulla base di una richiesta complessa dell’imputato, il giudice deve assumere le prove indicate dall’imputato, facendo comunque salva la possibilità per il pubblico ministero di ottenere l’ammissione di prove contrarie a quelle indicate dall’imputato.
Per quel che concerne la decisione del giudizio abbreviato, si applicano nel caso di specie le stesse norme previste per la sentenza dibattimentale, in particolare quelle di cui agli artt. 529 e ss.ti del codice di procedura penale. Come nel rito ordinario, infatti, anche nell’abbreviato per poter statuire una condanna è necessario che la responsabilità penale dell’imputato sia provata oltre ogni ragionevole dubbio, poiché in caso contrario dovrebbe senz’altro emettersi sentenza di proscioglimento (eventualmente anche ai sensi dell’art. 530 comma II c.p.p.).
Per quanto concerne gli elementi che fondano la decisione, si tratta di:
- Atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero;
- Eventuali atti di indagine suppletiva.
- prove assunte nell’ambito del rito abbreviato e gli eventuali atti di indagini difensive presentati con la richiesta.
Con l’eventuale sentenza di condanna, il giudice riduce la pena di un terzo quando si procede per un delitto e della metà quando si procede per una contravvenzione. Lo sconto si applica alla pena determinata in concreto, quindi al netto anche di eventuali applicazioni e bilanciamenti di circostanze attenuanti o aggravanti.
La sentenza emessa all’esito del giudizio abbreviato è appellabile. In particolare, le sentenze di proscioglimento sono appellabili dal pubblico ministero ma non dall’imputato (salvo che sia pronuncia la non imputabilità dello stesso per vizio totale di mente), mentre quelle di condanna possono essere appellate dal pubblico ministero solo se si tratta di condanna per un reato diverso da quello che era indicato nell’imputazione. Non sono invece mai soggette ad impugnazione, nemmeno dal condannato, le sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda.
Si precisa che anche l’eventuale giudizio di secondo grado è destinato a svolgersi in camera di consiglio.
Consigli pratici: quando conviene optare per il rito ordinario?
- Quando si approssimano i termini di prescrizione del reato o dei reati contestati all’imputato;
- Quando l’ipotesi accusatoria appare aggredibile controinterrogando i testi dell’accusa o articolando prova orale a discarico, non ammissibile in sede di abbreviato condizionato.
Quando conviene optare per il rito abbreviato?
- Quando non è concreta la prospettiva di una prescrizione del reato, e le prove a discarico articolabili non sono eccessivamente numerose o complesse e quindi compatibili con un abbreviato condizionato. Quando, con la diminuzione di pena di un terzo, si hanno concrete probabilità di ottenere i benefici della sospensione condizionale della pena o del contenimento della stessa al di sotto degli anni quattro, per ottenere, in tale ultima ipotesi, già nel dibattimento l’applicazione di pene sostitutive ovvero, in sede di esecuzione, l’applicazione di pene alternative alla detenzione.
Quando conviene optare per il patteggiamento?
- Solo nel caso che si profili assai conveniente l’accordo sulla pena col pubblico ministero, tale da consentirne la sospensione condizionale o da scongiurare l’ipotesi di una condanna assai più dura, sempre, ovviamente, che non appaiano percorribili strategie difensive quanto alla prova e che l’ipotesi della prescrizione sia remota.
Pubblico Ministero
Il pubblico ministero (spesso abbreviato in P.M. o PM), nell’ordinamento giudiziario italiano, è un organo dell’amministrazione della giustizia ripartito in più uffici dell’ordinamento giudiziario. Al pubblico ministero spetta il delicato compito di vigilare sull’osservanza delle leggi, sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia, sulla tutela dei diritti dello Stato, delle persone giuridiche, degli incapaci e dei soggetti minorenni; nonché quello di promuovere la repressione dei reati e l’applicazione delle misure di sicurezza. In materia penale, in particolare, il pubblico ministero ha il compito di esercitare l’azione penale ovvero, a seguito dell’espletamento delle indagini preliminari, di richiedere il rinvio a giudizio di colui/coloro che ritenga autori di reato, formulando il relativo capo d’imputazione (qualora, viceversa, il PM ritenga che non sussista una ragionevole previsione di condanna dell’imputato, avrà cura di richiedere al GIP l’archiviazione della notizia di reato).
In tale ultimo ambito, il PM rappresenta l’organo giudiziario esplicante la funzione inquirente (investigativa) e requirente (richiesta al giudice di provvedimenti), ed è designato dal vigente codice di rito, ispirato al sistema accusatorio a seguito della riforma della procedura penale del 1988, come parte del procedimento penale (DPR 22.09.1988 n. 447).
A norma dell’art. 70 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le funzioni del Pubblico Ministero sono esercitate dal procuratore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari, o da funzionari subalterni loro sostituti. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono invece esercitate dall’avvocato generale, a norma dell’articolo 59 del medesimo decreto.
A norma degli artt. 74 e 75 del Regio Decreto n. 12/1941, l’ufficio del pubblico ministero ha competenza in materia penale, civile ed amministrativa. Tuttavia le funzioni attribuite all’ufficio in materia penale sono indubbiamente preminenti, se si considera che al Pubblico Ministero è attribuito l’esercizio dell’azione penale e l’esecuzione delle sentenze di condanna passate in giudicato, con la notifica al reo dell’ordine di esecuzione della pena (unitamente ad eventuale ordine di sospensione per pene inferiori ai quattro anni).
In ambito penale, il pubblico ministero esercita l’azione penale quando intravede una ragionevole previsione di condanna (così la c.d. riforma Cartabia). Tali funzioni sono esercitate, nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado, dai magistrati della Procura della Repubblica (art. 51 c.p.p.). Spettano alla Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, oltre ai procedimenti di competenza di quest’ultimo, quelli che rientrano nella competenza del giudice di pace e, nelle sedi ove è istituita, della corte d’assise; spettano, invece, alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni i procedimenti che rientrano nella competenza del medesimo essendo i fatti reato perpetrati da persone che non abbiano, all’epoca del reato, compiuto i diciotto anni.
Il PM gode, inoltre, delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Un ufficio inquirente e requirente particolare è la Direzione Nazionale Antimafia (DNA) che ha il compito di coordinare l’attività investigativa nel settore della criminalità organizzata.
Secondo l’art. 109 della Costituzione della Repubblica Italiana, «l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria».
Ogni Procura della Repubblica dispone, pertanto, della rispettiva sezione di polizia giudiziaria. Il personale è quello delle forze di polizia italiane (talvolta anche delle capitanerie di porto) scelto dal Procuratore della Repubblica. Queste sezioni dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite, e gli ufficiali ed agenti addetti non possono essere trasferiti o dispensati se non con il loro consenso e su provvedimento del Procuratore della Repubblica.
La Procura generale della Repubblica dispone di tutte le sezioni di polizia giudiziaria istituite nel distretto di corte d’appello.
Sempre nell’ambito penale, il Pubblico ministero svolge in massima parte funzioni di tipo inquirente. Infatti, con l’abrogazione del codice di procedura penale del 1930, il PM non ha più poteri di tipo inquisitorio che consentivano, con l’istruttoria formale, di poter decidere, sulla base delle prove raccolte, il rinvio a giudizio o l’eventuale assoluzione dell’imputato.
Dal 1988, con l’introduzione del nuovo codice di procedura penale, l’organo di accusa conduce le indagini preliminari, ossia unitamente alla polizia giudiziaria, che dirige e di cui si avvale, raccoglie gli elementi di prova, ai sensi di quanto disposto nel Libro V del vigente c.p.p.
Solo in seno al dibattimento, innanzi al giudice e nel contraddittorio col difensore dell’imputato, si formeranno le vere e proprie prove.
Il PM, pertanto, ha l’onere di richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) l’emissione del decreto d’archiviazione, qualora ritenga che non vi sia una ragionevole previsione di condanna, ovvero al Giudice dell’udienza preliminare (GUP) il rinvio a giudizio del medesimo – salvo i casi di citazione diretta a giudizio. Ciò in quanto non può autonomamente decidere se sottoporre a processo penale l’indagato, come pure se archiviare una notizia di reato. Parimenti il PM chiede al GIP l’emissione del decreto penale di condanna, nonché l’emissione di un provvedimento applicativo di misura cautelare (come abbiamo visto a proposito delle misure cautelari).
In caso di inerzia del PM o di contrasto tra due o più PM, le funzioni inquirenti nelle indagini e nei procedimenti penali possono essere avocate da parte del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello ai sensi dell’art. 412 c.p.p.
Presso la Corte di Cassazione, la funzione del Pubblico Ministero è solamente requirente, non essendo allo stesso organo demandati poteri investigativi e di raccolta di elementi di prova (nei procedimenti innanzi alla Suprema Corte di Cassazione non vi è istruttoria, ma mera discussione in ordine ai ricorsi ai fini di un giudizio di pura legittimità).
Il PM, nelle forme e nei casi previsti dal codice di rito penale, infine, può proporre l’impugnazione avverso provvedimenti, come ordinanze o sentenze, che siano contrari alle proprie richieste, ricorrendo in appello o innanzi alla Corte di Cassazione.
Nell’udienza, il magistrato del Pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia. Il superiore gerarchico, o “capo dell’ufficio”, ossia il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Generale, provvede alla sua sostituzione nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in altri casi espressamente previsti dalla legge.
Negli altri casi, il Pubblico ministero può essere sostituito solo con il suo consenso qualora egli si astenga ex art. 36 c.p.p. Infatti, il Pubblico ministero a differenza del giudice non può essere ricusato dalle parti per gravi ragioni di convenienza (art. 37 c.p.p.). Il magistrato inquirente, secondo la lettera del codice di procedura penale, non ha l’obbligo, bensì la “facoltà” di astenersi, qualora vi siano gravi ragioni di convenienza. Tuttavia, il PM, qualora non ritenga di doversi astenere, potrebbe essere sostituito dal superiore gerarchico, ma solo nei casi previsti dalla legge, fermo restando l’eventuale esercizio della sanzione disciplinare e conseguente responsabilità interna del magistrato del Pubblico ministero di fronte al capo dell’ufficio.