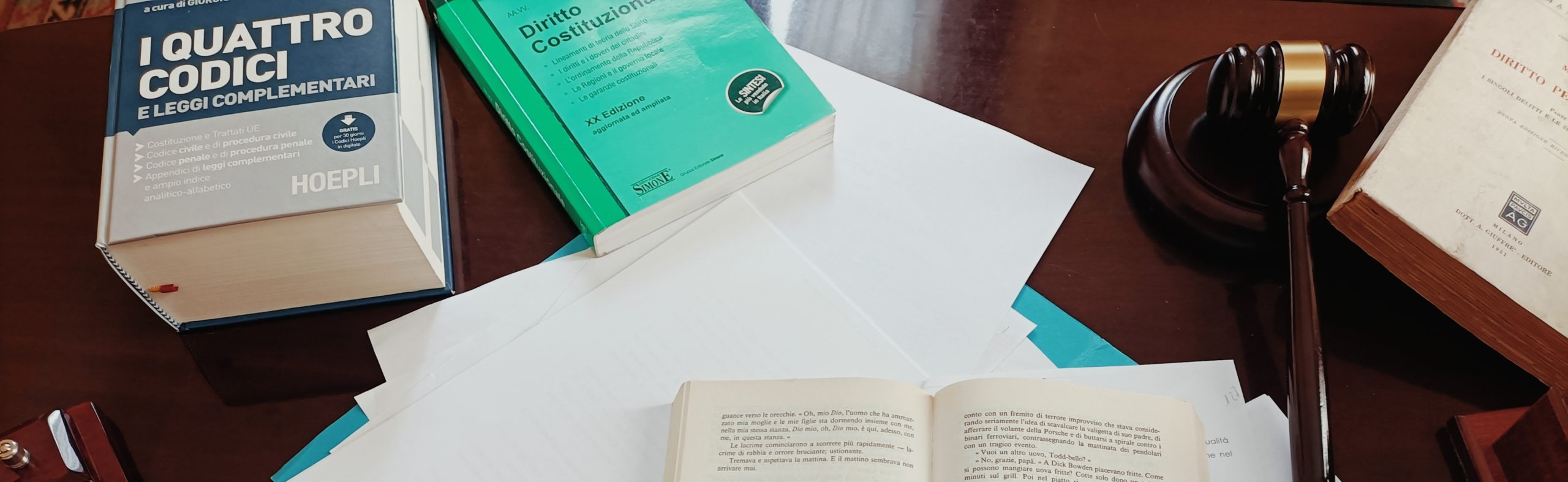Diritto penale
Una Prigione Dorata
La Porsche sfrecciava sulla grigia striscia d’asfalto della Milano Laghi.
Zio Arturo impugnava il volante come fosse un’arma e intanto, col solito piglio dell’affabulatore, mi parlava del nostro nuovo cliente, Ivan Alexandrov, ricchissimo imprenditore russo di San Pietroburgo.
Il tizio aveva programmato un soggiorno turistico da favola in Italia, tra Milano, Venezia, Firenze, Roma e le innevate piste di Courmayeur, con la sola compagnia del suo fedele autista. Tuttavia, al suo sbarco alla Malpensa, invece del comitato d’accoglienza del lussuoso albergo del centro di Milano, ove aveva prenotato per tre notti, ad attenderlo aveva trovato quattro signori dallo sguardo truce, armati di tutto punto, con l’incarico di condurlo presso una dimora assai meno accogliente: il carcere di Busto Arsizio. Gli avevano notificato un ordine d’esecuzione di pena detentiva: un mese di reclusione.
La vicenda raccontata da mio zio era tanto surreale, da sfiorare il ridicolo. Quattro anni prima, Alexandrov, anche in quell’occasione in viaggio turistico in Italia, si era reso responsabile di un maldestro incidente automobilistico a seguito del quale un venditore ambulante di Sorrento aveva riportato lievi ferite. Il processo si era svolto in contumacia, poiché Alexandrov aveva lasciato l’Italia pochi giorni dopo l’incidente, senza avere il tempo e l’avvedutezza di lasciare alle autorità un proprio recapito in patria. Il difensore d’ufficio che lo aveva assistito, forse un pivello alle prime armi, si era persino dimenticato di chiedere la sospensione condizionale della pena (1), benché il suo assistito fosse incensurato.
La sera precedente, il fratello di Alexandrov si era presentato alla porta dello studio Battaglia, poco dopo le venti, per firmare il mandato difensivo a zio Arturo e consegnare una busta con diecimila euro in contanti, dichiarando di non essere interessato ad una fattura. Mio zio non aveva perso tempo ed aveva passato l’intera serata a digitare sulla tastiera del suo pc portatile, per meritare un saldo finale della parcella in linea col generoso anticipo.
Mentre mi riferiva questo particolare, a mio zio sfuggì un sorriso sardonico. Poi piegò il viso di lato, per avvicinarlo al mio, rischiando di perdere di vista la strada. Vidi i suoi occhi illuminarsi d’orgoglio. «Non non siamo dipendenti, Ale, siamo professionisti. Per gente come noi, che non timbra il cartellino, la sirena di fine servizio non suona mai. Quando hai a che fare coi detenuti, il camice dell’operatore di giustizia non te lo togli mai di dosso. E per una parcella cospiqua devi essere pronto a lavorare anche di notte».
Io annuii, anche se sull’argomento mi sentivo alquanto impreparato. Di parcella non ne avevo incassata nemmeno una e nessun cliente che potessi definire personale aveva ancora varcato la soglia della mia stanza, l’ultima a sinistra, alla fine del corridoio, accanto a quella del mio mentore.
Lo zio, subito dopo avere superato il casello autostradale, fece uno scatto laterale in direzione della corsia d’emergenza e mi fissò di nuovo, con i suoi occhi da corvo. Feci appena in tempo a capire che stava per materializzarsi alla sprovvista l’ennesimo capitolo di un eterno esame di procedura penale. «Rispondi al volo, senza pensare. Stando così le cose, come dobbiamo muoverci per il nostro Alexandrov?».
Una vampata calda mi torturò le tempie, mentre mio zio rimetteva in moto la sua Porsche. Fin dai tempi della scuola odiavo essere interrogato a bruciapelo, anche perché sono sempre stato un pessimo improvvisatore. Frugai nel confuso bagaglio delle mie conoscenze e diedi la risposta che mi parve più ragionevole. «Impugniamo la sentenza? Voglio dire, facciamo appello?».
Due tondi punti neri, profondi come gallerie, mi trafissero il petto da sinistra, senza che io potessi difendermi. «Se abbiamo un ordine di esecuzione della pena vuol dire che la sentenza è definitiva, non ti pare? Vedi di far girare le rotelline che hai in tesa e di ragionare!».
Ebbi paura, sia di fare brutta figura sia del fatto che mio zio, a furia di tormentarmi col suo sguardo inquisitore, andasse a sbattere contro uno dei camion che accostavano a destra. Ebbi un’illuminazione, evento piuttosto raro dalle parti del mio cervello, e mi portai una mano alla fronte. «Ah, già…dobbiamo fare un’istanza urgente al magistrato di sorveglianza (2), per l’applicazione provvisoria delle pene alternative alla detenzione».
Per mia fortuna lo zio annuì ed i tratti del suo volto sembrarono distendersi. «Molto meglio, Ale. Molto meglio!». Poi, staccando la mano dal volante, afferrò una cartelletta di plastica che aveva adagiato sul cruscotto, ne estrasse due fogli dattiloscritti e me li porse. «Ieri sera ho preparato un’istanza di detenzione domiciliare (3) in albergo, leggila!». Ricordo bene che mi sfuggì una smorfia di sbalordimento. «Detenzione domiciliare in albergo?! Ma che idea è?». Lo zio scosse la testa, deluso dal mio stupore. «Ho allegato la dichiarazione di ospitalità del direttore del più prestigioso albergo di Milano. Non c’è altra soluzione. Il fratello di Alexandrov è già ripartito per la Russia, senza poter garantire un alloggio in zona». Poi distillò una delle sue ampollose perle di presunta saggezza giuridica. «Se i giudici sono i notai della giustizia, noi avvocati ne siamo gli artisti. Non dobbiamo stancarci di inventare, di essere creativi, di ribaltare il punto di vista comune».
Feci segno di sì, con amarezza, in preda al fondato sospetto che non sarei mai diventato un bravo avvocato, visto quanto era prevedibili e banali i pochi neuroni che saltellavano nella mia mente e che speravano che venisse presto il venerdì sera.
Il palazzo di giustizia di Varese era simile ad una casa di bambole, tutto di mattoni rossi e con, al centro della struttura, un balcone imbandierato che sembrava un arengario.
Ci arrivammo in meno di un’ora, perché lo zio aveva tenuto per tutto il viaggio una velocità da autodromo.
Depositammo a mani di un distratto cancelliere l’istanza con gli allegati, tra cui la carta intestata col timbro dell’albergo e la firma del direttore. Poi, una volta soli nel corridoio, lo zio batté due volte la sua manona sulla mia spalla, tutta pelle ed ossa. «Sai che cosa devi fare!». Per un istante rimasi impalato, col fermo convincimento che nemmeno un’intera giornata mi sarebbe bastata a risolvere quell’enigma. Poi mi ricordai di una delle prime lezioni di vita forense impartitemi dallo zio: “Mai fidarsi dei cancellieri, un bradipo è più veloce di loro. Quando hai depositato un atto urgente, bussa subito alla stanza del giudice, guadagnerai tempo prezioso…specie quando c’è di mezzo un detenuto!”.
Così feci, mentre lo zio si fumava una sigaretta nel parcheggio del Tribunale. Scivolai, timido come un fantasma, nella stanza del giudice, non appena, da fuori, un “AVANTI” fu risuonato fragoroso come uno sparo. Nella mano destra stringevo una copia del ricorso, col timbro di deposito già stampato. Il magistrato mi indicò una sedia e, con mia sorpresa, si mise subito a leggere l’atto di zio Arturo. Per due volte sembrò rimbalzare sulla sedia, nello sforzo di trattenere una risata. Poi mi lanciò uno sguardo in tralice, sotto due spesse lenti da miope. «Caso davvero anomalo. Questo signore è incensurato?».
Mi diedi un tono, provando a fare del mio meglio. «Oh sì, Signor giudice. Non ha nessun processo in corso, né precedenti condanne. Si è trattato di vera sfortuna. La vittma se l’è cavata con pochi giorni di ospedale. L’avvocato d’ufficio non ha neppure chiesto la condizionale. Il nostro cliente non ha potuto difendersi». Il magistrato annuì pensoso, mentre con indolenza lasciava cadere i pochi fogli del ricorso sulla sua scrivania. Mi congedò con un sorriso freddo. «Provvederò domani».
«La ringrazio molto, Signor giudice». Lasciai il tribunale di Varese fiero di me stesso, illudendomi che il mio intervento fosse risultato decisivo. «Esce domani, tutto alla grande». Annunciai allo zio, mentre salivo sulla sua macchina.
Ed invece quel solerte magistrato emise l’ordinanza di accoglimento del ricorso quel pomeriggio stesso.
L’indomani mattina, quattro solerti membri della scorta organizzarono il trasloco di Alexandrov dall’umida cella del carcere di Busto Arsizio, nelle campagne del varesotto, alla suite di un lussuoso albergo, nel centro di Milano.
Lo zio si fregava le mani, pensando al saldo finale della sua parcella. «Magari clienti così capitassero ogni mese!».
Nei giorni successivi, in studio, si susseguirono aneddoti grotteschi sul conto di Alexandrov.
La segretaria, che era al fianco di zio Arturo dal giorno del suo giuramento come neoavvocato, disse che, con la complicità del direttore d’albergo, quel riccone aveva trasformato la sua stanza in un Harem frequentato, da prostitute e pseudo massaggiatrici.
Marcello, un giovane praticante ingaggiato da un mese, raccontò che Alexandrov aveva spedito il suo autista personale dalle mogli dei suoi due compagni di cella, perché lasciasse ad entrambe un ragguardevole quantitativo di banconote «perché i loro mariti erano stati gentili con lui e gli avevano rifatto il letto». La segretaria, che pretendeva sempre di avere l’ultima parola, aveva avanzato il sospetto che l’impreditore russo avesse prezzolato anche i poliziotti che avrebbero dovuto controllare i suoi movimenti, visto che in albergo non si era visto nessun membro delle forze dell’ordine. Disse che il tizio trascorreva le sue due ore quotidiane di permesso all’aperto a fare shopping in Via Monte Napoleone e che aveva scritto al suo socio che si sarebbe trattenuto in Italia un mese oltre il previsto, per portare a termine il suo piano di viaggio.
Il mese di detenzione domiciliare era quasi finito, quando il viso magro e spigoloso dello zio fece capolino oltre la soglia della mia stanza, la più piccola e buia di tutto lo studio. Mi chiese di fare visita ad Alexandrov. «…vuole vederti, per ringraziarti. Vacci, è gente generosa e piena di soldi».
Accettai di buon grado; ero proprio curioso di guardare negli occhi un miliardario russo, per cercare di capire come diavolo avesse fatto a raggranellare tanto denaro. Se ne avessi avuto l’occasione gliel’avrei chiesto, alla faccia della riservatezza.
Quando misi piede in quella camera d’albergo, gli occhi mi si accesero come fanali e faticai ad evitare di mettermi a ridere. Quella suite sembrava un mausoleo, con il letto a baldacchino, arazzi, specchi e quadri dalle pesanti cornici ad impreziosire le pareti piene di stucchi.
Alexandrov era inerte, disteso sopra un interminabile divano Chesterfield, con due giovani donne affaccendate sul suo corpo con l’amorevole operosità delle restauratrici di un’opera d’arte. La più giovane, seduta ad un capo del divano, era intenta a limargli le unghie. L’altra gli massiaggiava con delicatezza le spalle, le braccia ed il petto, sussurrandogli misteriose parole all’orecchio. Lui sorrideva e faceva segno ad entrambe di continuare.
Lungo l’intero perimetro della stanza erano disposte in ordinata schiera decine e decine di bottiglie di vino, birra, Rhum, vodka e Whisky. Il rettangolare esercito di vetri e lattine si snodava da uno stipite della porta d’ingresso a quello opposto, senza soluzione di continuità ed accarezzando per intero ciascuna delle quattro pareti. Ivana, l’interprete, era seduta in un angolo appartato. Era una donna di grande cultura. L’avevo conosciuta in studio, perché mi aveva aiutato a tradurre in russo una mail da spedire al fratello di Alexandrov, con una informativa aggiornata sulla pratica. Notò la mia divertita curiosità ed indicò la bottiglia più vicina alla sua sedia. «E’ un gioco russo. Gli amici non vanno via dalla festa finché il giro non è completo. Ovviamente alla fine sono tutti ubriachi».
Mi limitai a sorridere, stringendomi nelle spalle.
Il cliente borbottò qualcosa, con voce rotta dall’alcool.
Ivana mi fissò con occhi vitrei. «Dice che per te fa arrivare una bella ragazza e tanta vodka! Dice che devi divertirti perché hai troppo la faccia del bravo ragazzo!».
Rimasi di stucco. Mai nella vita mi ero sentito così a disagio. Il mio immobilismo fisico e mentale fu scosso dall’immagine del volto di Claudia, la mia ragazza, severo e bisognoso di attenzioni, come sempre. Per l’imbarazzo credo di essere diventato bianco e rosso, come la bandiera della Croazia. Cercai le parole più appropriate per declinare l’offerta, senza offendere il mio benefattore mancato.«Può dirgli che lo ringrazio ma che non posso accettare?».
Alexandrov doveva avere capito, perché, col braccio, indicò un tavolinetto. Feci due passi, seguendo l’immaginaria linea tracciata dal suo dito indice, e raccolsi una pila di banconote ammonticchiate.
L’uomo lasciò cadere il braccio e bisbigliò poche parole. «Grazie. Questa è vacanza più bella di mia vita…».
Questa volta non riuscii a trattenere una risata.
Sospensione condizionale della pena
Consiste nel beneficio riconosciuto al condannato, al termine del processo penale,consistente nella sospensione dell’esecuzione della pena per 5 anni (nel caso dei delitti) o per 2 anni (per le contravvenzioni). Alla sospensione consegue l’estinzione del reato solo ove il reo non commetta un nuovo reato della stessa indole, nei cinque anni successivi. Di questo beneficio può fruire il reo condannato a non più di 2 anni di pena detentiva o a non più di 2 anni e 6 mesi se si tratta di persona che ha compiuto gli anni diciotto ma non ancora gli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta o a non più di 3 anni se il condannato è minore di anni diciotto. Il ridetto beneficio viene concesso al reo a condizione che costui non sia già stato condannato a pena detentiva per un delitto, non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ex artt. 163 e ss.ti c.p. e la condanna non comporti l’applicazione di una misura di sicurezza per pericolosità sociale. Il giudice può altresì concedere il beneficio al reo già condannato per un solo precedente reato, a condizione che la pena inflitta, sommata a quella irrogata in precedenza, non superi la soglia massima indicata ut supra. In tale ultimo caso, tuttavia, la concessione del beneficio è subordinata al risarcimento del danno e alle restituzioni alla vittima del reato (salvo che la pena inflitta sia inferiore all’anno). Il beneficio è concesso dal giudice con la sentenza che definisce il processo solo su richiesta di parte (non d’ufficio) a seguito della verifica della sussistenza delle condizioni di legge predette e formulata una prognosi favorevole sulla condotta di vita futura da parte del reo (visto l’art. 133 del codice penale contemplante i criteri per determinare la gravità del reato e l’entità della pena da irrogare). La concessione del beneficio può essere subordinata dal giudice al risarcimento del danno patito dalla vittima del reato, nonché alle necessarie restituzioni. Il beneficio è revocato dal Giudice dell’esecuzione su richiesta del pubblico ministero se sopravviene, nel tempo predetto (5 anni in caso di delitti, 2 anni in caso di contravvenzioni), una condanna per reato della stessa indole. Per reati della stessa indole, come da costante giurisprudenza, s’intendono fatti costituenti illecito di rilevanza penale che violino lo stesso bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice. A mero titolo esemplificativo va detto che la truffa può essere considerato reato della stessa indole del furto, poiché entrambi sono reati contro il patrimonio, ma non dell’omicidio stradale, che è reato contro la persona. In effetti, a ben pensarci, reati tanto dissimili non possono essere ritenuti espressione di un’unitaria inclinazione all’illecito penale essendo palesemente frutto di impulsi e circostanze assai diverse.
Qualora nel detto termine di 5 anni il reo, condannato a pena sospesa, non commetta un reato della stessa indole, il reato per il quale ha ottenuto la sospensione condizionale della pena è estinto e pertanto la sanzione irrogata non avrà mai concreta esecuzione.
Magistrato di sorveglianza
Il magistrato di sorveglianza (fino al 1986 denominato giudice di sorveglianza), nell’ordinamento giudiziario italiano, è un organo monocratico con competenze relative all’esecuzione della pena. Esercita le sue funzioni, dunque, in una fase successiva all’emanazione di una sentenza definitiva di colpevolezza (vale a dire a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione, ovvero di sentenza di primo grado o d’appello non impugnate nei termini di legge rispettivamente con l’appello o con il ricorso per cassazione). Esplica attività di vigilanza sulle carceri italiane e controlla che l’attuazione del programma di trattamento del condannato e dell’internato risulti conforme ai principi risocializzativi sanciti dalla costituzione (art. 27 costituzione) e dall’ordinamento penitenziario, attraverso visite accurate e l’audizione dei detenuti. Fu istituito con l’approvazione della legge di riforma dell’ordinamento penitenziario italiano (legge 26 luglio 1975 n. 354).
Il Magistrato di sorveglianza assicura, pertanto, la tutela dei diritti dei detenuti e ad istanza dell’interessato:
- Concede la liberazione anticipata (sconto di quarantacinque giorni della pena inflitta per ogni semestre di buona condonna all’interno del carcere o di rispetto delle prescrizioni per coloro che si trovino in detenzione domiciliare. Si badi che a seguito della c.d. Riforma Cartabia lo sconto di pena per ogni semestre può essere elevato a 75 giorni in casi eccezionali per detenuti che si siano segnalati come particolarmente meritevoli di un trattamento premiale);
- Riconosce i permessi premio, ovvero per ragioni familiari;
- Ammette il detenuto al lavoro all’esterno dell’istituto di pena;
- Autorizza il detenuto ad effettuare visite specialistiche e a sottoporsi a ricoveri ospedalieri, anche per infermità psichica;
- Approva il programma di trattamento rieducativo individualizzato per ciascun detenuto.
Inoltre applica al richiedente, in via provvisoria, qualora vi siano ragioni di urgenza, le pene alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare), qualora ritenga che in tal senso disporrà in via definitiva il Tribunale di Sorveglianza. Si pensi, ad esempio, al condannato che abbia in corso un programma di trattamento di dipendenze da sostanze che sia costretto ad interrompere il programma di recupero per essere incarcerato e, successivamente, con grave danno, riprenderlo solo dopo l’accoglimento dell’istanza da parte del Tribunale di sorveglianza.
Mentre in altri sistemi si ritiene che l’esecuzione della pena, anche detentiva, abbia natura semplicemente amministrativa, in Italia si è ritenuta necessaria la sua piena giurisdizionalizzazione. Il Magistrato di Sorveglianza, pertanto, svolge le sue funzioni nel settore penale e, temporalmente, dopo che la sentenza di condanna è stata pronunciata irrevocabilmente. La sua attività è dunque regolata dal diritto dell’esecuzione penale e dal diritto penitenziario.
Questo orientamento rigoroso è improntato alla massima garanzia dei diritti dei detenuti e ispirato dall’esigenza di rispettare integralmente il dettato costituzionale che riconosce alla pena un ruolo di risocializzazione.
Inoltre, il Magistrato di Sorveglianza decide le istanze di esonero dai relativi pagamenti formulate dai condannati che riferiscono di versare in condizioni economiche disagiate e di non poter pagare le spese del loro processo (c.d. spese processuali), oltre alle spese di mantenimento in carcere.
Le funzioni del Magistrato di sorveglianza si distinguono da quelle attribuite al Tribunale di Sorveglianza. Quest’ultimo è l’organo collegiale della magistratura di sorveglianza, competente sulle questioni più delicate in tema di esecuzione penale e giudice di secondo grado relativamente alle decisioni del Magistrato di Sorveglianza, che, in quest’ultimo caso, non potrà personalmente comporre il collegio per evidenti ragioni di incompatibilità. Nel collegio sono presenti, oltre a due Magistrati di Sorveglianza – uno dei quali presiede il collegio stesso – anche due componenti esperti, nominati tra sociologi, psicologi, criminologi, medici, quali figure che potranno fornire il loro contributo professionale per la decisione da assumere, con particolare riferimento all’accertamento della pericolosità sociale del reo. Al Tribunale di Sorveglianza è demandata la facoltà di decidere la più opportuna modalità di esecuzione della pena in tutti i suoi risvolti e declinazioni, obbedendo al precetto sancito dall’art.27, comma 3 della Costituzione, secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (oggi si suole dire, non a torto, che il grado di civiltà di un popolo si misura alla stregua del senso di umanità che accompagna l’esecuzione delle pene). La pena di cui parliamo non è solo quella detentiva, bensì anche quella pecuniaria.
In particolare, il Tribunale di Sorveglianza deciderà le istanze, di liberi e detenuti, in merito all’eventuale concessione di pene alternative alla detenzione, preso atto, se sussistenti, dei provvedimenti provvisori ed urgenti adottati dal Magistrato di Sorveglianza.
Detenzione domiciliare
E’ una pena (diversamente dagli arresti domiciliari che rientrano nel novero delle misure cautelari disposte prima dell’emissione di una sentenza definitiva di condanna) altermativa alla detenzione in carcere. Si auspica nella prassi una sua applicazione sempre più estesa, in omaggio al principio, cardine dell’odierna esecuzione penale, che la detenzione in carcere debba costituire l’extrema ratio della pretesa punitiva dello Stato. Nella più recente declinazione dell’esecuzione penale, la detenzione domiciliare è vista con favore, da un lato perché consente di evitare il sovraffollamento carcerario, d’altro lato perché evita il contagio criminale che spesso ha luogo negli istituti di pena. Inoltre, in una visione della pena meno orientata all’afflittività punitiva e più incline al recupero sociale, il radicamento familiare del reo e il supporto affettivo delle persone care può rivelarsi decisivo nel favorire un percorso risocializzativo. La detenzione domiciliare consiste nell’esecuzione della pena entro il perimetro della propria abitazone (terrazze e giardini di proprietà compresi) o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con la stessa convivente, di case famiglia protette.
Chi la concede? – Se l’esecuzione della pena è già iniziata, la misura è concessa su richiesta del detenuto (anche personale, ovvero sottoscritta dal diretto interessato senza l’assistenza di un difensore) dal tribunale di sorveglianza del luogo ove il richiedente è detenuto (il magistrato di sorveglianza provvede provvisoriamente, in attesa della decisione del tribunale, nel caso di grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione).
Se l’esecuzione della pena non è iniziata, nei casi previsti dall’art.656 c.p.p. c.5, (pena da scontare, anche residua, non superiore ad anni quattro – così la norma a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale) il pubblico ministero la sospende. L’ordine di esecuzione della pena ed il contestuale decreto di sospensione sono notificati al condannato ancora in libertà che entro trenta giorni può presentare presso gli uffici della procura che ha emesso l’ordine di esecuzione in parola l’ istanza di concessione della pena alternativa (affidamento in prova/detenzione domiciliare). L’istanza, corredata dalla prova della disponibilità di un alloggio (rogito d’acquisto, contratto di locazione ovvero dichiarazione di disponibilità all’ospitalità di un terzo soggetto) viene dunque trasmessa dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza del luogo di residenza del richiedente che dovrà decidere entro quarantacinque giorni dal ricevimento (termine solo indicativo e non perentorio, d’altra parte quasi mai rispettato).
Il tribunale di sorveglianza, nell’accogliere l’istanza, fissa le prescrizioni della misura e può anche prevedere modalità di controllo con mezzi elettronici (c.d. braccialetto elettronico consistente, in realtà, in una cavigliera).
Il detenuto domiciliare non è a carico dell’Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l’assistenza medica.
Vediamo ora nel dettaglio le varie ipotesi e tipologie di detenzione domiciliare.
Detenzione domiciliare ordinaria (art. 47- ter l. 354/1975)
Chi può chiederla:
- La persona che abbia compiuto i settanta anni di età e sia stata condannata per qualunque reato ad eccezione di quelli previsti:
- dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I ( riduzone in schiavitù, tratta di schiavi ed altri reati contro la personalità individuale);
- dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale (reati sessuali in varie declinazioni);
- dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (associazione a delinquere, sequestro di persona etc);
- dall’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario (reati associativi di stampo mafioso);
- Chiunque non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne’ gli sia mai stata applicata l’aggravante di cui all’articolo 99 del codice penale (recidiva), nelle ipotesi che seguono:
- debba scontare una condanna all’arresto o una pena detentiva anche residua inferiore a quattro anni e sia:
- donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente;
- padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole (c. d. legge mammo). Per impossibilità assoluta della madre s’intende grave nocumento alla salute o esigenze lavorative con trasferte in luoghi significativamente distanti dal domicilio ove dimora la prole;
- persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia
- persona di età superiore a sessanta anni, se inabile, anche parzialmente;
- Chi deve scontare una pena anche residua inferiore ai due anni, anche in difetto dei requisiti richiesti dal punto 1 ma purché non sia stato condannato per uno dei reati previsti dall’art. 4-bis ord. penit. quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati (si tratta dell’ipotesi di ordine generale più frequente nella prassi);
- debba scontare una condanna all’arresto o una pena detentiva anche residua inferiore a quattro anni e sia:
Detenzione domiciliare speciale ( art.47- quinquies l. 354/1975)
Prevista dall’art. 47 quinquies, la misura alternativa della detenzione domiciliare speciale è stata introdotta dall’art. 3 della legge di modifica dell’ordinamento penitenziario 8 marzo 2001 n. 40.
Con tale beneficio si è voluto consentire alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura ed all’assistenza dei figli.
La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, quando non ricorrono le condizioni di cui all’articolo 47-ter (pena inferiore ai 4 anni), solo se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.
Vi possono essere ammessi, se hanno espiato almeno un terzo della pena, o almeno 15 anni in caso di condanna all’ergastolo:
- la madre di bambini di età inferiore ad anni dieci, con lei conviventi;
- il padre quando la madre sia deceduta o altrimenti nell’impossibilità assoluta di assistere i figli (ut supra).
La legge 62/2011 ne ha esteso l’efficacia introducendo il comma 1-bis all’art. 47-quinquies che consente l’espiazione dei minimi di pena richiesti per accedere al beneficio ( un terzo della pena complessiva o 15 anni in caso di ergastolo) presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all’assistenza dei figli. In caso di impossibilità di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo’ essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. Tale possibilità resta comunque preclusa alle madri condannate per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis o.p.
Detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria (47-quater introdotto nel corpo della l. 354/1975 )
Con l’inserimento dell’art. 47-quater nel corpo della l. 354/1975 ad opera della l. 231/1999, il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell’articolo 286-bis, comma 2 del codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell’assistenza ai casi di aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (affidamento in prova al servizio sociale) e 47-ter (detenzione domiciliare), anche oltre i limiti di pena ivi previsti. La norma persegue altresì la finalità di evitare, in carceri sovraffollati, un esteso contagio.
Detenzione domiciliare per pene non superiori a diciotto mesi (l. 199/2010)
Introdotta dalla l. 199/2010, tale fattispecie di detenzione domiciliare ha subito successive modifiche concernenti il limite di pena. Inizialmente prevista per una durata di tempo limitata al 31 dicembre 2013, è stata stabilizzata dal dl 23 dicembre 2013 n. 146.
Ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore a diciotto mesi, può essere concessa anche d’ufficio direttamente dal Magistrato di sorveglianza, se non vi ostano gravi motivi, la possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione o in un altro luogo, pubblico o privato di cura, assistenza ed accoglienza.
La misura non può essere concessa:
- ai condannati per reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario);
- ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale);
- ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge sull’ordinamento penitenziario);
- qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti;
- qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso (si pensi al padre accusato di maltrattamenti in famiglia ove chieda di scontare la pena presso la casa familiare).
Nel caso la condanna a diciotto mesi – o meno – di reclusione sia comminata a una persona in libertà, è lo stesso pubblico ministero che, al momento della predisposizione del titolo esecutivo, ne sospende l’esecuzione, previo accertamento dell’esistenza e dell’idoneità dell’alloggio.
Nel caso in cui il condannato, con pena da scontare fino a diciotto mesi, sia in carcere, potrà presentare una richiesta direttamente al magistrato di sorveglianza (la cui decisione è di certo molto più rapida di quella che potrebbe adottare il Tribunale di sorveglianza). In ogni caso – anche senza la richiesta dell’interessato – la direzione dell’istituto di pena preparerà per ciascun detenuto che rientri nelle condizioni previste dalla legge una relazione sul comportamento tenuto durante la detenzione e sulla idoneità dell’alloggio.
Il magistrato di sorveglianza provvederà con un’ordinanza per la concessione della detenzione domiciliare.
In ogni caso, il magistrato di sorveglianza può imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per accertare che il tossicodipendente o l’alcoldipendente inizi immediatamente o prosegua il programma terapeutico.
L’ufficio locale dell’esecuzione penale esterna, competente per gli interventi di sostegno e controllo, segnala ogni evento rilevante sull’esecuzione della pena e trasmette le relazioni trimestrali e quella conclusiva.
La l. 199/2010, in caso di evasione dalla detenzione domiciliare (art. 385 codice penale), ha inasprito le pene portandole da un minimo di un anno di reclusione ad un massimo di tre (fino a cinque se vi sono violenza o effrazione, fino a sei se il reato è stato consumato con uso di armi).
L’avvocato richiesto dal proprio assistito, libero o detenuto, di fare istanza di detenzione domiciliare dovrà informare il cliente della delicatezza di tale scelta. Infatti se il reo, ammesso alla detenzione domiciliare, sarà sorpreso dalle forze dell’ordine fuori dal domicilio indicato all’atto della concessione della pena alternativa senza preventiva autorizzazione potrà essere arrestato in flagranza del reato di evasione. Inoltre, se interverrà una condanna in sede di conseguente giudizio per direttissima, questa sarà ostativa alla concessione del medesimo beneficio in futuro.
La detenzione domiciliare impone autocontrollo, disciplina e predisposizione alla sottoposizione a regole e restrizioni. Altrimenti diverrà un’occasione mancata, anzi una vera sciagura portatrice di guai peggiori.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 17.10.2022 dei decreti attuativi della c.d. riforma Cartabia, il Giudice della cognizione (vale a dire il giudice del processo che pronuncia la condanna dell’imputato) potrà applicare, per le pene fino a quattro anni, la sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare. La “nuova” detenzione domiciliare sostitutiva comporta l’obbligo di: “rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunità o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso il condannato può lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice”.