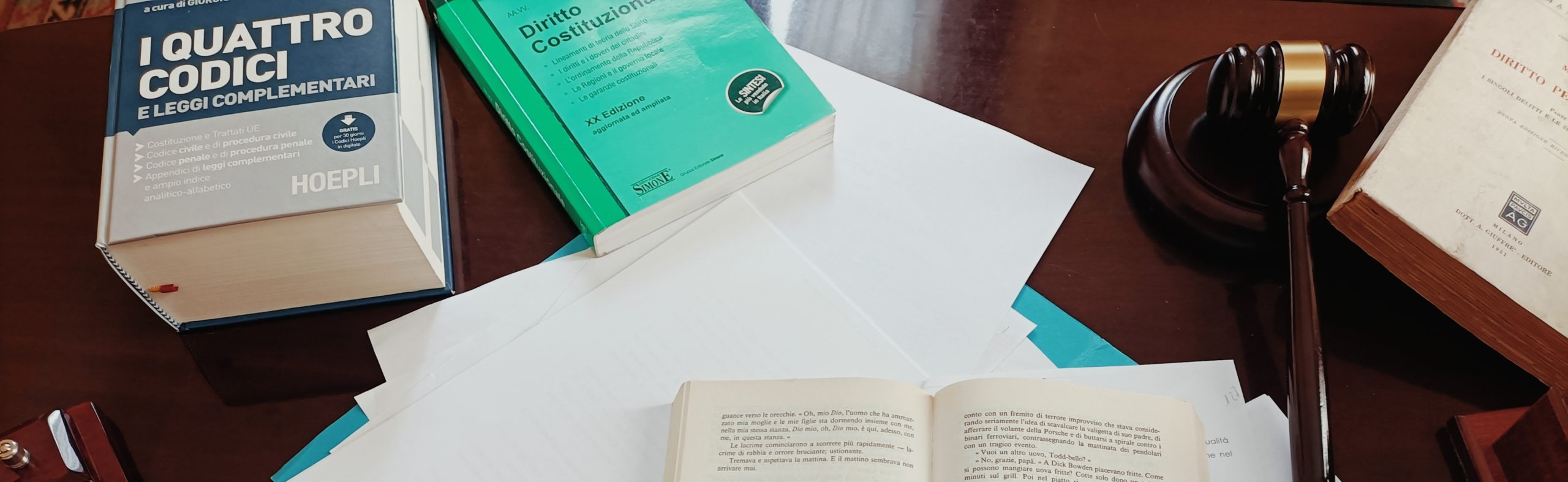Diritto processuale penale
L’imputato sagace tace e rimane contumace… ma non sempre…
La tazzina di caffè scottava tra le dita, al solito tavolino del bar sotto casa, quando mio zio Arturo mi chiamò al cellulare.
Non lo dimenticherò mai: era il primo di Febbraio, faceva freddo benché il sole trafiggesse i vetri ed io ero stretto nel mio giubbotto blu. Ancora non lo sapevo, ma un’ora dopo avrei varcato, per la prima volta in vita mia, il severo portone del carcere di San Vittore.
«Scusami tanto Ale, ma ho un’emergenza terribile. Devi andarci tu a San Vittore, all’interrogatorio di garanzia di Aliprandi».
Aliprandi era uno dei principali clienti dello studio Arturo Battaglia, quello per cui lavoravo da fedele nipote: era un imprenditore senza scrupoli, ma abilissimo ad uscire sempre indenne da una ben assortita serie di reati societari e prontissimo a saldare le esose parcello di mio zio, che considerava un compagno di viaggio irrinunciabile.
Ricordo che, fissando il display del cellulare, avevo sbuffato a pieni polmoni tutta la mia rassegnazione. «Un’emergenza, zio…ma certo…». Li conoscevo bene gli stravaganti imprevisti di mio zio e già immaginavo il mio unico parente di sesso maschile rimasto in famiglia allungare una banconota al botteghino, sul lungolario Trento, per comprare due biglietti di andata e ritorno per il traghetto delle otto e trenta, da Como all’isola Comacina, uno per se e uno per lei, Michela, la sua fidanzatina delle medie, la più pretenziosa delle amanti, l’unica a cui lui permettesse d’essere gelosa di sua moglie.
«Ti ricordi, vero, quello che ti ho insegnato sull’interrogatorio? L’imputato sagace tace e rimane contumace. In altre parole: muto come un pesce!». Quando citava questi motti, ch’erano il suo marchio di fabbrica, mio zio inalberava d’improvviso quel tono saggio, da persona responsabile, addirittura da maestro di vita.
«Certo che lo ricordo!».
In effetti, come dimenticare gli enfatici principi che zio Arturo declamava dal pulpito della sua poltrona imbottita davanti alla libreria? Ero nel suo studio legale da pochi minuti, ancora con la bottiglia di spumante alle labbra, subito dopo che il presidente della commissione d’esame mi aveva stretto la mano, con le parole più irrealistiche del mondo: «Lei è furbo. Sarà un buon avvocato». Mio zio mi aveva afferrato le spalle, con le sue manone da contadino mancato, puntandomi addosso due occhi accesi come fanali dal suo delirio di onnipotenza intellettuale e, così ho sempre sospettato, da un pizzico di polvere bianca. «L’imputato, all’interrogatorio, non deve rispondere MAI. L’imputato sagace tace e rimane contumace, ricordalo sempre. Dice una parola sbagliata? ZAC…è rovinato per tutta la vita! Dice una parola a sua difesa? In questo mondo di forcaioli e giustizialisti nessuno gli crederà mai. La gente pensa subito: chi sarebbe così stupido da autoaccusarsi? E’ come se l’avversario conoscesse le carte che hai in mano e tu non avessi una identica fortuna. Sarebbe come giocare una partita di calcio irregolare in cui puoi solo subire goal ma in cui ti è impedito di farne. Brutto affare, non credi?».
Come non credergli? Soprattutto per me, un giovinastro senza la minima esperienza di vita, ancora a digiuno di processi e che aveva assistito agli interrogatori di polizia solo davanti allo schermo della tv. Sapevo solo che la luce abbagliante di una lampada da tavolo, puntata in faccia all’interrogato, era un’invenzione cinematografica e che rispondere alle domande di un poliziotto o di un magistrato, conoscendo a mala pena le accuse del pubblico ministero, era da stupidi e da presuntuosi.
Arrivai davanti al portone di San Vittore tutto affannato, dopo avere corso senza sosta dalla fermata della metropolitana di Sant’Agostino, per essere puntuale al mio primo appuntamento con la giustizia penale, e senza la più pallida idea di quale pulsante dovessi schiacciare per farmi aprire.
Il piantone dell’ufficio matricola, col suo sguardo torvo, ci mise due minuti buoni a confrontare i mie capelli biondi tutti arruffati, i miei occhi malinconici ed il mio viso pallido e magro col faccione esultante d’illusioni che campeggiava al centro del tesserino plastificato d’iscrizione all’ordine degli avvocati di Milano. Poi fece un ruvido cenno ad un collega e quello si sollevò dalla poltroncina con le molle rotte, sopra la quale aveva sprofondato la sua pesante mole, per guidarmi su per una ripida scala di ferro, che somigliava ad una via di fuga in caso d’incendio.
Mi fecero entrare subito nella stanzetta del magistrato, una giovane donna dai capelli ricci che era intenta a collegare fili ad un computer e che non mi degnò neppure di uno sguardo.
Aliprandi mi aspettava in giacca e cravatta, ritto come un fusto, e, con quel sorriso enigmatico che gli spuntava da sotto i baffoni bianchi. Non aveva certo l’aria contrita e timorosa del detenuto. Tra i due il più titubante ed insicuro ero di certo io, d’altra parte questa è la mia specialità: sentirmi a disagio in ogni situazione, con l’aggravante incendiaria della totale incapacità di fingere. Credo che questa candida impotenza sia ciò che più apprezza di me Claudia, la mia fidanzata, forse perché riesce a farmi fare tutto ciò che vuole, anche guidare fino a San Benedetto del Tronto, avanti ed indietro in giornata, solo per una mangiata di pesce sulla spiaggia con la sua amica del cuore: Doris.
Ad Aliprandi non ci fu bisogno di sussurrare alcunché. Fu lui a prendere l’iniziativa e a posarmi una mano sul braccio, crollando il capo di lato ed invitandomi a sedere sul fondo della stanza, a debita distanza dal Giudice. «Ovviamente mi avvalgo della facoltà di non rispondere!».
Mi limitai ad annuire. «Ovviamente».
«Dobbiamo aspettare che l’accusa scopra le sue carte. Scommetto che non hanno niente in mano, solo una decina di fatture che ritengono sospette. Proveranno a dimostrare che sono relative ad operazioni inesistenti. Il mio commercialista non l’hanno ancora sentito, è importante che tuo zio si tenga in contatto con lui». Proseguì, con l’aria di chi la sa lunga. «Noi sfrutteremo il contropiede. Non voglio fare dichiarazioni al buio».
Ero d’accordo e recitai la mia inutile lezione. «L’interrogatorio è una garanzia per l’indagato. Non può diventare una trappola mortale. Condivido il suo silenzio, Signor Aliprandi».
Lui mi batté una mano sulla spalla. «Mi chiami Roberto. Io e suo zio ci conosciamo dai tempi del liceo. Quando sarò uscito di qui vi porterò a mangiare pesce nel miglior ristorante di Milano».
Mi sfuggì un sorriso gelido, perché sapevo bene che dare troppa confidenza ai clienti era un po’ come accettare, da bambini, le caramelle dagli sconosciuti.
La verbalizzazione richiese poco più di cinque minuti, giusto il tempo di dare atto che Roberto Aliprandi, proprietario di una villa sul lago di Como ed allo stato ancora incensurato, non avrebbe risposto alle domande, ed il giudice non sollevò neppure gli occhi dal computer.
Mentre Aliprandi lasciava la stanza, con aria da gran signore, il Giudice per le indagini preliminari, quello che prima del processo deve decidere se mantenere in vigore la misura cautelare a carico degli indagati, mi rivolse uno sguardo implacabile. «Avvocato Mayer, lei deve fermarsi per il prossimo arrestato. Deve sostituire il difensore di fiducia che non riesce a venire. Per oggi la nomino d’ufficio, ex articolo 97 quarto comma».
Mi sentii gelare i polsi. Non potevo rifiutare, ero come in gabbia con le mie paure come uniche compagne di cella.
Il ruolo del difensore d’ufficio, che pure ricoprivo da un paio di mesi, essendo iscritto all’apposita lista, mi era sempre parso scomodo, dal momento che l’imputato spesso non capisce d’essere in dovere di pagare un avvocato che non ha scelto e nominato di propria iniziativa e, d’altra parte, i doveri professionali che ti trovi ad adempere non differiscono in nulla da quelli di un difensore di fiducia lautamente remunerato. In altre parole, l’imputato è portato a confondere il difensore d’ufficio con la gratuità dell’assistenza, quasi fosse un medico del pronto soccorso che è tenuto per legge a salvargli la vita.
Il malcapitato che la sorte mi aveva affidato era un uomo di circa quaranta anni, basso ed incassato nelle spalle, in tuta verde e con la barba incolta.
Si chiamava Alfredo Esposito, era nato a Napoli e si guardava attorno con l’aria incerta di chi fatica a realizzare in quale luogo si trovi. Era raggomitolato su una sedia d’angolo e sembrava incarnare l’esatto opposto di Aliprandi. Trovai la forza di chiedere al giudice di «…poter conferire brevemente col mio assistito». Quando ci fummo seduti in una saletta separata, gli mitragliai in faccia la filastrocca imparata dallo zio. «…l’imputato sagace tace e rimane contumace. Una parola sbagliata e ZAC, è la fine. E’ come giocare una partita di calcio in cui esiste solo la tua porta, quella in cui puoi subire goal. L’altra neppure esiste …». Mi sorpresi di come risultavo credibile, persino autorevole, dall’alto della mia insospettabile, anche se solo apparente, conoscenza del diritto.
Il Signor Esposito mi guardava atterrito, a bocca aperta, come assistesse alle scene più truculente di un film dell’orrore, in balia delle parole che ascoltava. «Maronna lu carmine….veramente?….allora devo starmene zitto. Mi avvalgo della facoltà…certo che mi avvalgo. Ma io non ho fatto niente…lo giuro, avvocà…». Tentò di dirmi altro, ma io gli feci segno di tacere, poiché ogni parola fuori luogo rischiava di compromettere la sua situazione. Stringeva i pugni, con le lacrime finte di chi si professa innocente per tentare la sorte, sperando di pescare la carta giusta. Almeno così sembrò a me.
Nell’istante preciso in cui la verbalizzazione aveva inizio, col cancelliere che digitava le prime parole sulla tastiera del pc, nella stanzetta fece irruzione un uomo alto e grigio di capelli, col piglio del padrone di casa ed un borsone stracolmo di carte stretto nella mano destra. «Chiedo scusa del ritardo, Signor Giudice. Sono l’Avvocato Piazza, difensore di fiducia del signor Esposito». Sventolò la fotocopia di due biglietti aerei. «Il Signor Esposito è del tutto estraneo ai fatti. Il giorno della rapina era a Napoli e questi biglietti ne sono la prova inconfutabile. Ovviamente in sede d’interrogatorio chiariremo tutto e io chiederò la revoca della misura cautelare». Poi mi rivolse uno sguardo bonario ed affranto. «Grazie collega. Spero di non averti fatto perdere troppo tempo. A buon rendere».
Il giudice, allora, sollevò verso di me due occhi inespressivi. «Avvocato Mayer, lei può andare».
Era capitato tutto troppo in fretta perché potessi essere davvero padrone di me stesso o solo accorgermi della secchiata di acqua gelida che il mondo della giustizia rovesciava addosso alle mie prime velleità professionali.
Blaterai senza convinzione uno striminzito «buongiorno», a testa bassa, ma nessuno si degnò di rispodermi ed io pensai che quella indifferenza dopo tutto me la meritavo.
Allora mi decisi a scivolare, furtivo come un’ombra, fuori da quella camera di tortura di tutte mie sterili ambizioni.
Prima che riuscissi a varcare la soglia, il Signor Esposito ebbe un sussulto e parole senza suono mi colpirono alla schiena come pugnalate «Avvocà, non mi avete fatto neanche parlare. Siete proprio ‘nu strunzo».
Interrogatorio
Si tratta di un atto della procedura penale che viene comunemente definito quale esercizio di “diritto di autodifesa” e può essere svolto: dal pubblico ministero, direttamente o per sua delega da ufficiali di polizia giudiziaria; dal giudice (più spesso dal giudice per le indagini preliminari) anche in sede di convalida di arresto; infine, nell’udienza preliminare dal GUP.
L’art. 64 c.p.p. prevede che le dichiarazioni, in sede di interrogatorio, potranno essere rese dall’indagato, libero nella persona, solo se costui decida spontaneamente di farle, avendo l’indagato, viceversa, diritto inviolabile al silenzio. Nell’espletamento dell’interrogatorio, non possono essere utilizzati mezzi o tecniche idonee ad incidere sulla libertà di autodeterminazione dell’indagato o suscettibili di alterarne la capacità di ricordare i fatti (per ovvie esigenze di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali dell’individuo).
In omaggio al principio “nemo tenetur se detegere” (grossolanamente traducibile con l’espressione: nessuno può essere costretto a danneggiarsi) nell’espletamento dell’interrogatorio, l’indagato non ha l’obbligo di dire la verità sui fatti oggetto d’indagine ma solo sulla propria identità e su eventuali procedimenti penali o pregresse condanne a proprio carico. Tuttavia risponde del reato di calunnia se, per discolparsi, scientemente incolpa falsamente dei medesimi fatti un terzo soggetto, anche estraneo all’indagine (il reato di calunnia implica la conoscenza dell’estraneità al fatto di colui che viene incolpato, quindi il dolo della falsa accusa).
L’interrogatorio è un atto proprio delle indagini preliminari in quanto in sede di processo l’imputato potrà eventualmente essere sottoposto, se lo vorrà, con le medesime garanzie ed alle medesime condizioni, ad esame delle parti ex art. 208 c.p.p. L’esame sarà reso dall’imputato, che intenda sottoporvisi, (a richiesta propria o delle altre parti) a seguito dell’audizione dei testi di PM e parte civile e prima dell’escussione dei testi della difesa. Così come l’indagato in sede di interrogatorio, anche l’imputato in sede di esame potrà avvalersi della facoltà di non rispondere, ma il suo silenzio non potrà impedire il proseguimento delle indagini, nel primo caso, e del giudizio, nel secondo caso.
L’art. 64 c.p.p. stabilisce le regole generali e le cautele da osservare all’atto dell’assunzione dell’interrogatorio. In particolare, al comma tre, si prevede che, pena l’inutilizzabilità delle dichiarazioni, l’interrogato debba essere avvertito: del fatto che le dichiarazioni che renderà potranno anche essere usate contro di lui; della facoltà di non rispondere e del fatto che anche in tal caso le indagini proseguiranno; del fatto che, se renderà dichiarazioni circa la responsabilità di terze persone, in relazione a dette dichiarazioni, potrà essere tenuto a rendere testimonianza in un futuro e separato processo (in quest’ultimo caso con un proceso dovere di rispondere alle domande e di rispondere secondo verità).
Interrogatorio di garanzia
L’interrogatorio di garanzia è un adempimento che il giudice è tenuto a compiere, nell’esclusivo interesse dell’indagato e al solo fine di consentirgli di rendere dichiarazioni a proprio discarico, quando applichi una misura coercitiva o restrittiva della libertà personale a carico dell’indagato stesso. L’istituto è dunque finalizzato al rispetto del diritto di difesa e di conoscenza dell’addebito in relazione al quale si è raggiunti da un provvedimento restrittivo della libertà personale Si tratta di un momento fondamentale del procedimento cautelare penale, in quanto rappresenta il primo contatto che la persona sottoposta a misura cautelare ha con il giudice, a garanzia del più ampio diritto di difesa.
L’interrogatorio di garanzia è disciplinato dall’articolo 294 del codice di procedura penale.
Il giudice competente a disporre e condurre l’interrogatorio di garanzia è quello che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare su richiesta del PM. Dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, tuttavia, quando la misura è disposta dalla corte d’assise o dal tribunale, all’interrogatorio deve procedere il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.
Se l’interrogatorio deve essere assunto nella circoscrizione di un altro tribunale, infine, il giudice (o il presidente nel caso di organo collegiale) che non ritenga di procedervi personalmente può delegare l’incombente al giudice per le indagini preliminari del luogo. L’interrogatorio di garanzia è sottoposto a termini temporali ben precisi che sono di massimo cinque giorni dall’esecuzione della custodia in caso di custodia cautelare in carcere e di massimo dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione con riferimento a tutte le altre misure cautelari, sia coercitive che interdittive. Se il pubblico ministero ne fa espressa istanza nella richiesta di custodia cautelare, l’interrogatorio della persona sottoposta a tale misura deve invece avvenire entro il termine di quarantotto ore.
La stringenza dei detti termini è garanzia del fatto che l’indagato non possa essere privato a lungo della libertà personale senza avere avuto l’occasione di rendere dichiarazioni o a produrre documentazione a propria discolpa.
Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporta la perdita di efficacia della misura cautelare e la rimessione in libertà di colui che frattanto vi sia stato sottoposto. Le predette tempistiche non si applicano, per ovvie ragioni, al caso in cui il giudice, che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare, abbia proceduto all’interrogatorio nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto.
L’interrogatorio di garanzia rappresenta un diriritto indefettibile dell’indagato poiché gli consente di rendere dichiarazioni o produrre documenti idonei a dimostrare l’insussistenza, a proprio carico, delle esigenze di applicazione di una misura cautelare o di fugare i gravi indizi di colpevolezza.
In punto di interrogatorio di garanzia, lo scopo della c.d. Riforma Cartabia è quello di garantire:“massimo livello di documentazione per le prove dichiarative e per gli interrogatori tenuti fuori udienza”. Così in caso di interrogatorio di garanzia di un soggetto non detenuto, il nuovo comma 6 bis dell’art. 294 c.p.p., sulla falsariga dell’art. 141 bis c.p.p., prevede la videoregistrazione come ordinario strumento di documentazione, e in ragione del minor grado di costrizione dell’interrogato in punto di libertà personale, consente il ricorso alla fonoregistrazione “in caso di indisponibilità delle apparecchiature”.
Il consiglio pratico che solitamente si fornisce a coloro che si trovino ad assistere un indagato in occasione di un interrogatorio è quello di suggerire all’assistito di avvalersi della facoltà di non rispondere, poiché la parola dell’interrogato potrebbe essere contraddetta da documenti o da altri elementi investigativi coperti dal segreto ed idonei a smentire la credibilità del dichiarante. Le dichiarazioni rese dall’indagato sono “fatte al buio”, senza conoscere nel dettaglio il materiale investigativo in possesso degli inquirenti e rischiano di essere una carta giocata affrettatamente, contro un avversario che non si è ancora esposto con una propria mossa.
Giudice per le indagini preliminari (GIP)
Il giudice per le indagini preliminari (GIP, per brevità, nel gergo forense) è un attore protagonista del procedimento penale italiano, istituito a seguito della radicale riforma del processo penale del 1988 (DPR 22.09.1988 n. 447), in sostituzione della precedente figura del giudice istruttore. Interviene, in determinate e specifiche occasioni, nella fase delle indagini preliminari (le indagini preliminari rappresentano una fase predibattimentale del procedimento. Ciò significa che necessariamente precedono un processo che si appalesa, in quel momento, puramente eventuale). Previste e disciplinate dal codice di procedura penale italiano all’art. 326, le indagini preliminari hanno una durata massima di sei mesi per le contravvenzioni, di un anno per i delitti in genere, di un anno e mezzo per i gravi reati previsti dall’art. 407 comma II c.p. I suddetti termini sono prorogabili, a richiesta motivata del pubblico ministero per una sola volta e per massimo di sei mesi in ragione unicamente della particolare complessità delle indagini (così la c.d. riforma Cartabia che ha innovato la previgente disposizione che prevedeva come durata massima delle indagini preliminari: sei mesi, un anno per i reati ex art. 407 comma II c.p.p, prorogabili di sei mesi a richiesta del pubblico ministero per giusta causa e, successivamente, solo per particolare complessità delle indagini o per oggettiva impossibilità di concluderle nel termine). Sono coperte da segreto investigativo per gli atti compiuti durante la loro pendenza e possono concludersi alternativamente, a scelta del pubblico ministero, che ne è titolare, con la richiesta di archiviazione della notizia di reato per infondatezza dell’ipotesi accusatoria o con l’esercizio dell’azione penale, con conseguente richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato o con la notifica di decreto di citazione diretta a giudizio. Concluse le indagini preliminari, il PM quando “gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca…” (art. 408 comma 1 a seguito della CD Riforma Cartabia ) notifica all’indagato l’avviso di conclusione delle indagni preliminari (art. 415 bis c.p.p.). Con tale avviso il PM informa l’indagato della facoltà, entro il ventesimo giorno successivo alla notifica, di richiedere d’essere sottoposto ad interrogatorio, di rendere spontanee dichiarazioni, di indicare persone informate sui fatti a discarico, di depositare una memoria e produrre documenti. Mentre in caso di richiesta da parte dell’indagato di interrogatorio il PM è vincolato a fissarlo, viceversa in caso di indicazione di fonti di prova a discarico il PM può ritenere superflua l’ulteriore indagine suggerita e rigettare la richiesta, anche semplicemente omettendo di darvi seguito. L’istituto delle indagini preliminari fu, anch’esso, introdotto con la riforma della giustizia penale dell’anno 1988.
Il giudice per le indagini preliminari non ha autonomi poteri di iniziativa probatoria (a differenza del giudice istruttore, che ne era titolare), ma provvede solo su istanza di parte (cosiddetta giurisdizione semipiena); i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge (vige infatti il principio di tassatività). Il GIP è anche privo di un proprio fascicolo processuale, a differenza del giudice dibattimentale, che ne ha a disposizione uno dedicato. Gli atti conosciuti dal giudice per le indagini preliminari sono solo quelli che il pubblico ministero sceglie di allegare alle istanze che presenta. A mero titolo esemplificativo, unitamente alla richiesta di emissione di un’ordinanza cautelare a carico dell’indagato (vedi infra a proposito delle misure cautelari), il pubblico ministero allega gli atti che ritiene necessari o utili al fine della affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato ovvero delle esigenze cautelari. Nella selezione di tali atti/documenti è riconosciuta al P.M. una facoltà di scelta; il p.m., tuttavia, deve trasmettere al GIP tutti gli elementi, acquisiti nel corso delle indagini, che depongano in senso favorevole all’indagato (questo principio è posto a tutela dei diritti di tutti coloro che, nel segreto talvolta più assoluto delle stanze della procura e della polizia giudiziaria, vengono sottoposti ad investigazioni a loro insaputa). Le funzioni attribuite al giudice per le indagini preliminari sono preordinate a garantire l’indagato stesso, nella fase durante la quale più attuale è il pericolo di abusi a suo danno, ovvero proprio durante le indagini preliminari coperte da segreto. Fra i provvedimenti più significativi che il GIP è chiamato ad emettere vi è, come già detto, l’ordinanza di applicazione di una misura cautelare su richiesta del pubblico ministero.
Il GIP, altresì, accoglie, o rigetta, con decreto, la richiesta di archiviazione della notizia di reato avanzata dal pubblico ministero (art. 409 c.p.p.), nonché la richiesta di autorizzazione e la successiva convalida dei mezzi di ricerca della prova delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti (artt. 266, 266-bis e 267 c.p.p.). In caso di opposizione alla richiesta di archiviazione da parte della persona offesa (art.410 c.p.p.), il GIP può dichiarare l’opposizione inammissibile, perché immotivata o perché non si precisa quale sarebbe l’indagine supplettiva richiesta, e con decreto disporre l’archiviazione e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero. Oppure può ritenere ammissibile l’opposizione e fissare per la discussione nel merito l’udienza in camera di consiglio (art.127 c.p.p.). A seguito dell’udienza, il GIP può comunque disporre con ordinanza l’archiviazione della notizia di reato, oppure, sempre con ordinanza, ordinare lo svolgimento di ulteriori indagini (generalmente quelle suggerite dalla persona offesa con l’opposizione), o ancora può obbligare il P.M. all’esercizio dell’azione penale (c.d. imputazione coatta). Il GIP è, inoltre, competente, prima della fissazione dell’udienza preliminare (poiché in quest’ultima ipotesi provvede il GUP) a giudicare il procedimento in sede di riti speciali tra cui: il rito abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento), il decreto penale di condanna (artt. 438 e ss.ti c.p.p.). L’ordinamento giudiziario riserva l’esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari ai magistrati che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni di giudice del dibattimento, con possibilità di deroga soltanto per imprescindibili e straordinarie esigenze di servizio.
Il ruolo del Giudice per le indagini preliminari è assai delicato, dovendo egli garantire equilibrio alle dinamiche delle investigazioni, allo scopo di evitare abusi di potere ed arbitrii che possano comportare la violazione dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, spesso a loro insaputa, nelle indagini preliminari.
Misure cautelari
Le misure cautelari sono temporanee restrizioni della libertà personale, disposte, a carico di indagati o imputati, con provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria nel periodo intercorrente tra l’inizio del procedimento penale (acquisizione della notizia di reato) e l’emanazione della sentenza definitiva. Rappresentano un’eccezione al principio, caposaldo della giustizia penale, secondo il quale si è presunti innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, e come tali debbono essere disposte con rigore e prudenza, una volta verificata con scrupolo la sussistenza delle condizioni di applicabilità (come vedremo: gravi indizi di colpevolezza e sussistenza di esigenze cautelari a carico del destinatario).
Le misure cautelari vengono applicate, dunque, in via eccezionale e con ordinanza motivata dall’autorità giudiziaria per scongiurare uno dei seguenti concreti pericoli;
- difficoltà nell’accertamento del reato (c.d. pericolo di inquinamento probatorio);
- difficoltà nell’esecuzione della sentenza (c.d. pericolo di fuga dell’indagato/imputato);
- concreta possibilità che, in libertà, vengano compiuti dall’indagato o imputato altri reati o che si aggravino le conseguenze del reato già commesso (c.d. pericolo di reiterazione della condotta criminosa).
Le misure cautelari possono essere disposte ed applicate solo ove sussistano a carico del destinatario altresì gravi indizi di colpevolezza, ovvero ove si imponga la formulazione di una prognosi sfavorevole circa l’ipotesi assolutoria (probababilità, e non mera e generica possibilità, di condanna penale).
Le ordinanze cautelari presentano talune peculiari caratteristiche:
- sono strumentali al procedimento penale, poiché mirano, nel quadro di una vicenda processuale denotata da una certa gravità, ad evitare che si concretino i summenzionati pericoli;
- per le medesime ragioni sono anche provvedimenti urgenti, ovvero non differibili nella loro esecuzione, pena il rischio di inquinamento probatorio, fuga dell’indagato/imputato ovvero di reiterazione della condotta criminosa da parte di costui;
- sono incidentali, in quanto è necessaria la pendenza di un procedimento penale nel corpo del quale innestare il provvedimento cautelare (vengono meno con la definizione del procedimento penale);
- allo stato degli atti deve sussistere una prognosi di colpevolezza a carico dell’indagato/imputato (c.d. gravi indizi di colpevolezza).
Tale prognosi, però, in ossequio al perentorio disposto dell’art. 27 Cost., comma II, deve essere formulata alla luce del principio di presunzione di innocenza fino alla definitività della sentenza, quindi con particolare rigore;
- Sono provvedimenti immediatamente esecutivi, sebbene provvisori;
- Provvisori, inquanto, oltre a venire meno con l’emissione della sentenza definitiva, possono essere revocati o modificati al modificarsi della valutazione di sussistenza delle condizioni di applicabilità;
- sono impugnabili nei modi, nelle forme e nel rispetto dei termini previsti dal codice di procedura penale (riesame, appello e ricorso per Cassazione);
- sono espressamente tipizzate dalla legge;
- infine le misure cautelari possono essere disposte solo con un provvedimento del giudice (da qui la giurisdizionalità delle stesse).
Vi sono diversi tipi di misure cautelari: personali (titolo I, artt. 272-315 c.p.p.) e reali (titolo II, artt. 316-325 c.p.p.).
Le misure cautelari personali, destinate a porre limiti e vincoli all’esercizio dei diritti, per l’appunto, “personali” si distinguono in
- coercitive (artt. 280-286 c.p.p.), che limitano alcune libertà fondamentali dell’individuo (con particolare riferimento alla libertà di movimento);
- interdittive (artt. 287-290 c.p.p.) che incidono su alcune facoltà del soggetto in merito all’esercizio di diritti e
- misure di sicurezza, che vengono applicate temporalmente con scopi cautelari, sulla scorta della sussistenza di una pericolosità sociale dell’indagato/imputato.
Le misure cautelari coercitive, a loro volta, si suddividono in obbligatorie e custodiali: le prime, evidentemente meno afflittive, comprendono il divieto di espatrio, il divieto o l’obbligo di dimora, l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, l’allontanamento dalla casa familiare; le seconde, invece, sono la custodia cautelare in carcere, gli arresti domiciliari, la custodia cautelare in luogo di cura.
Va detto che la misura cautelare della custodia in carcere, certamente tra tutte la più afflittiva, è da ritenersi l’extrema ratio della difesa penale. Ciò significa che essa va applicata solo ove ogni altra misura meno afflittiva (arresti domiciliari, obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria etc) si riveli inidonea ed inefficace al fine contenitivo cui tende.
Le misure cautelari interdittive impongono la sospensione dell’esercizio di un pubblico ufficio o servizio, la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori (per reati commessi in ambito familiare), il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali (in relazione ad imputazioni per reati di natura commerciale).
Le misure di sicurezza, viceversa, vengono applicate provvisoriamente in determinati casi tassativavamente previsti dalla legge allo scopo di contenere una conclamata pericolosità sociale dell’indagato. Si cita, a mero titolo esemplificativo, la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico per soggetto affetto da totale vizio di mente ed incline al reato.
Le misure cautelari reali, invece, impediscono il compimento di atti dispositivi relativi a determinati beni o cose (incidendo sull’aspetto patrimoniale delle persone sottoposte alla loro esecuzione) e si distinguono nel sequestro conservativo (art. 316 c.p.p.) e nel sequestro preventivo (art. 321 c.p.p.). Con quest’ultime misure non deve essere confuso il sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p. che è un provvedimento adottato dal pubblico ministero.
Il sequestro conservativo tende a garantire alla vittima del reato un equo risarcimento del danno, congelando i beni rientranti nel patrimonio dell’indagato/imputato, impedendo che questi se ne liberi cedendoli a terze persone, spesso con atti simulati di vendita o donazione, onde sottrarli a futuri eventuali pignoramenti.
Il sequestro preventivo colpisce cose che si sospetta possano essere utilizzate per perpetrare nuovi reati. E’ un provvedimento cautelare che protegge la collettività dal pericolo degli effetti di un reato o della perpetrazione di future condotte criminose (si pensi, a mero titolo esemplificativo, al sequestro di un’arma propria o impropria ovvero di sostanza stupefacente o di moneta falsa etc).
Viceversa il sequestro probatorio tende a scongiurare il pericolo della perdita / alterazione / contaminazione di luoghi od oggetti costituenti fonte di prova della colpevolezza degli autori del reato per il cui accertamento si procede.
Ricorso avverso misura cautelare: Il riesame, l’appello ed il ricorso per Cassazione, rappresentano i rimedi contro i provvedimenti che dispongono le misure cautelari personali, meglio conosciuti come mezzi d’impugnazione. Contro le misure cautelari sono previsti dei rimedi specifici connotati da una autonoma disciplina. Trattasi dei mezzi d’impugnazione di cui sopra. In questa sede verranno considerati i tre istituti in modo singolo, anche alla luce della legge n. 47/2015 che ha apportato delle modifiche, in particolare circa la disciplina dei termini del riesame e dell’appello.
- Il rimedio del riesame è disciplinato all’articolo 309 del codice di procedura penale, e a proporlo possono essere l’imputato o il suo avvocato difensore. Il riesame rappresenta un’impugnazione dell’ordinanza che applica una misura cautelare coercitiva.
Va depositato presso la cancelleria del tribunale del luogo nel quale ha sede la corte d’appello nel cui distretto è stata emessa l’ordinanza, denominato tribunale del riesame, a pena di decadenza entro il termine perentorio dieci giorni dall’esecuzione o dalla notificazione del provvedimento applicativo della misura avversata (i due momenti dell’esecuzione e della notifica spesso coincidono). Il riesame non può essere proposto se la misura cautelare personale dovesse essere disposta dopo l’appello del Pubblico Ministero. La proposizione del riesame determina, in capo al collegio giudicante, l’onere di una complessiva rivalutazione della sussistenza a carico del richiedente dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, perché ha un effetto devolutivo integrale. Per quanto concerne il ricorso per il riesame (anche alla luce del termine brevissimo per la sua proposizione: solo dieci giorni) non si ritiene necessario che, nel corpo dell’atto, vengano enucleati gli specifici motivi d’impugnazione. Essi motivi, così come quelli aggiunti dopo la proposizione del ricorso, possono essere declinati e messi a verbale in udienza, prima che inizi la discussione.
Il tribunale del riesame, al quale è devoluto il compito di confermare, annullare o riformare il provvedimento impugnato, verifica se siano ancora sussistenti ed attuali le condizioni di applicabilità della misura. E’ altresì previsto che il giudice del riesame, al quale non vengono riconosciuti poteri istruttori, si possa avvalere, ai fini di una ponderata decisione, del materiale a lui trasmesso a norma del comma 5 dell’articolo 309 del codice di procedura penale, costituente il fondamento della richiesta cautelare, nochè di quello prodotto su iniziativa delle parti.
La legge n. 47/2015 introduce delle modifiche di rilievo al procedimento del riesame. Il richiedente ha diritto di comparire all’udienza, che si svolge in camera di consiglio, innanzi al Tribunale in composizione collegiale. Il giudice del riesame può annullare l’ordinanza che ha disposto la misura se il giudice che l’ha emessa non ha provveduto a motivarla congruamente.
Su richiesta del ricorrente, se ricorrono giustificati motivi, è possibile differire l’udienza camerale sino a dieci giorni. Sono anche previsti dei termini stringenti per la trasmissione degli atti, l’emanazione ed il deposito in cancelleria dell’ordinanza che decide il riesame, a pena d’inefficacia, senza possibilità di rinnovo, dell’ordinanza che dispone la misura cautelare. L’ordinanza del tribunale del riesame deve essere depositata entro trenta giorni dal giorno della decisione. Il termine può essere prorogato di altri quindici giorni se la motivazione risulti molto complessa.
Il mezzo di impugnazione dell’appello cautelare è disciplinato all’art. 310 del codice di procedura penale.
Può essere proposto dal Pubblico Ministero se la sua richiesta di misura cautelare è stata respinta, dall’imputato e dal suo avvocato difensore se dovesse essere applicata una misura interdittiva, oppure se dovesse essere rigettata una richiesta di revoca, modifica, estinzione o sostituzione di una misura cautelare.
L’appello al Tribunale del riesame deve essere proposto avverso ordinanze relative alle misure cautelari personali, quando non è previsto lo specifico rimedio del riesame.
Trattandosi di un vero e proprio atto d’appello, si ha l’onere di specifica e puntuale enucleazione dei motivi su cui l’impugnazione si fonda. Tuttavia questo onere di enucleazione delle specifiche doglianze non esenta il tribunale del riesame, dall’esaminare anche i capi dell’ordinanza impugnata che appaiano legati in modo indissolubile ai motivi indicati, sempre che i profili sottesi possano essere rilevati d’ufficio.
Anche in relazione all’appello, la legge n. 47/2015 ha apportato modifiche sui termini processuali.
Il tribunale deve decidere l’appello entro venti giorni dal dì in cui ha ricevuto gli atti.
Il deposito del provvedimento collegiale, a sua volta, deve avvenire entro trenta giorni dal dì della decisione. Quest’ultimo termine può essere prorogato a quarantacinque giornj se la motivazione appaia molto complessa.
Il ricorso per Cassazione in materia cautelare e di status libertatis è disciplinato all’articolo 311 del codice di procedura penale.
Hanno facoltà di proporre il ricorso alla Suprema Corte: il Pubblico Ministero che ha chiesto l’applicazione della misura cautelate; l’imputato ed il suo avvocato difensore, con riferimento alle ordinanze del tribunale emesse in virtù del riesame o dell’appello.
Il ricorso deve essere presentato entro dieci giorni dal giorno della comunicazione o dal giorno della notifica dell’avviso di deposito del provvedimento da impugnare.
Gli stringenti e tassativi motivi del ricorso, limitati alla violazione di legge o al difetto di motivazione, determinano una cognizione, in capo alla Suprema Corte di Cassazione, incentrata
- sulla congruità logico-giuridica della motivazione
- Su difetto di deliberato circa una doglianza che è stata resa oggetto del riesame o dell’appello
- In relazione a profili di travisamento della prova,.
Il comma 2 dell’articolo 311 del codice di procedura penale, dedicato al ricorso per saltum, prevede la possibilità per l’imputato di rinunciare al riesame e di adire direttamente la Suprema Corte di Cassazione.
Se, su ricorso dell’imputato, la Suprema Corte dovesse annullare con rinvio un’ordinanza con la quale era stata disposta una misura cautelare, e se il giudice del rinvio non dovesse decidere entro dieci giorni dal dì della ricezione degli atti ovvero non dovesse depositare in cancelleria il provvedimento entro trenta giorni dal dì della decisione, la misura coercitiva perderebbe efficacia.
La sentenza 22 novembre 2017 n. 53203 della Cassazione penale ha interpretato la legge 103/2017, che ha modificato gli articoli 571 e 613 del codice di procedura penale, disponendo che il ricorso in Cassazione contro le misure cautelari possa ancora essere esperito personalmente dall’imputato, a differenza degli altri casi, nei quali questa facoltà è riservata agli avvocati difensori iscritti all’albo dei patrocinanti presso la suprema corte di Cassazione.
Indagato
Con il termine indagato si indica la persona sottoposta alle indagini o, in altri termini, la persona nei cui confronti si svolgono indagini in ordine ad una ipotesi di reato che non si è ancora concretizzata in una formale imputazione.
Lo status di persona sottoposta alle indagini può riconoscersi fin dal momento in cui perviene alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero una notizia qualificata di reato, in forza della quale vengano svolte indagini soggettivamente orientate (Rivello). Nel momento in cui al pubblico ministero perviene dalla polizia giudiziaria, da altro pubblico ufficiale o da un privato una notizia di reato, o nel momento in cui il pubblico ministero l’acquisisce di propria iniziativa, lo stesso deve provvedere ad iscrivere immediatamente tale notizia in un apposito registro custodito presso gli uffici della procura della Repubblica territorialmente competente (generalmente il locus commissi delicti), detto registro delle notizie di reato (Il nome della persona va iscritto non appena risultino “indizi” a suo carico ex art. 335 comma 1-bis introdiotto con la recente riforma della giustizia). L’iscrizione ha una funzione meramente cognitiva e non costitutiva della qualifica di indagato (Corte cost. 7 luglio 2005, n. 307): “Essa vale solamente a determinare una formalizzazione della individuazione dell’indagato, ad ufficializzare, quell’insieme di elementi, di fatti conoscitivi, di indizi che fanno convergere le indagini sulla persona medesima” (Giarda-Spangher).
La persona sottoposta alle indagini, il cui nome sia stato iscritto nel registro delle notizie di reato, ben può non essere a conoscenza del procedimento a suo carico, in quanto le attività di indagine sono normalmente coperte da segreto (art. 329 c.p.p.). Onde appurare la propria eventuale iscrizione nel registro degli indagati ciascuna persona può fare, ex art. 335 c.p.p., apposita domanda di visura del registro, relativamente al proprio nominativo, allegando copia fotostatica del proprio documento d’identità presso i competenti uffici della Procura della Repubblica. Pertanto, a meno che non venga disposta una misura cautelare o pre-cautelare, o vi sia richiesta di proroga delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero (art. 406 c.p.p.), le stesse possono concludersi senza che l’indagato ne abbia contezza. Solo quando debbono essere compiuti atti di indagine ai quali il difensore dell’indagato ha diritto di assistere (artt. 360, 364 e 365 c.p.p., c.d. atti garantiti), il pubblico ministero ha l’obbligo di informare l’indagato che nei suoi confronti è pendente un procedimento penale, mediante l’invio dell’informazione di garanzia, contenente una indicazione sommaria dell’addebito e l’invito a nominare un difensore di fiducia (art. 369 c.p.p.). Sono atti garantiti: l’interrogatorio (artt. 64 e 65 c.p.p.), l’ispezione, il confronto (art. 364 c.p.p.) e gli accertamenti tecnici irripetibili che riguardano persone cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione (art. 360 c.p.p.) (si pensi, a mero titolo esemplificativo, alla rilevazione delle tracce di frenata sull’asfalto nel contesto di indagini relative ad omicidio stradale).
L’informazione di garanzia rappresenta quindi per l’indagato l’atto con il quale egli apprende formalmente di essere sottoposto ad indagini. La persona sottoposta alle indagini deve essere informata anche del proprio diritto di difesa (art. 369-bis c.p.p.). Poiché nel corso delle indagini preliminari l’indagato può essere sottoposto ad atti investigativi suscettibili di successiva utilizzazione probatoria o subire restrizioni della libertà personale, allo stesso sono estese tutte le norme previste nell’interesse dell’imputato, sia quelle inerenti alla libertà personale e di autodeterminazione, sia tutte quelle relative in generale al diritto di difesa. Quanto sopra è sancito dall’art. 61 c.p.p. il quale estende all’indagato tutti i diritti e le garanzie dell’imputato e ogni altra disposizione relativa all’imputato, salvo che sia diversamente stabilito (artt. dal 61 al 73 c.p.p.).
La qualità di indagato permane sino alla chiusura delle indagini preliminari o sino a quando non intervengano fatti estintivi della stessa. Si riacquista la qualifica di indagato con il decreto del giudice che autorizza la riapertura delle indagini dopo l’archiviazione (art. 414 c.p.p.) o con l’ordinanza di riapertura delle indagini a seguito di revoca della sentenza di non luogo a procedere (art. 436, comma 2, c.p.p.).
Difensore di fiducia
E’ il difensore, iscritto presso uno degli albi degli avvocati, che l’indagato/imputato sceglie per la propria miglior tutela processuale, sulla base di un rapporto di fiducia o perché ritiene abbia le competenze necessarie a svolgere il mandato nel migliore dei modi. Secondo l’art. 96 del Codice di procedura penale, l’indagato/imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia. La nomina è fatta con dichiarazione resa all’autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata (al di là del rigore letterale della norma ad oggi, come è facile comprendere, il mezzo più utilizzato per il deposito dell’atto di nomina è la pec) . La nomina del difensore di fiducia della persona fermata [307, 384 c.p.p.], arrestata [380, 381 c.p.p.] o in custodia cautelare [284, 285, 286 c.p.p.], finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto, nelle forme previste dal comma 2 del citato articolo (ciò poiché alla persona detenuta può risultare difficoltoso l’esercizio del diritto di scelta del difensore più idoneo ad occuparsi del suo caso).
Nomina d’ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p.
Il difensore d’ufficio è un avvocato, iscritto nelle apposite liste sulla base di una propria richiesta e dichiarazione di disponibilità, il cui ruolo è quello di svolgere la funzione di rappresentante processuale di soggetti, sprovvisti di difensore di fiducia, che siano indagati o imputati in procedimenti penali Viene designato, per l’appunto d’ufficio, tra gli appartenenti alle predette liste/elenchi formate presso i consigli dell’ordine degli avvocati. L’imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. Questo principio è funzionale al precetto relativo alla obbligatorietà di difesa tecnica nei procedimenti penali (diritto irrinunciabile dal predetto interessato cui è preclusa la facoltà di difendersi da solo). In effetti il diritto alla difesa in giudizio è ritenuto valore non negoziabile e principio cardine di un ordinamento realmente garantista.
I Consigli dell’ordine circondariali di ciascun distretto di Corte d’appello predispongono, mediante un apposito ufficio centralizzato, l’elenco dei professionisti iscritti all’albo e facenti parte dell’elenco nazionale ai fini della nomina a difensore d’ufficio su richiesta dell’autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria. Il Consiglio nazionale forense fissa, con cadenza annuale, i criteri generali per la nomina dei difensori d’ufficio sulla base della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità.
Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l’assistenza del difensore e la persona sottoposta alle indagini o l’imputato ne sono privi, danno avviso dell’atto al difensore d’ufficio il cui nominativo è comunicato dall’ufficio competente.
Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 dell’art. 97 c.p.p. non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa, il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 102 c.p.p.. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all’ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell’urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato solo un difensore iscritto nell’elenco di cui al comma 2.Il difensore di ufficio ha l’obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.
Infine va detto che il difensore d’ufficio ha il diritto di essere remunerato dal proprio assistito, salvo il caso che quest’ultimo sia stato ammesso al patrocinio a spese dello stato.